
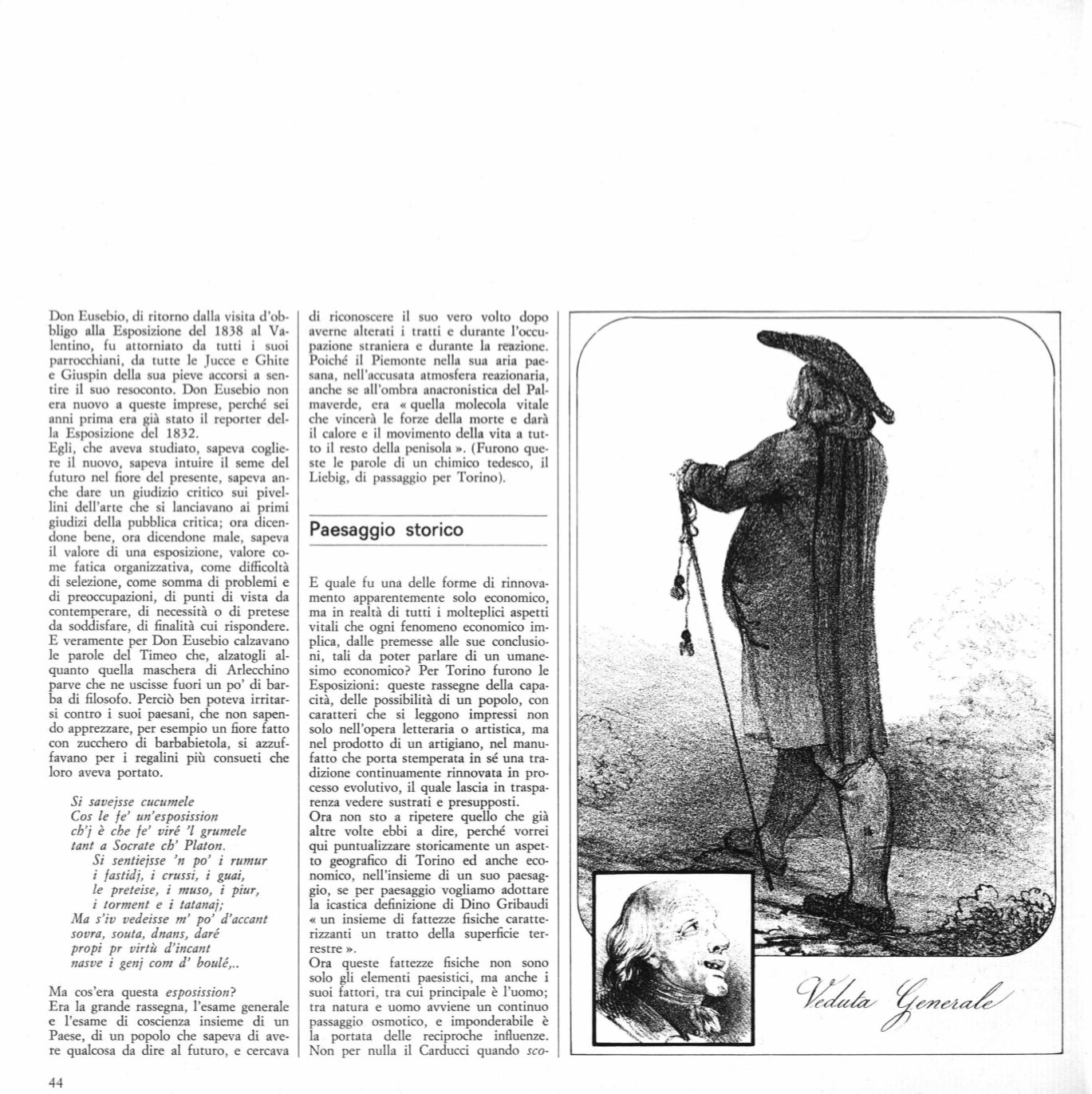
Don Eusebio, di ritorno dalla visita d'ob–
bligo alla Esposizione del 1838 al Va–
lentino, fu attorniato da tutti i suoi
parrocchiani, da tutte le Jucce e Ghite
e Giuspin della sua pieve accorsi a sen–
tire
il
suò resoconto. Don Eusebio non
era nuovo a queste imprese, perché sei
anni prima era già stato
il
reporter del–
la Esposizione del 1832.
Egli, che aveva studiato, sapeva coglie–
re
il
nuovo, sapeva intuire il seme del
futuro nel fiore del presente, sapeva an–
che dare un giudizio critico sui pivel–
lini dell'arte che si lanciavano ai primi
giudizi della pubblica critica; ora dicen–
done bene, ora dicendone male, sapeva
il valore di una esposizione, valore co–
me fatica organizzativa, come difficoltà
di selezione, come somma di problemi e
di preoccupazioni, di punti di vista da
contemperare, di necessità o di pretese
da soddisfare, di finalità cui rispondere.
E veramente per Don Eusebio calzavano
le parole del Timeo che, alzatogli al–
quanto quella maschera di Arlecchino
parve che ne uscisse fuori un po' di bar–
ba di filosofo. Perciò ben poteva irritar–
si contro i suoi paesani, che non sapen–
do apprezzare, per esempio un fiore fatto
con zucchero di barbabietola, si azzuf–
favano per i regalini più consueti che
loro aveva portato.
Si savejsse cucumele
Cos le fe' un'esposission
ch'i è che fe' viré 'l grumele
tant a Socrate ch' Platon.
Si sentiejsse 'n po'
i
rumur
i fastidj, i crussi, i guai,
le preteise, i muso, i piur,
i torment e i tatanaj;
Ma s'iv vedeisse m' po' d'accant
sovra, souta, dna/H, daré
propi pr virtù d'incant
nasve i geni com d' boulé,..
Ma cos'era questa
esposission?
Era la grande rassegna, l'esame generale
e l'esame
di
coscienza insieme di un
Paese, di un popolo che sapeva di ave–
re qualcosa da dire al futuro, e cercava
44
di nconoscere
il
suo vero volto dopo
averne alterati i tratti e durante l'occu–
pazione straniera e durante la reazione.
Poiché
il
Piemonte nella sua aria pae–
sana, nell'accusata atmosfera reazionaria,
anche se all'ombra anacronistica del Pal–
maverde, era «quella molecola vitale
che vincerà le forze della morte e darà
il
calore e
il
movimento della vita a tut–
to
il
resto della penisola
».
(Furono que–
ste le parole di un chimico tedesco,
il
Liebig, di passaggio per Torino).
Paesaggio storico
E quale fu una delle forme di rinnova–
mento apparentemente solo economico,
ma in realtà di tutti i molteplici aspetti
vitali che ogni fenomeno economico im–
plica, dalle premesse alle sue conclusio–
ni, tali da poter parlare di un umane–
simo economico? Per Torino furono le
Esposizioni: queste rassegne della capa–
cità, delle possibilità di un popolo, con
caratteri che si leggono impressi non
solo nell'opera letteraria o artistica, ma
nel prodotto di un artigiano, nel manu–
fatto che porta stemperata in sé una tra–
dizione continuamente rinnovata in pro–
cesso evolutivo, il quale lascia in traspa–
renza vedere sustrati e presupposti.
Ora non sto a ripetere quello che già
altre volte ebbi a dire, perché vorrei
qui puntualizzare storicamente un aspet–
to geografico di Torino ed anche eco–
nomico, nell'insieme di un suo paesag–
gio, se per paesaggio vogliamo adottare
la icastica definizione di Dino Gribaudi
«un insieme di fattezze fisiche caratte–
rizzanti un tratto della superficie ter–
restre
».
Ora queste fattezze fisiche non sono
solo gli elementi paesistici, ma anche i
suoi fattori, tra cui principale è l'uomo;
tra natura e uomo avviene un continuo
passaggio osmotico, e imponderabile è
la portata delle reciproche influenze.
Non per nulla
il
Carducci quando
sco-


















