
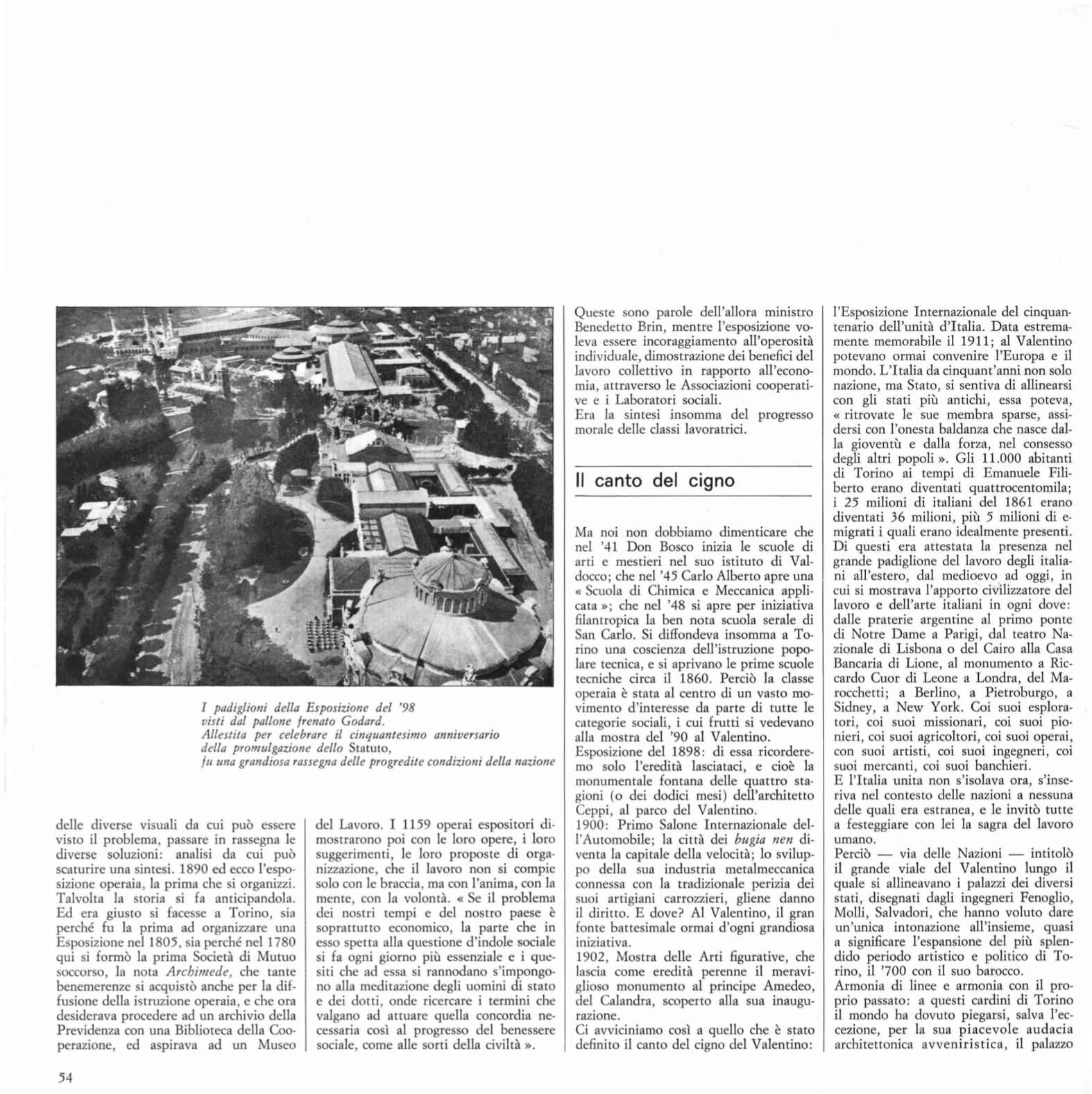
I padiglioni della Esposizione del '98
visti dal pallone frenato Godard.
Allestita per celebrare il cinquantesimo anniversario
della promulgazione dello
Statuto,
fu una grandiosa rassegna delle progredite condizioni della nazione
delle diverse visuali da cui può essere
visto il problema, passare in rassegna le
diverse soluzioni: analisi da cui può
scaturire una sintesi. 1890 ed ecco l'espo–
sizione operaia, la prima che si organizzi.
Talvolta la storia si fa anticipandola .
Ed era giusto si facesse a Torino, sia
perché fu la prima ad organizzare una
Esposizione nel 1805, sia perché nel 1780
qui si formò la prima Società di Mutuo
soccorso, la nota
Archimede,
che tante
benemerenze si acquistò anche per la dif–
fusione della istruzione operaia, e che ora
desiderava procedere ad un archivio della
Previdenza con una Biblioteca della Coo–
perazione, ed aspirava ad un Museo
54
del Lavoro . I 1159 operai espositori di–
mostrarono poi con le loro opere, i loro
suggerimenti, le loro proposte di orga–
nizzazione, che
il
lavoro non si compie
solo con le braccia, ma con l'anima, con la
mente, con la volontà. « Se
il
problema
dei nostri tempi e del nostro paese è
soprattutto economico, la parte che in
esso spetta alla questione d'indole sociale
si fa ogni giorno più essenziale e i que–
siti che ad essa si rannodano s'impongo–
no alla meditazione degli uomini di stato
e dei dotti, onde ricercare i termini che
valgano ad attuare quella concordia ne–
cessaria così al progresso del benessere
sociale, come alle sorti della civiltà
».
Queste sono parole dell'allora mInIstro
Benedetto Brin, mentre l'esposizione vo–
leva essere incoraggiamento all'operosità
individuale, dimostrazione dei benefici del
lavoro collettivo in rapporto all'econo–
mia, attraverso le Associazioni cooperati–
ve e i Laboratori sociali.
Era la sintesi insomma del progresso
morale delle classi lavoratrici.
Il canto del cigno
Ma noi non dobbiamo dimenticare che
nel '41 Don Bosco inizia le scuole di
arti e mestieri nel suo istituto di Val–
docco; che nel '45 Carlo Alberto apre una
« Scuola di Chimica e Meccanica appli–
cata
»;
che nel '48 si apre per iniziativa
filantropica la ben nota scuola serale di
San Carlo. Si diffondeva insomma a To–
rino una coscienza dell'istruzione popo–
lare tecnica, e si aprivano le prime scuole
tecniche circa
il
1860. Perciò la classe
operaia è stata al centro di un vasto mo–
vimento d'interesse da parte di tutte le
categorie sociali, i cui frutti si vedevano
alla mostra del '90 al Valentino.
Esposizione del 1898: di essa ricordere–
mo solo l'eredità lasciataci, e cioè la
monumentale fontana delle quattro sta–
gioni (o dei dodici mesi) dell'architetto
Ceppi, al parco del Valentino.
1900 : Primo Salone Internazionale del–
l'Automobile; la città dei
bugia nen
di–
venta la capitale della velocità; lo svilup–
po della sua industria metalmeccanica
connessa con la tradizionale perizia dei
suoi artigiani carrozzieri, gliene danno
il diritto. E dove? Al Valentino, il gran
fonte battesimale ormai d'ogni grandiosa
iniziativa.
1902, Mostra delle Arti figurative, che
lascia come eredità perenne il meravi–
glioso monumento al principe Amedeo,
del Calandra, scoperto alla sua inaugu–
razione.
Ci avviciniamo così a quello che è stato
definito
il
canto del cigno del Valentino:
l'Esposizione Internazionale del cinquan–
tenario dell'unità d'Italia. Data estrema–
mente memorabile il 1911; al Valentino
potevano ormai convenire l'Europa e il
mondo. L'Italia da cinquant'anni non solo
nazione, ma Stato, si sentiva di allinearsi
con gli stati più antichi, essa poteva,
«ritrovate le sue membra sparse, assi–
dersi con l'onesta baldanza che nasce dal–
la gioventù e dalla forza, nel consesso
degli altri popoli
».
Gli 11.000 abitanti
di Torino ai tempi di Emanuele Fili–
berto erano diventati quattrocentomila;
i 25 milioni di italiani del 1861 erano
diventati 36 milioni, più 5 milioni di e–
migrati i quali erano idealmente presenti.
Di questi era attestata la presenza nel
grande padiglione del lavoro degli italia–
ni all'estero, dal medioevo ad oggi, in
cui si mostrava l'apporto civilizzatore del
lavoro e dell'arte italiani in ogni dove:
dalle praterie argentine al primo ponte
di Notre Dame a Parigi, dal teatro Na–
zionale di Lisbona o del Cairo alla Casa
Bancaria di Lione, al monumento a Ric–
cardo Cuor di Leone a Londra, del Ma–
rocchetti; a Berlino, a Pietroburgo, a
Sidney, a New York. Coi suoi esplora–
tori, coi suoi missionari, coi suoi pio–
nieri, coi suoi agricoltori, coi suoi operai,
con suoi artisti, coi suoi ingegneri, coi
suoi mercanti, coi suoi banchieri.
E l'Italia unita non s'isolava ora, s'inse–
riva nel contesto delle nazioni a nessuna
delle quali era estranea, e le invitò tutte
a festeggiare con lei la sagra del lavoro
umano.
Perciò - via delle Nazioni - intitolò
il
grande viale del Valentino lungo
il
quale si allineavano i palazzi dei diversi
stati, disegnati dagli ingegneri Fenoglio,
Molli, Salvadori, che hanno voluto dare
un'unica intonazione all'insieme, quasi
a significare l'espansione del più splen–
dido periodo artistico e politico di To–
rino, il '700 con il suo barocco.
Armonia di linee e armonia con il pro–
prio passato: a questi cardini di Torino
il mondo ha dovuto piegarsi, salva l'ec–
cezione, per la sua piacevole audacia
architettonica avveniristica, il palazzo


















