
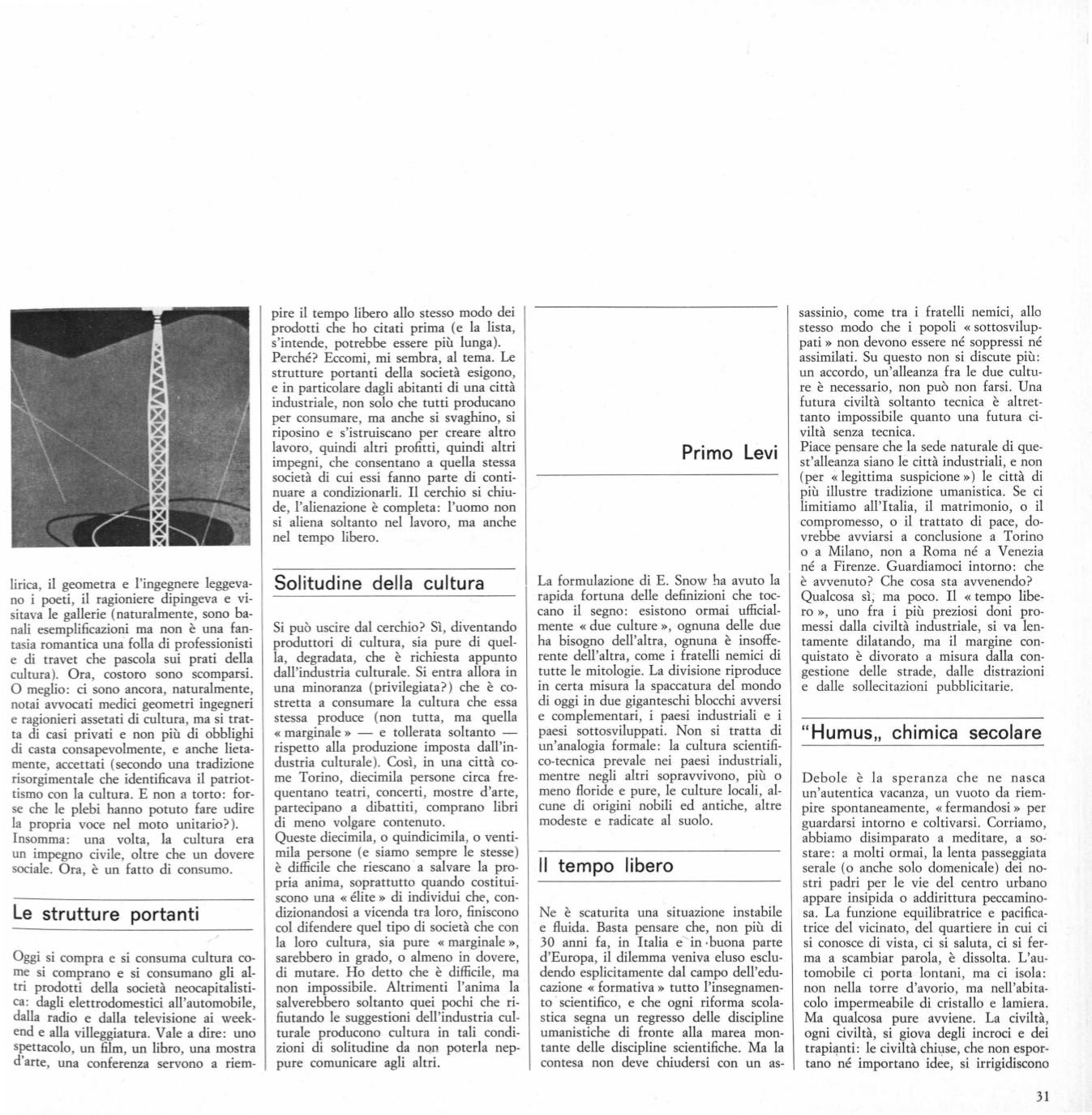
lirica, il geometra e l'ingegnere leggeva–
no i poeti, il ragioniere dipingeva e vi–
sitava le gallerie (naturalmente, sono ba–
nali esemplificazioni ma non è una fan–
tasia romantica una folla di professionisti
e di travet che pascola sui prati della
cultura). Ora, costoro sono scomparsi.
O meglio: ci sono ancora , naturalmente,
notai avvocati medici geometri ingegneri
e ragionieri assetati di cultura, ma si trat–
ta di casi privati e non più di obblighi
di casta consapevolmente, e anche lieta–
mente, accettati (secondo una tradizione
risorgimentale che identificava il patriot–
tismo con la cultura. E non a torto: for–
se che le plebi hanno potuto fare udire
la propria voce nel moto unitario?).
Insomma: una volta, la cultura era
un impegno civile, oltre che un dovere
sociale. Ora,
è
un fatto di consumo.
Le strutture portanti
Oggi si compra e si consuma cultura co–
me si comprano e si consumano gli al–
tri prodotti della società neocapitalisti–
ca: dagli elettrodomestici all'automobile,
dalla radio e dalla televisione ai week–
end e alla villeggiatura. Vale a dire: uno
spettacolo, un film, un libro, una mostra
d'arte, una conferenza servono a riem-
pire il tempo libero allo stesso modo dei
prodotti che ho citati prima (e la lista,
s'intende, potrebbe essere più lunga).
Perché? Eccomi, mi sembra, al tema. Le
strutture portanti della società esigono,
e in particolare dagli abitanti di una città
industriale, non solo che tutti producano
per consumare, ma anche si svaghino, si
riposino e s'istruiscano per creare altro
lavoro, quindi altri profitti, quindi altri
impegni, che consentano a quella stessa
società di cui essi fanno parte di conti–
nuare a condizionarli. Il cerchio si chiu–
de, l'alienazione è completa: l'uomo non
si aliena soltanto nel lavoro, ma anche
nel tempo libero.
Solitudine della cultura
Si può uscire dal cerchio? Sì, diventando
produttori di cultura, sia pure di quel–
la, degradata, che
è
richiesta appunto
dall'industria culturale. Si entra allora in
una minoranza (privilegiata?) che è co–
stretta a consumare la cultura che essa
stessa produce (non tutta, ma quella
« marginale» - e tollerata soltanto -
rispetto alla produzione imposta dall'in–
dustria culturale). Così, in una città co–
me Torino, diecimila persone circa fre–
quentano teatri, concerti, mostre d'arte,
partecipano a dibattiti, comprano libri
di meno volgare contenuto.
Queste diecimila, o quindicimila, o venti–
mila persone (e siamo sempre le stesse)
è
difficile che riescano ' a salvare la pro–
pria anima, soprattutto quando costitui–
scono una «élite» di individui che, con–
dizionandosi a vicenda tra loro, finiscono
col difendere quel tipo di società che con
la loro cultura, sia pure «marginale »,
sarebbero in grado, o almeno in dovere,
di mutare. Ho detto che
è
difficile, ma
non impossibile. Altrimenti l'anima la
salverebbero soltanto quei pochi che ri–
fiutando le suggestioni dell'industria cul–
turale producono cultura in tali condi–
zioni di solitudine da non poterla nep–
pure comunicare agli altri-
Primo Levi
La formulazione di E. Snow ha avuto la
rapida fortuna delle definizioni che toc–
cano il segno: esistono ormai ufficial–
mente « due culture », ognuna delle due
ha bisogno dell'altra, ognuna
è
insoffe–
rente dell'altra, come i fratelli nemici di
tutte le mitologie. La divisione riproduce
in certa misura la spaccatura del mondo
di oggi in due giganteschi blocchi avversi
e complementari, i paesi industriali e i
paesi sottosviluppati. Non si tratta di
un'analogia formale: la cultura scientifi–
co-tecnica prevale nei paesi industriali,
mentre negli altri sopravvivono, più o
meno floride e pure, le culture locali, al–
cune di origini nobili ed antiche, altre
modeste e radicate al suolo.
Il tempo libero
Ne è scaturita una situazione instabile
e fluida. Basta pensare che, non più di
3O anni fa, in I talia e..... in .buona parte
d'Europa, il dilemma veniva eluso esclu–
dendo esplicitamente dal campo dell'edu–
cazione « formativa» tutto l'insegnamen–
to .scientifico, e che ogni riforma scola–
stica segna un regresso delle discipline
umanistiche di fronte alla marea mon–
tante delle discipline scientifiche. Ma la
contesa non deve chiudersi con un as-
sassllllO, come tra i fratelli nemici, allo
stesso modo che i popoli «sottosvilup–
pati » non devono essere né soppressi né
assimilati. Su questo non si discute più:
un accordo, un'alleanza fra le due cultu–
re è necessario, non può non farsi. Una
futura civiltà soltanto tecnica è altret–
tanto impossibile quanto una futura ci–
viltà senza tecnica.
Piace pensare che la sede naturale di que–
st'alleanza siano lè città industriali, e non
(per « legittima suspicione») le città di
più illustre tradizione umanistica. Se ci
limitiamo all'Italia, il matrimonio, o il
compromesso, o il trattato di pace, do–
vrebbe avviarsi a conclusione a Torino
o a Milano, non a Roma né a Venezia
né a Firenze. Guardiamoci intorno: che
è
avvenuto? Che cosa sta avvenendo?
Qualcosa sì; ma poco. Il «tempo libe–
ro », uno fra i più preziosi doni pro–
messi dalla civiltà industriale, si va len–
tamente dilatando, ma il margine con–
quistato
è
divorato a misura dalla con–
gestione delle strade, dalle distrazioni
e dalle sollecitazioni pubblicitarie.
"Humus" chimica secolare
Debole è la speranza che ne nasca
un'autentica vacanza, un vuoto da riem–
pire spontaneamente, «fermandosi» per
guardarsi intorno e coltivarsi. Corriamo,
abbiamo disimparato a meditare, a
so~
stare : a molti ormai, la lenta passeggiata
serale (o anche solo domenicale) dei no–
stri padri per le vie del centro urbano
appare insipida o addirittura peccamino–
sa. La funzione equilibratrice e pacifica–
trice del vicinato, del quartiere in cui ci
si conosce di vista, ci si saluta, ci si fer–
ma a scambiar parola,
è
dissolta. L'au–
tomobile ci porta lontani, ma ci isola:
non nella torre d'avorio, ma nell'abita–
colo impermeabile di cristallo e lamiera.
Ma qualcosa pure avviene. La civiltà,
ogni civiltà, si giova degli incroci e dei
trapi~nti :
le civiltà
chi~se,
che non espor–
tano né importano idee, si irrigidiscono
31


















