
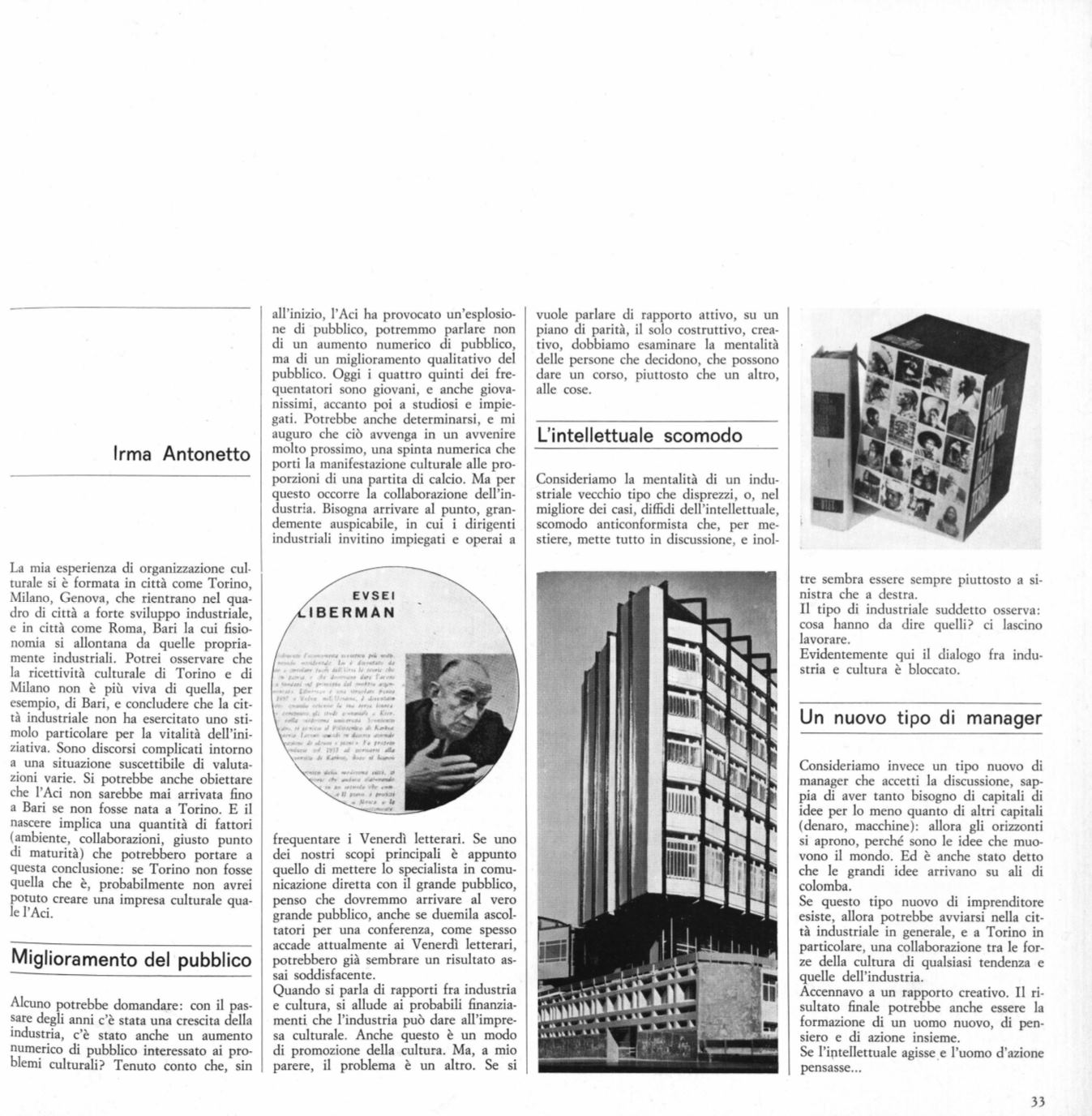
Irma Antonetto
La mia esperienza di organizzazione cul–
turale si è formata in città come Torino,
Milano, Genova, che rientrano nel qua–
dro di città a forte sviluppo industriale,
e in città come Roma, Bari la cui fisio–
nomia si allontana da quelle propria–
mente industriali. Potrei osservare che
la ricettività culturale di Torino e di
Milano non è più viva di quella, per
esempio, di Bari, e concludere che la cit–
tà industriale non ha esercitato uno sti–
molo particolare per la vitalità dell'ini–
ziativa. Sono discorsi complicati intorno
a una situazione suscettibile di valuta–
zioni varie. Si potrebbe anche obiettare
che l'Aci non sarebbe mai arrivata fino
a Bari se non fosse nata a Torino. E il
nascere implica una quantità di fattori
(ambiente, collaborazioni, giusto punto
di maturità) che potrebbero portare a
questa conclusione: se Torino non fosse
quella che è, probabilmente non avrei
potuto creare una impresa culturale qua–
le l'Aci.
Miglioramento del pubblico
Alcuno potrebbe domandare: con il pas–
sare degli anni c'è stata una crescita della
industria, c'è stato anche un aumento
numerico di pubblico interessato ai pro–
blemi culturali? Tenuto conto che, sin
all'inizio, l'Aci ha provocato un'esplosio–
ne di pubblico, potremmo parlare non
di un aumento numerico di pubblico,
ma di un miglioramento qualitativo del
pubblico. Oggi i quattro quinti dei fre–
quentatori sono giovani, e anche giova–
nissimi, accanto poi a studiosi e impie–
gati. Potrebbe anche determinarsi, e mi
auguro che ciò avvenga in un avvenire
molto prossimo, una spinta numerica che
porti la manifestazione culturale alle pro–
porzioni di una partita di calcio. Ma per
questo occorre la collaborazione dell'in–
dustria. Bisogna arrivare al punto, gran–
demente auspicabile, in cui i dirigenti
industriali invitino impiegati e operai a
EVSEI
IBERMAN
frequentare i Venerdì letterari. Se uno
dei nostri scopi principali è appunto
quello di mettere lo specialista in comu–
nicazione diretta con
il
grande pubblico,
penso che dovremmo arrivare al vero
grande pubblico, anche se duemila ascol–
tatori per una conferenza, come spesso
accade attualmente ai Venerdì letterari,
potrebbero già sembrare un risultato as–
sai soddisfacente.
Quando si parla di rapporti fra industria
e cultura, si allude ai probabili finanzia–
menti che l'industria può dare all'impre–
sa culturale. Anche questo è un modo
di promozione della cultura. Ma, a mio
parere,
il
problema è un altro. Se si
vuole parlare di rapporto attivo, su un
piano di parità, il solo costruttivo, crea–
tivo, dobbiamo esaminare la mentalità
delle persone che decidono, che possono
dare un corso, piuttosto che un altro,
alle cose.
L'intellettuale scomodo
Consideriamo la mentalità di un indu–
striale vecchio tipo che disprezzi, o, nel
migliore dei casi, diffidi dell 'intellettuale,
scomodo anticonformista che, per me–
stiere, mette tutto in discussione, e inol-
tre sembra essere sempre piuttosto a si–
nistra che a destra.
Il tipo di industriale suddetto osserva :
cosa hanno da dire quelli? ci lascino
lavorare.
Evidentemente qui il dialogo fra indu–
stria e cultura è bloccato.
Un nuovo tipo di manager
Consideriamo invece un tipo nuovo di
manager che accetti la discussione, sap–
pia di aver tanto bisogno di capitali di
idee per lo meno quanto di altri capitali
(denaro, macchine): allora gli orizzonti
si aprono, perché sono le idee che muo–
vono il mondo. Ed è anche stato detto
che le grandi idee arrivano su ali di
colomba.
Se questo tipo nuovo di imprenditore
esiste, allora potrebbe avviarsi nella cit–
tà industriale in generale, e a Torino in
particolare, una collaborazione tra le for–
ze della cultura di qualsiasi tendenza e
quelle dell'industria.
Accennavo a un rapporto creativo. Il ri–
sultato finale potrebbe anche essere la
formazione di un uomo nuovo, di pen–
siero e di azione insieme.
Se l'iptellettuale agisse ,e l'uomo d'azione
pensasse.. .
33


















