
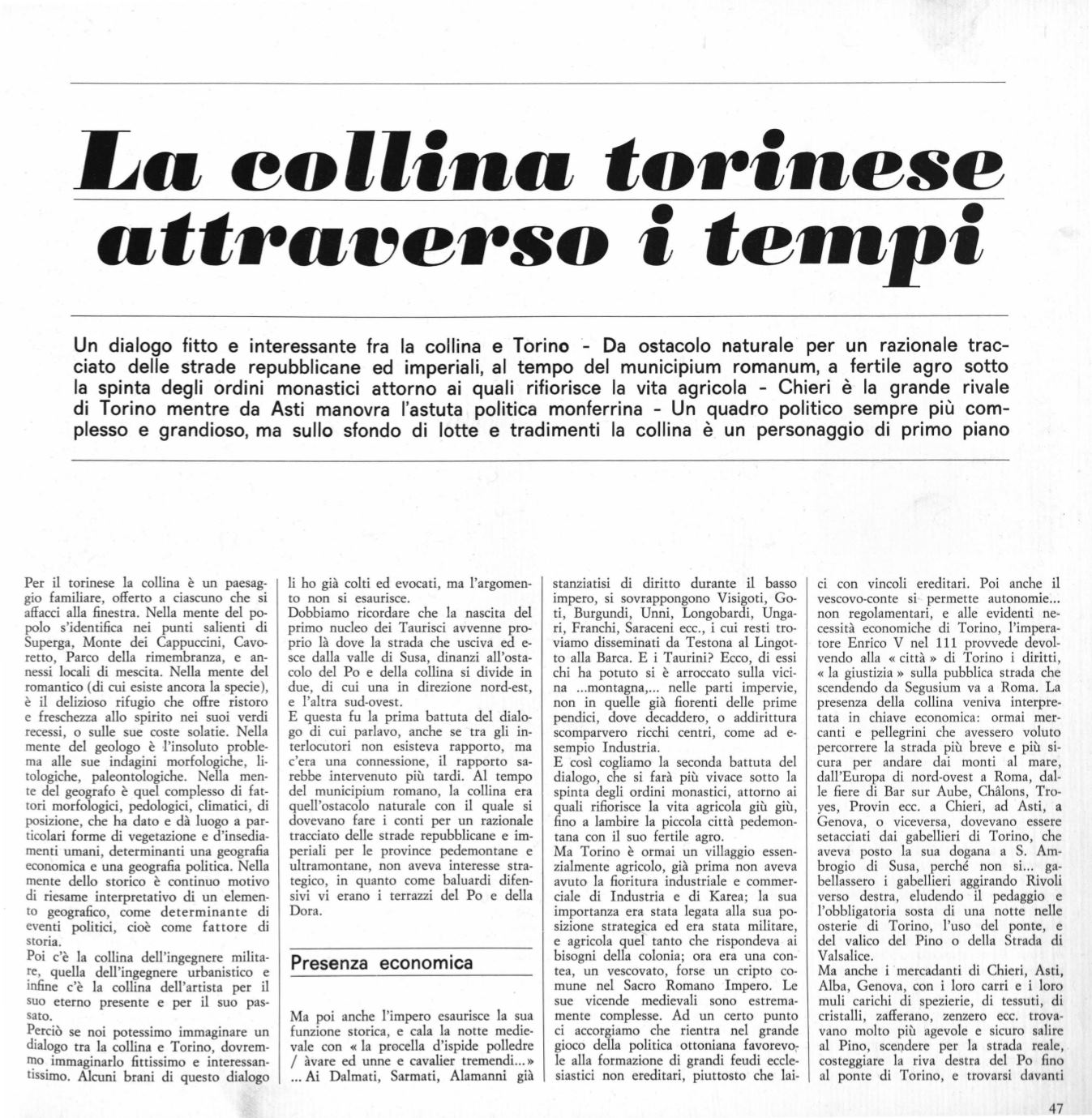
La eollina torinese
attraverso
i
tenapi
Un dialogo fitto e interessante fra la collina e Tòrino- Da ostacolo naturale per un razionale trac–
ciato delle strade repubblicane ed imperiali, al tempo del municipium romanum, a fertile agro sotto
la spinta degli ordini monastici attorno ai quali rifiorisce la vita agricola - Chieri
è
la grande rivale
di Torino mentre da Asti manovra l'astuta politica monferrina - Un quadro politico sempre più com–
plesso e grandioso, ma sullo sfondo di lotte e tradimenti la collina
è
un personaggio di primo piano
Per il torinese la collina è un paesag–
gio familiare, offerto a ciascuno che si
affacci alla finestra. Nella mente del po–
polo s'identifica nei punti salienti di
Superga, Monte dei Cappuccini, Cavo–
retto, Parco della rimembranza, e an–
nessi locali di mescita. Nella mente del
romantico (di cui esiste ancora la specie),
è il delizioso rifugio che offre ristoro
e freschezza allo spirito nei suoi verdi
recessi, o sulle sue coste solatie. Nella
mente del geologo è ,l'insoluto proble–
ma alle sue indagini morfologiche, li–
tologiche, paleontologiche. Nella men–
te del geografo è quel complesso di fat–
tori morfologici, pedologici, climatici, di
posizione, che ha dato e dà luogo a par–
ticolari forme di vegetazione e d'insedia–
menti umani, determinanti una geografia
economica e una geografia politica. Nella
mente dello storico è continuo motivo
di riesame interpretativo
di
un elemen–
to geografico, come determinante di
eventi politici, cioè come fattore di
storia.
Poi c'è la collina dell'ingegnere milita–
re, quella dell'ingegnere urbanistico e
infine c'è la collina dell'artista per il
suo eterno presente e per il suo pas–
sato.
Perciò se noi potessimo immaginare un
dialogo tra la collina e Torino, dovrem–
mo immaginarlo fittissimo e interessan–
tissimo. Alcuni brani di questo dialogo
li ho già colti ed evocati, ma l'argomen–
to non si esaurisce.
Dobbiamo ricordare che la nascita del
primo nucleo dei Taurisci avvenne pro–
prio là dove la strada che usciva ed e–
sce dalla valle di Susa, dinanzi all'osta–
colo del Po e della collina si divide in
due, di cui una in direzione nord-est,
e l'altra sud-ovest.
E questa fu la prima battuta del dialo–
go di cui parlavo, anche se tra gli in–
terlocutori non esisteva rapporto, ma
c'eta una connessione,
il
rapporto sa–
rebbe intervenuto più tardi. Al tempo
del municipium romano, la collina era
quell'ostacolo naturale con il quale si
dovevano fare i conti per un razionale
tracciato delle strade repubblicane e im–
periali per le province pedemontane e
ultramontane, non aveva interesse stra–
tegico, in quanto come baluardi difen–
SIVI VI
erano i terrazzi del Po e della
Dora.
Presenza economica
Ma poi anche l'impero esaurisce la sua
funzione storica, e cala la notte medie–
vale con «la pt0cella d'ispide polledre
/ àvare ed unne e cavalier tremendi... »
... Ai Dalmati, Sarmati, Alamanni già
stanziatisi di diritto durante il basso
impero, si sovrappongono Visigoti, Go–
ti, Burgundi, Dnni, Longobardi, Dnga–
ri, Franchi, Saraceni ecc., i cui resti tro–
viamo disseminati da Testona al Lingot–
to alla Barca. E i Taurini? Ecco, di essi
chi ha potuto si è arroccato sulla vici–
na ...montagna,... nelle parti impervie,
non in quelle già fiorenti delle prime
pendici, dove decaddero , o addirittura
scomparvero ricchi centri, come ad e–
sempio Industria.
E così cogliamo la seconda battuta del
dialogo, che si farà più vivace sotto la
spinta degli ordini monastici, attorno ai
quali rifiorisce la vita agricola giù giù,
fino a lambire la piccola città pedemon–
tana con il suo fertile agro.
Ma Torino è ormai un villaggio essen–
zialmente agricolo, già prima non aveva
avuto la fioritura industriale e commer–
ciale di Industria e di Karea; la sua
importanza era stata legata alla sua po–
sizione strategLca ed era stata militare,
e agricola quel tanto che rispondeva ai
bisogni della colonia; ora era una con–
tea, un vescovato, forse un cripto co–
mune nel Sacro Romano Impero. Le
sue vicende medievali sono estrema–
mente complesse. Ad un certo punto
ci accorgiamo che rientra nel grande
gioco della politica ottoniana
favorevo~
le alla formazione di grandi feudi eccle–
siastici non ereditari, piuttosto che lai-
ci con vincoli ereditari. Poi anche il
vescovo-conte si permette autonomie...
non regolamentari, e alle evidenti ne–
cessità economiche di Torino, l'impera–
tore Enrico V nel 111 provvede devol–
vendo alla «città» di Torino i diritti,
« la giustizia» sulla pubblica strada che
scendendo da Segusium va a Roma. La
presenza della collina veniva interpre–
tata in chiave economica : ormai mer–
canti e pellegrini che avessero voluto
percorrere la strada più breve e più si–
cura per andare dai monti al mare,
dall 'Europa di nord-ovest a Roma, dal–
le fiere di Bar sur Aube, Chalons, Tro–
yes, Provin ecc. a Chieri, ad Asti, a
Genova, o viceversa, dovevano essere
setacciati dai gabellieri di Torino, che
aveva posto la sua dogana a S. Am–
brogio di Susa, perché non si.. . ga–
bellassero i gabellieri aggirando Rivoli
verso destra, eludendo
il
pedaggio e
l'obbligatoria sosta di una notte nelle
osterie di Torino, l'uso del ponte, e
del valico del Pino o della Strada di
ValsaIice.
Ma anche i mercadanti di Chieri, Asti,
Alba, Genova, con i loro carri e i loro
muli carichi di spezierie, di tessuti, di
cristalli, zafferano, zenzero ecc. trova–
vano molto più agevole e sicuro salire
al Pino, sceijdere per la strada reale, .
costeggiare la riva destra del Po fino
al ponte di Torino, e trovarsi davanti
47


















