
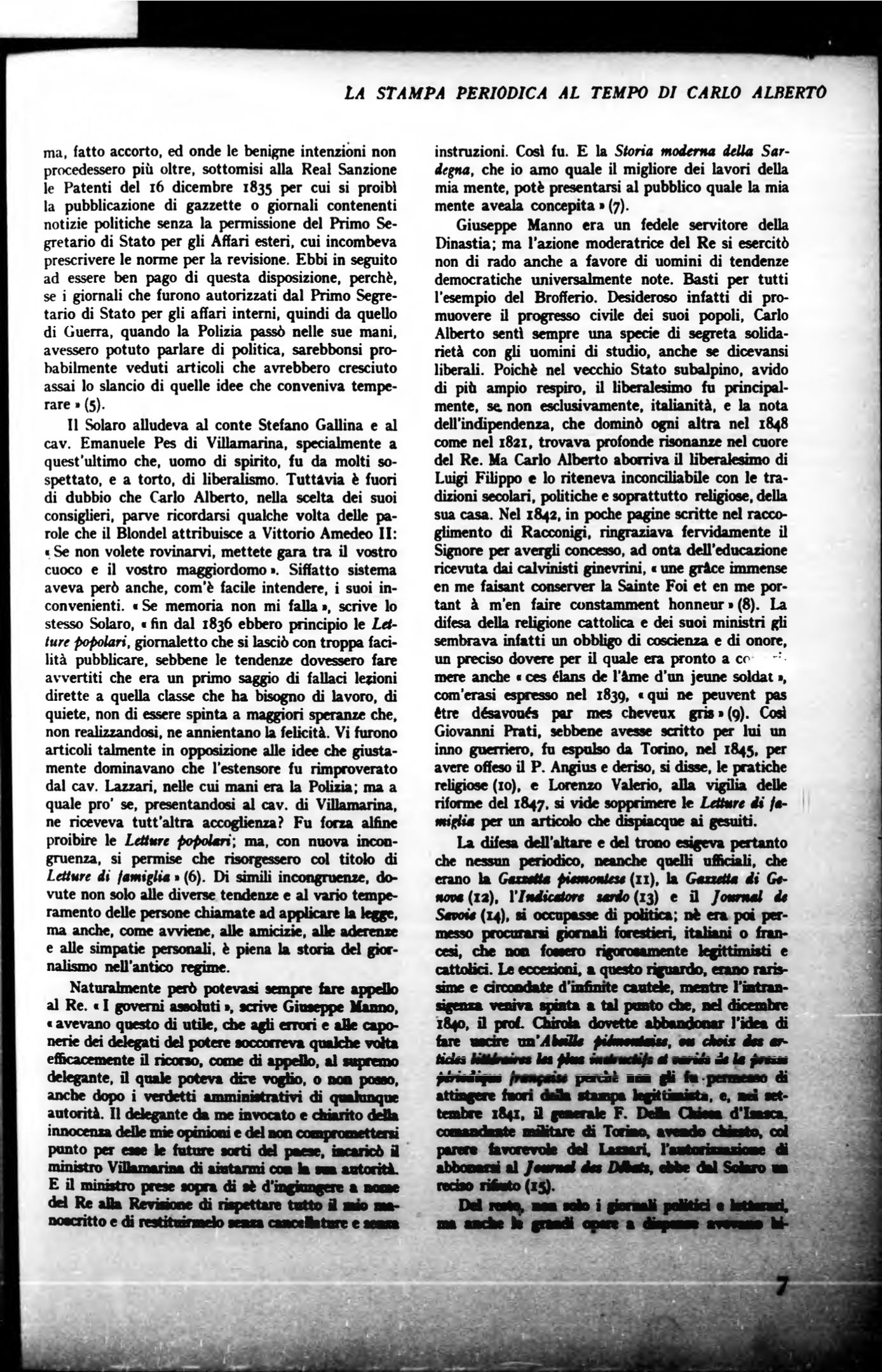
LA STAMPA PERIODICA AL TEMPO DI CARLO ALBERTO
ma,
fatto accorto, ed onde le benigne intenzioni non
procedessero più oltre, sottomisi alla Reai Sanzione
le Patenti del 16 dicembre 1835 per cui si proibì
la pubblicazione di gazzette o giornali contenenti
notizie politiche senza la permissione del Primo Se
gretario di Stato per gli Affari esteri, cui incombeva
prescrivere le norme per la revisione. Ebbi in seguito
ad essere ben pago di questa disposizione, perchè,
se i giornali che furono autorizzati dal Primo Segre
tario di Stato per gli affari interni, quindi da quello
di Guerra, quando la Polizia passò nelle sue mani,
avessero potuto parlare di politica, sarebbonsi pro
babilmente veduti articoli che avrebbero cresciuto
assai lo slancio di quelle idee che conveniva tempe
rare »(5).
Il Solaro alludeva al conte Stefano Gallina e al
cav .
Emanuele Pes di Villamarina, specialmente a
quest’ultimo che, uomo di spirito, fu da molti so
spettato, e a torto, di liberalismo. Tuttavia è fuori
di dubbio che Carlo Alberto, nella scelta dei suoi
consiglieri, parve ricordarsi qualche volta delle pa
role che il Blondel attribuisce a Vittorio Amedeo II:
«Se non volete rovinarvi, mettete gara tra il vostro
cuoco e il vostro maggiordomo». Siffatto sistema
aveva però anche, com’è facile intendere, i suoi in
convenienti. «Se memoria non mi falla », scrive lo
stesso Solaro, «fin dal 1836 ebbero principio le
Let
ture popolari,
giornaletto che si lasciò con troppa faci
lità pubblicare, sebbene le tendenze dovessero fare
avvertiti che era un primo saggio di fallaci lezioni
dirette a quella classe che ha bisogno di lavoro, di
quiete, non di essere spinta a maggiori speranze che,
non realizzandosi, ne annientano la felicità. Vi furono
articoli talmente in opposizione alle idee che giusta
mente dominavano che l’estensore fu rimproverato
dal cav. Lazzari, nelle cui mani era la Polizia; ma a
quale prò’ se, presentandosi al cav. di Villamarina,
ne riceveva tutt'altra accoglienza? Fu forza alfine
proibire le
Letture popolari',
ma, con nuova incon
gruenza, si permise che risorgessero col titolo di
Letture di famiglia
»(6). Di simili incongruenze, do
vute non solo alle diverse tendenze
e al vario
tempe
ramento delle persone chiamate
ad applicare la legge,
ma anche, come avviene,
alle
amicizie,
alk aderenze
e alle simpatie personali, è piena
la
storia
del gior
nalismo nell’antico regime.
Naturalmente però potevasi sempre
fare
appello
al Re. «I governi assoluti », scrive
Giuseppe Manno,
«avevano questo di utile,
che agli
errori
e alle capo
nerie dei delegati del
potere soccorreva
qualche
volta
efficacemente
il ricorso, come di appello, al supremo
delegante, il quale
poteva dire voglio,
o
non posso,
anche dopo i
verdetti amministrativi di qualunque
autorità. Il
delegante da me invocato e chiarito della
innocenza delle
mie opinioni e dd noncompromettersi
punto
per esse le fatare sorti dd paese, incaricò fl
ministro
Villamarina di aiutarmi con la sua autorità.
E il ministro
prese sopra di sè d’ingiungere a nome
del Re alla Revisione di rispettare tatto il ino
ma
noscritto e di restituirmelo sema cancrlatare e sena
instruzioni. Così fu.
E
la
Storia moderna della Sar
degna,
che io amo quale il migliore dei lavori della
mia mente, potè presentarsi al pubblico quale la mia
mente aveala concepita »(7).
Giuseppe Manno era un fedele servitore della
Dinastia; ma l’azione moderatrice del Re si esercitò
non di rado anche a favore di uomini di tendenze
democratiche universalmente note. Basti per tutti
l’esempio del Brofferio. Desideroso infatti di pro
muovere il progresso civile dei suoi popoli, Carlo
Alberto sentì sempre una specie di segreta solida
rietà con gli uomini di studio, anche se dicevansi
liberali. Poiché nel vecchio Stato subalpino, avido
di più ampio respiro, il liberalesimo fu principal
mente, se. non esclusivamente, italianità, e la nota
deU’indipendenza, che dominò ogni altra nel 1848
come nel 1821, trovava profonde risonanze nel cuore
del Re. Ma Carlo Alberto aborriva il liberalesimo di
Luigi Filippo e lo riteneva inconciliabile con le tra
dizioni secolari, politiche e soprattutto religiose, della
sua casa. Nel 1842, in poche pagine scritte nel racco
glimento di Racconigi, ringraziava fervidamente il
Signore per avergli concesso, ad onta dell’educazione
ricevuta dai calvinisti ginevrini, «une gràce immense
en me faisant conserver la Sainte Foi et en me por-
tant à m’en faire constamment honneur »(8). La
difesa della religione cattolica e dei suoi ministri gli
sembrava infatti un obbligo di coscienza e di onore,
un preciso dovere per il quale era pronto a co -?-
mere anche «ces élans de l’àme d’un jeune soldat »,
com’erasi espresso nel 1839, «qui ne peuvent pas
étre désavoués par mes cheveux gris »(9). Così
Giovanni Prati, sebbene avesse scritto per lui un
inno guerriero, fu espulso da Torino, nel 1845, per
avere offeso il P. Angius e deriso, si disse, le pratiche
religiose (10), e Lorenzo Valerio, alla vigilia delle
riforme del 1847. si vide sopprimere le
Letture di fa
miglia
per un articolo che dispiacque ai gesuiti.
La difesa dell’altare e del trono esigeva pertanto
che nessun periodico, neanche quelli ufficiali, che
erano la
Gazzetta piemontese
(11), la
Gazzetta di Ge
nova (12), VIndicatore sardo (1
3)
e il
Journal de
Savoie
(14), si occupasse di politica; nè era poi per
messo procurarsi giornali forestieri, italiani o fran
cesi, che non fossero rigorosamente legittimisti e
cattolici. Le eccctioni, a questo riguardo, erano raris
sime e circondate d’infinite cautele, mentre l’intran
sigenza veniva spinta a tal ponto die, nel dicembre
1840, fl prof. Chinila dovette abbandonar l’idea di
fare osa re
xm’AbeiUe piémontaise, om ckoix des or
-
j l M . .
tmm Alm a»
^ ----------* i - 1 - I
m a.
------------
It&Cò
iVM C T fim
§C
9
p u s VHiH V IM /j 0 v i n c s
mC
Mi
JrrC&SC
M-
*- »- J-»------
1
------------------------------%- a ------- - i ;
Ai
jK n vm u p ic
p e r u l e n o n g i i i n ’ p s n n c s s o cu
~aa»-----------
t
.
W—
-
jl
. .
a
♦*** ?_ a _
---- n — a
attingere xuon Qou wiinpi ìeguonusta,
t
9
s a set-
tembre
1841, il
generale
F.
Della Classa d'Isasca.
comandante militare di Torino, avendo chiesto, col
parere favorevole dd Lanari, l'autorizzazione di
abbonarsi al
Jcmrual dea Déiets,
ebbe dd
Solaro
on
reciso rifato (15).
Dd redo, non solo i giornali poiitàd e letterari,
ma anche l i grandi <
m r
i
dispone avevano fai-


















