
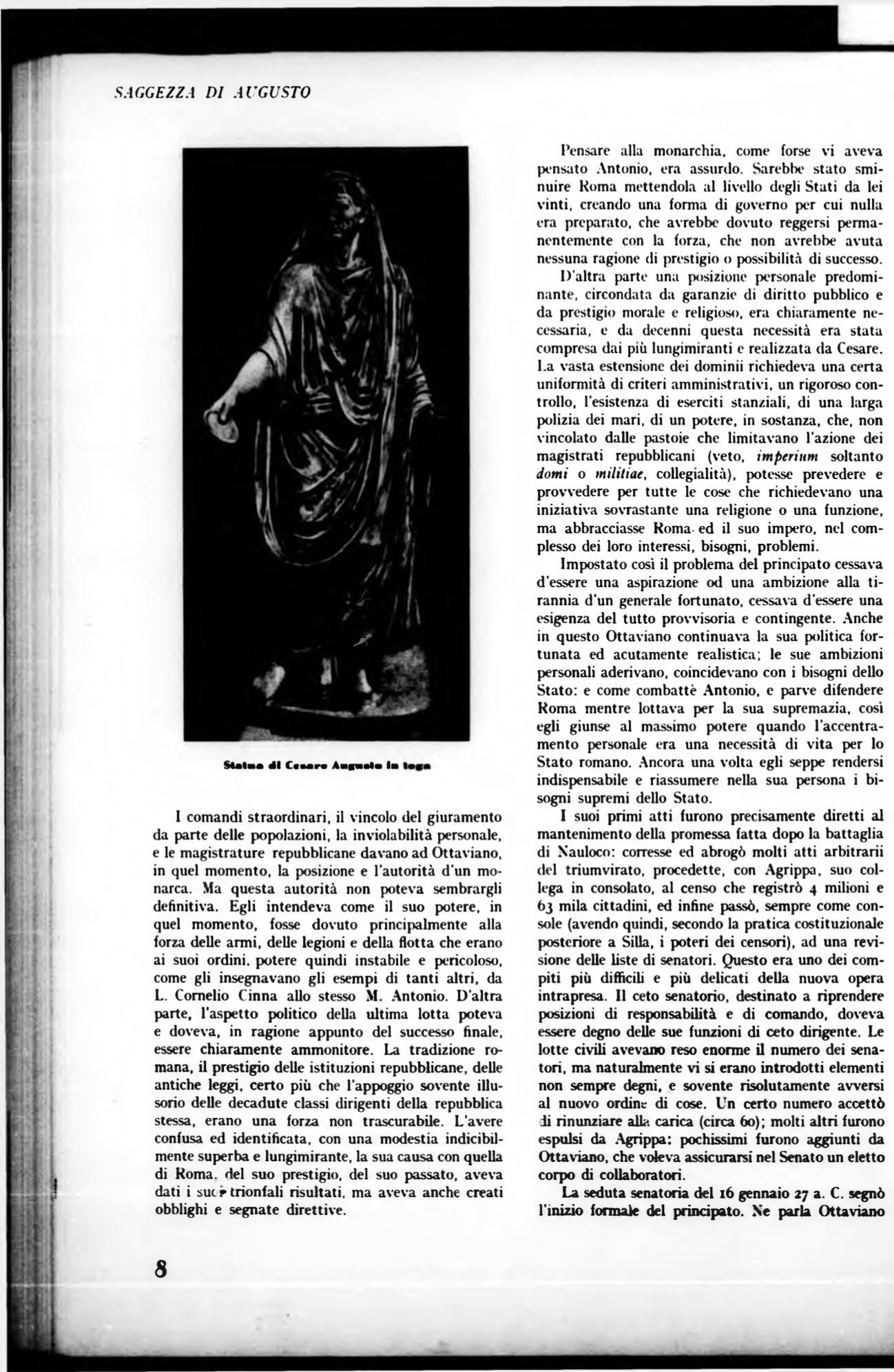
SAGGEZZA DI AUGUSTO
> r
S t a la * 41 C e s a re A a g a a ta la
I
comandi straordinari, il vincolo del giuramento
da parte delle popolazioni, la inviolabilità personale,
e le magistrature repubblicane davano ad Ottaviano,
in quel momento, la posizione e l ’autorità d ’un mo
narca. Ma questa autorità non poteva sembrargli
definitiva. Egli intendeva come il suo potere, in
quel momento, fosse dovuto principalmente alla
forza delle armi, delle legioni e della flotta che erano
ai suoi ordini, potere quindi instabile e pericoloso,
come gli insegnavano gli esempi di tan ti altri, da
L. Cornelio Cinna allo stesso M. Antonio. D ’altra
parte, l ’aspetto politico della ultima lotta poteva
e doveva, in ragione appunto del successo finale,
essere chiaramente ammonitore. La tradizione ro
mana, il prestigio delle istituzioni repubblicane, delle
antiche leggi, certo più che l ’appoggio sovente illu
sorio delle decadute classi dirigenti della repubblica
stessa, erano una forza non trascurabile. L ’avere
confusa ed identificata, con una modestia indicibil
mente superba e lungimirante, la sua causa con quella
di Roma, del suo prestigio, del suo passato, aveva
dati i sue? trionfali risultati, ma aveva anche creati
obblighi e segnate direttive.
Pensare alla monarchia, come forse v i aveva
pensato Antonio, era assurdo. Sarebbe stato smi
nuire Roma mettendola al livello degli Stati da lei
vinti, creando una forma di governo per cui nulla
era preparato, che avrebbe dovuto reggersi perma
nentemente con la forza, che non avrebbe avuta
nessuna ragione di prestigio o possibilità di successo.
D ’altra parte una posizione personale predomi
nante, circondata da garanzie di diritto pubblico e
da prestigio morale e religioso, era chiaramente ne
cessaria, e da decenni questa necessità era stata
compresa dai più lungimiranti e realizzata da Cesare.
La vasta estensione dei dominii richiedeva una certa
uniformità di criteri amministrativi, un rigoroso con
trollo, l’esistenza di eserciti stanziali, di una larga
polizia dei mari, di un potere, in sostanza, che, non
vincolato dalle pastoie che limitavano l’azione dei
magistrati repubblicani (veto,
imperium
soltanto
domi
o
militine,
collegialità), potesse prevedere e
provvedere per tutte le cose che richiedevano una
iniziativa sovrastante una religione o una funzione,
ma abbracciasse Roma- ed il suo impero, nel com
plesso dei loro interessi, bisogni, problemi.
Impostato così il problema del principato cessava
d ’essere una aspirazione od una ambizione alla ti
rannia d ’un generale fortunato, cessava d ’essere una
esigenza del tutto provvisoria e contingente. Anche
in questo Ottaviano continuava la sua politica for
tunata ed acutamente realistica; le sue ambizioni
personali aderivano, coincidevano con i bisogni dello
Stato: e come combattè Antonio, e parve difendere
Roma mentre lottava per la sua supremazia, così
egli giunse al massimo potere quando l ’accentra
mento personale era una necessità di v ita per lo
Stato romano. Ancora una volta egli seppe rendersi
indispensabile e riassumere nella sua persona i bi
sogni supremi dello Stato.
I
suoi primi atti furono precisamente diretti
mantenimento della promessa fatta dopo la battaglia
di Xauloco: corresse ed abrogò molti atti arbitrarti
del triumvirato, procedette, con Agrippa, suo col
lega in consolato, al censo che registrò 4 milioni e
63 mila cittadini, ed infine passò, sempre come con
sole (avendo quindi, secondo la pratica costituzionale
posteriore a Siila, i poteri dei censori), ad una revi
sione delle liste di senatori. Questo era uno dei com
piti più difficili e più delicati della nuova opera
intrapresa. Il ceto senatorio, destinato a riprendere
posizioni di responsabilità e di comando, doveva
essere degno delle sue funzioni di ceto dirigente. Le
lotte civili avevano reso enorme il numero dei sena
tori, ma naturalmente v i si erano introdotti elementi
non sempre degni, e sovente risolutamente avversi
al nuovo ordine di cose. Un certo numero accettò
di rinunziare alla carica (circa 60); molti altri furono
espulsi da Agrippa: pochissimi furono aggiunti da
Ottaviano, che voleva assicurarsi nel Senato un eletto
corpo di collaboratori.
La seduta senatoria del 16 gennaio 27 a.
C.
segnò
l’inizio formale del principato. Ne parla Ottaviano
8


















