
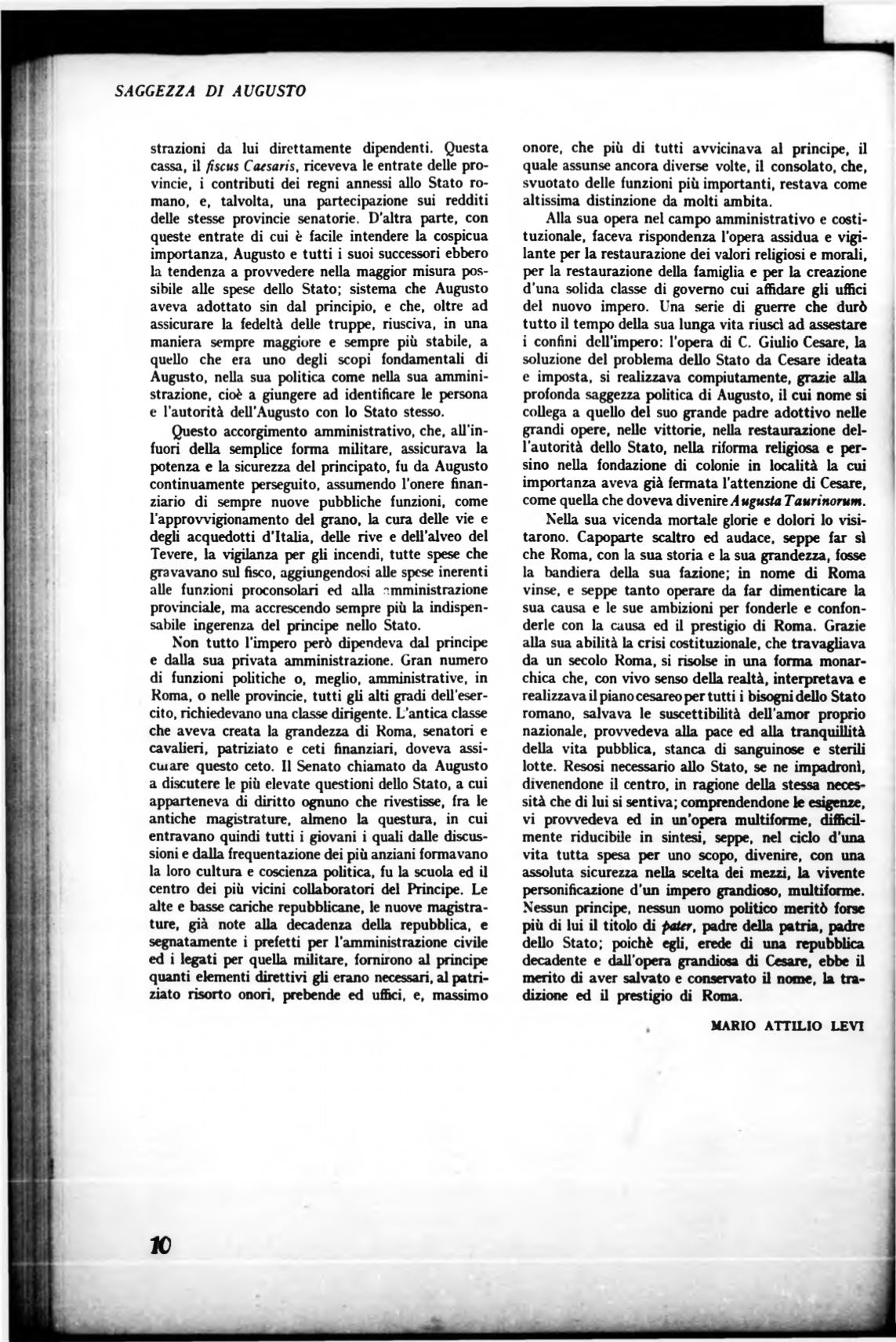
SAGGEZZA DI AUGUSTO
strazioni da lui direttamente dipendenti. Questa
cassa, il
fiscus Caesaris,
riceveva le entrate delle pro-
vincie, i contributi dei regni annessi allo Stato ro
mano, e, talvolta, una partecipazione sui redditi
delle stesse provincie senatorie. D’altra parte, con
queste entrate di cui è facile intendere la cospicua
importanza, Augusto e tutti i suoi successori ebbero
la tendenza a provvedere nella maggior misura pos
sibile alle spese dello Stato; sistema che Augusto
aveva adottato sin dal principio, e che, oltre ad
assicurare la fedeltà delle truppe, riusciva, in una
maniera sempre maggiore e sempre più stabile, a
quello che era uno degli scopi fondamentali di
Augusto, nella sua politica come nella sua ammini
strazione, cioè a giungere ad identificare le persona
e l’autorità dell’Augusto con lo Stato stesso.
Questo accorgimento amministrativo, che, all’in-
fuori della semplice forma militare, assicurava la
potenza e la sicurezza del principato, fu da Augusto
continuamente perseguito, assumendo l’onere finan
ziario di sempre nuove pubbliche funzioni, come
l'approvvigionamento del grano, la cura delle vie e
degli acquedotti d’Italia, delle rive e dell’alveo del
Tevere, la vigilanza per gli incendi, tutte spese che
gravavano sul fisco, aggiungendosi alle spese inerenti
alle funzioni proconsolari ed alla amministrazione
provinciale, ma accrescendo sempre più la indispen
sabile ingerenza del principe nello Stato.
Non tutto l’impero però dipendeva dal principe
e dalla sua privata amministrazione. Gran numero
di funzioni politiche o, meglio, amministrative, in
Roma, o nelle provincie, tutti gli alti gradi dell’eser
cito, richiedevano una classe dirigente. L’antica classe
che aveva creata la grandezza di Roma, senatori e
cavalieri, patriziato e ceti finanziari, doveva assi
emare questo ceto. Il Senato chiamato da Augusto
a discutere le più elevate questioni dello Stato, a cui
apparteneva di diritto ognuno che rivestisse, fra le
antiche magistrature, almeno la questura, in cui
entravano quindi tutti i giovani i quali dalle discus
sioni e dalla frequentazione dei più anziani formavano
la loro cultura e coscienza politica, fu la scuola ed il
centro dei più vicini collaboratori del Principe. Le
alte e basse cariche repubblicane, le nuove magistra
ture, già note alla decadenza della repubblica, e
segnatamente i prefetti per l ’amministrazione civile
ed i legati per quella militare, fornirono al principe
quanti elementi direttivi gli erano necessari, al patri
ziato risorto onori, prebende ed uffici, e, massimo
onore, che più di tutti avvicinava al principe, il
quale assunse ancora diverse volte, il consolato, che,
svuotato delle funzioni più importanti, restava come
altissima distinzione da molti ambita.
Alla sua opera nel campo amministrativo e costi
tuzionale, faceva rispondenza l’opera assidua e vigi
lante per la restaurazione dei valori religiosi e morali,
per la restaurazione della famiglia e per la creazione
d ’una solida classe di governo cui affidare gli uffici
del nuovo impero. Una serie di guerre che durò
tutto il tempo della sua lunga vita riuscì ad assestare
i confini dell’impero: l’opera di C. Giulio Cesare, la
soluzione del problema dello Stato da Cesare ideata
e imposta, si realizzava compiutamente, grazie alla
profonda saggezza politica di Augusto, il cui nome si
collega a quello del suo grande padre adottivo nelle
grandi opere, nelle vittorie, nella restaurazione del
l ’autorità dello Stato, nella riforma religiosa e per
sino nella fondazione di colonie in località la cui
importanza aveva già fermata l’attenzione di Cesare,
come quella che doveva divenire
Augusta Taurinorum.
Nella sua vicenda mortale glorie e dolori lo visi
tarono. Capoparte scaltro ed audace, seppe far sì
che Roma, con la sua storia e la sua grandezza, fosse
la bandiera della sua fazione; in nome di Roma
vinse, e seppe tanto operare da far dimenticare la
sua causa e le sue ambizioni per fonderle e confon
derle con la causa ed il prestigio di Roma. Grazie
alla sua abilità la crisi costituzionale, che travagliava
da un secolo Roma, si risolse in una forma monar
chica che, con vivo senso della realtà, interpretava e
realizzava il piano cesareo per tutti i bisogni dello Stato
romano, salvava le suscettibilità dell’amor proprio
nazionale, provvedeva alla pace ed alla tranquillità
della vita pubblica, stanca di sanguinose e sterili
lotte. Resosi necessario allo Stato, se ne impadronì,
divenendone il centro, in ragione della stessa neces
sità che di lui si sentiva; comprendendone le esigenze,
vi provvedeva ed in un’opera multiforme, difficil
mente riducibile in sintesi, seppe, nel ciclo d ’una
vita tutta spesa per uno scopo, divenire, con una
assoluta sicurezza nella scelta dei mezzi, la vivente
personificazione d’un impero grandioso, multiforme.
Nessun principe, nessun uomo politico meritò forse
più di lui il titolo di
poter,
padre della patria, padre
dello Stato; poiché egli, erede di una repubblica
decadente e dall’opera grandiosa di Cesare,
ebbe
il
merito di aver salvato e conservato il nome, la tra
dizione ed il prestigio di Roma.
MARIO ATTILIO LEVI
JC


















