
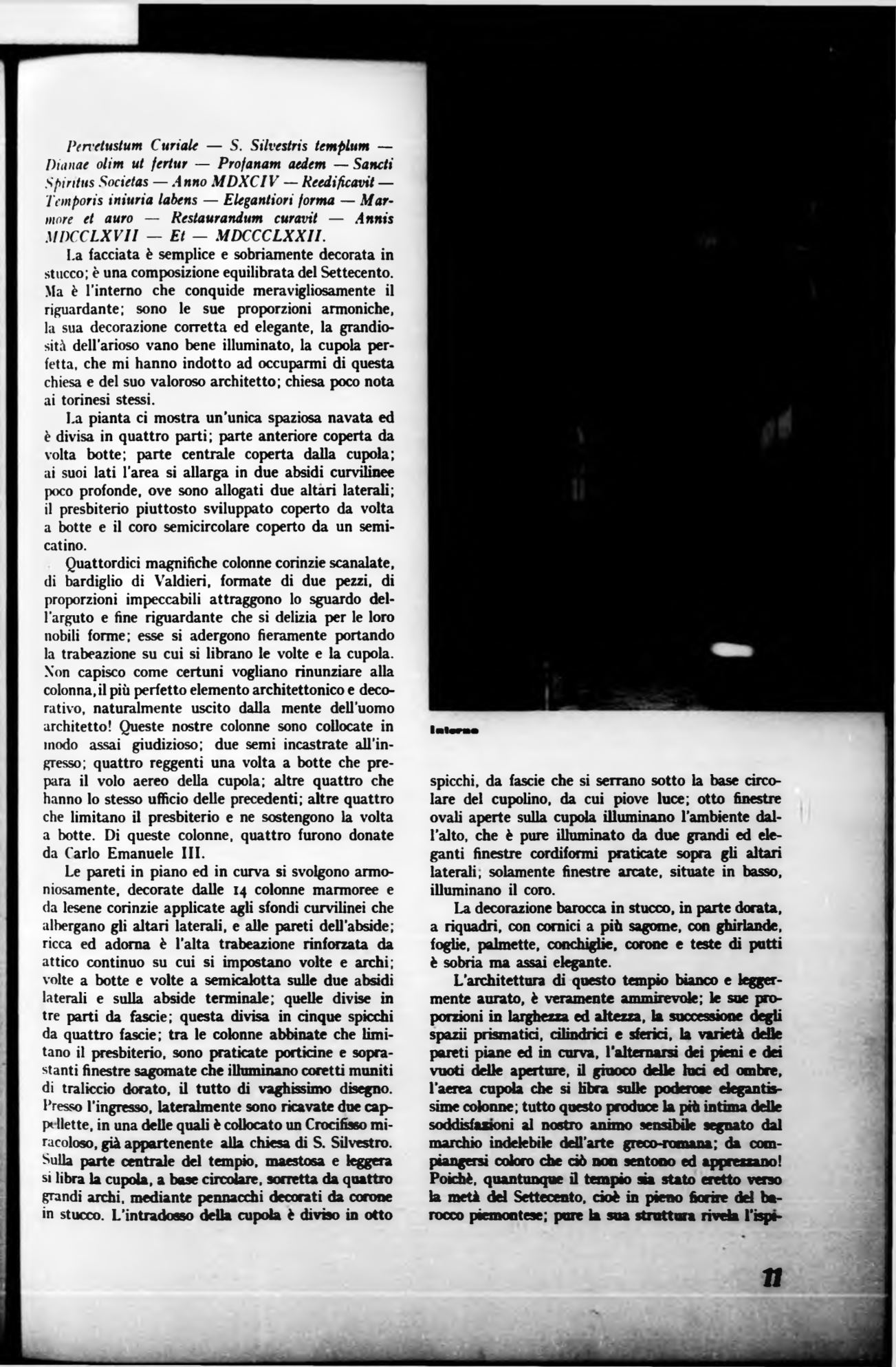
Pervetustum Curiale
—
S. Silvestris tempLtim
—
Diaiiae olim ut fertur
—
Profanarti aedem
—
Sancii
Spiritus Societas
—
Anno M D X C IV
—
Reedificavit
—
Temporis iniuria labens
—
Elegantiori forma
—
Mar
more et auro
—
Restaurandum curavit
—
Annis
M D C C LX V II — Et
—
M D C C C LX X I I.
La facciata è semplice e sobriamente decorata in
stucco; è una composizione equilibrata del Settecento.
Ma è l’interno che conquide meravigliosamente il
riguardante; sono le sue proporzioni armoniche,
la sua decorazione corretta ed elegante, la grandio
sità dell’arioso vano bene illuminato, la cupola per
fetta, che mi hanno indotto ad occuparmi di questa
chiesa e del suo valoroso architetto; chiesa poco nota
ai torinesi stessi.
La pianta ci mostra un’unica spaziosa navata ed
è divisa in quattro parti; parte anteriore coperta da
volta botte; parte centrale coperta dalla cupola;
ai suoi lati l’area si allarga in due absidi curvilinee
poco profonde, ove sono allogati due altari laterali;
il presbiterio piuttosto sviluppato coperto da volta
a botte e il coro semicircolare coperto da un semi
catino.
Quattordici magnifiche colonne corinzie scanalate,
di bardiglio di Valdieri, formate di due pezzi, di
proporzioni impeccabili attraggono lo sguardo del
l’arguto e fine riguardante che si delizia per le loro
nobili forme; esse si adergono fieramente portando
la trabeazione su cui si librano le volte e la cupola.
Non capisco come certuni vogliano rinunziare alla
colonna.ilpiù perfetto elemento architettonico e deco
rativo, naturalmente uscito dalla mente dell’uomo
architetto! Queste nostre colonne sono collocate in
modo assai giudizioso; due semi incastrate all’in
gresso; quattro reggenti una volta a botte che pre
para il volo aereo della cupola; altre quattro che
hanno lo stesso ufficio delle precedenti; altre quattro
che limitano il presbiterio e ne sostengono la volta
a botte. Di queste colonne, quattro furono donate
da Carlo Emanuele III.
Le pareti in piano ed in curva si svolgono armo
niosamente, decorate dalle 14 colonne marmoree e
da lesene corinzie applicate agli sfondi curvilinei che
albergano gli altari laterali, e alle pareti dell’abside;
ricca ed adorna è l’alta trabeazione rinforzata da
attico continuo su cui si impostano volte e archi;
volte a botte e volte a semicalotta sulle due absidi
laterali e sulla abside terminale; quelle divise in
tre parti da fascie; questa divisa in cinque spicchi
da quattro fascie; tra le colonne abbinate che limi
tano il presbiterio, sono praticate porticine e sopra
stanti finestre sagomate che illuminano coretti muniti
di traliccio dorato, il tutto di vaghissimo disegno.
Presso l’ingresso, lateralmente sono ricavate due cap
pi dette, in una delle quali è collocato un Crocifisso mi
racoloso, già appartenente alla chiesa di S. Silvestro.
Sulla parte centrale del tempio, maestosa e leggera
si libra la cupola, a base circolare, sorretta da quattro
grandi archi, mediante pennacchi decorati da corone
in stucco. L ’intradosso della cupola è diviso in otto
U lt r a *
spicchi, da fascie che si serrano sotto la base circo
lare del cupolino, da cui piove luce; otto finestre
ovali aperte sulla cupola illuminano l’ambiente dal
l’alto, che è pure illuminato da due grandi ed ele
ganti finestre cordiformi praticate sopra gli altari
laterali, solamente finestre arcate, situate in basso,
illuminano il coro.
La decorazione barocca in stucco, in parte dorata,
a riquadri, con cornici a più sagome, con ghirlande,
foglie, palmette, conchiglie, corone e teste di putti
è sobria ma assai elegante.
L ’architettura di questo tempio bianco e legger
mente aurato, è veramente ammirevole; le sue pro
porzioni in larghezza ed altezza, la successione degli
spazii prismatici, cilindrici e sferici, la varietà delle
pareti piane ed in curva, l ’alternarsi dei pieni e dei
vuoti delle aperture, il giuoco delle
lud
ed
ombre,
l'aerea cupola che si libra sulle poderose elegantis
sime colonne; tutto questo produce la più intima delle
soddisfammi al nostro animo sensibile segnato dal
marchio indelebile dell’arte greco-romana; da com
piangersi cokxo
che
dò
non sentono
ed
appressano!
Poiché, quantunque il tempio
sia stato eretto verso
la metà del Settecento,
cioè
in
pieno fiorire
dd
ba
rocco piemontese;
pure
la
sua struttura rivela l’ispt-
u


















