
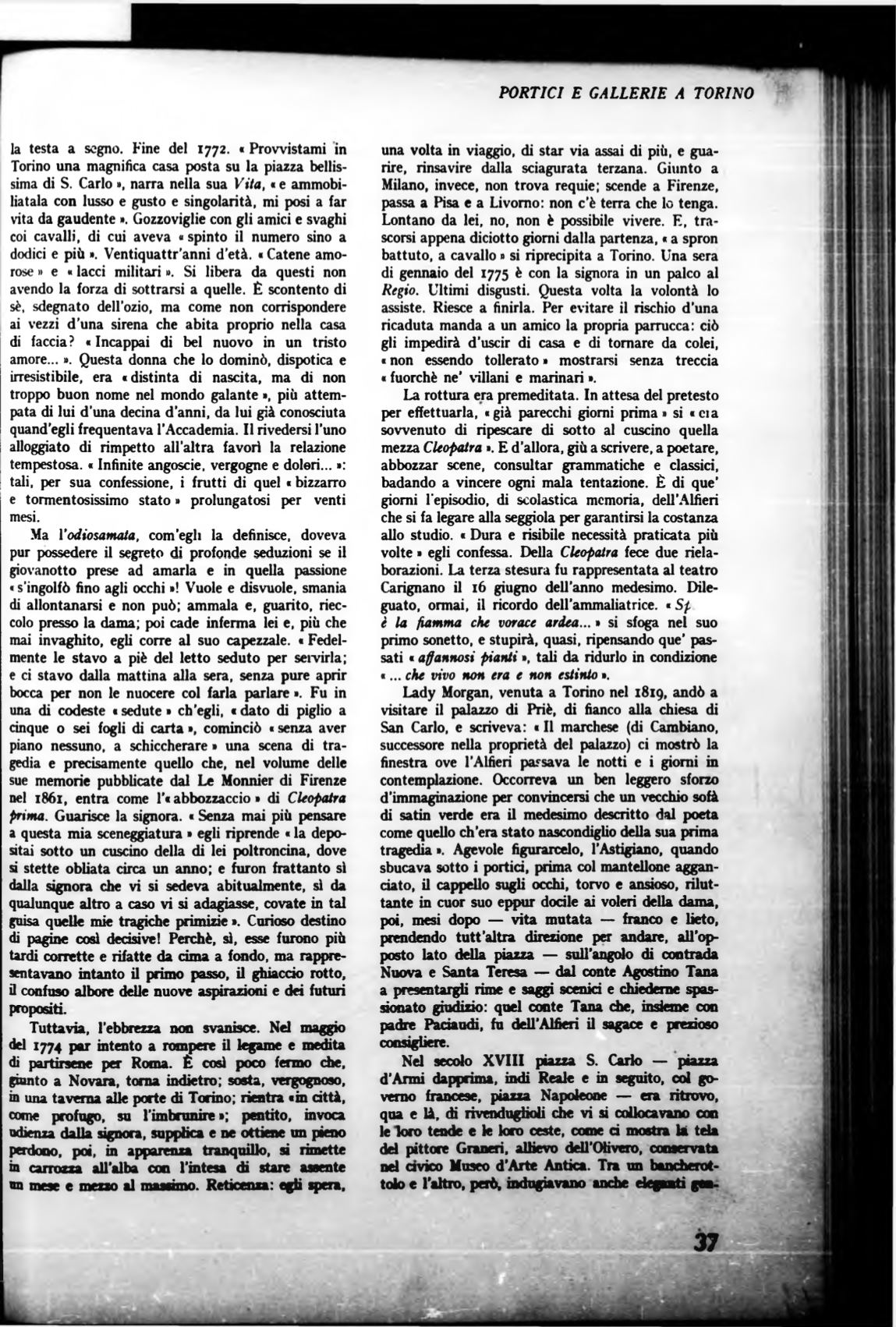
PORTICI E GALLERIE A TORINO
la testa a segno. Fine del 1772. «Provvistami in
Torino una magnifica casa posta su la piazza bellis
sima di S. Carlo », narra nella sua
Vita,
«e ammobi
liatala con lusso e gusto e singolarità, mi posi a far
vita da gaudente ». Gozzoviglie con gli amici e svaghi
coi cavalli, di cui aveva «spinto il numero sino a
dodici e più ». Ventiquattr’anni d’età. «Catene amo
rose » e «lacci militari ». Si libera da questi non
avendo la forza di sottrarsi a quelle. È scontento di
sè, sdegnato dell’ozio, ma come non corrispondere
ai vezzi d ’una sirena che abita proprio nella casa
di faccia? «Incappai di bel nuovo in un tristo
amore... ». Questa donna che lo dominò, dispotica e
irresistibile, era «distinta di nascita, ma di non
troppo buon nome nel mondo galante », più attem
pata di lui d ’una decina d ’anni, da lui già conosciuta
quand'egli frequentava l’Accademia. Il rivedersi l’uno
alloggiato di rimpetto all’altra favorì la relazione
tempestosa. « Infinite angoscie, vergogne e dolori... »:
tali, per sua confessione, i frutti di quel «bizzarro
e tormentosissimo stato » prolungatosi per venti
mesi.
Ma
Yodiosamata,
com’egli la definisce, doveva
pur possedere il segreto di profonde seduzioni se il
giovanotto prese ad amarla e in quella passione
«s’ingolfò fino agli occhi »! Vuole e disvuole, smania
di allontanarsi e non può; ammala e, guarito, riec-
colo presso la dama; poi cade inferma lei e, più che
mai invaghito, egli corre al suo capezzale. «Fedel
mente le stavo a piè del letto seduto per servirla;
e ci stavo dalla mattina alla sera, senza pure aprir
bocca per non le nuocere col farla parlare ». Fu in
una di codeste «sedute » ch'egli, «dato di piglio a
cinque o sei fogli di carta », cominciò «senza aver
piano nessuno, a schiccherare » ima scena di tra
gedia e precisamente quello che, nel volume delle
sue memorie pubblicate dal Le Monnier di Firenze
nel 1861, entra come l'« abbozzaccio » di
Cleopatra
prima.
Guarisce la signora. «Senza mai più pensare
a questa mia sceneggiatura » egli riprende «la depo
sitai sotto un cuscino della di lei poltroncina, dove
si stette obliata circa un anno; e furon frattanto sì
dalla signora che vi si sedeva abitualmente, sì da
qualunque altro a caso vi si adagiasse, covate in tal
guisa quelle mie tragiche primizie ». Curioso destino
di pagine così decisive! Perchè, sì, esse furono più
tardi corrette e rifatte da cima a fondo, ma rappre
sentavano intanto il primo passo, il ghiaccio rotto,
il confuso albore delle nuove aspirazioni e dei futuri
propositi.
Tuttavia, l’ebbrezza non svanisce. Nel maggio
del 1774
par intento a rompere il legame e medita
di partirsene per Roma. È così poco fermo che,
giunto a Novara, toma indietro; sosta, vergognoso,
in una taverna alle porte di Torino; rientra «in città,
come
profugo, su l’imbrunire»; pentito, invoca
udienza dalla signora, supplica e ne ottiene un pieno
perdono, poi, in apparenza tranquillo, si rimette
in carrozza all’alba
eoo
l’intesa di stare assente
un mese e mezzo al massimo. Reticenza: egli spera.
una volta in viaggio, di star via assai di più, e gua
rire, rinsavire dalla sciagurata terzana. Giunto a
Milano, invece, non trova requie; scende a Firenze,
passa a Pisa e a Livorno: non c'è terra che lo tenga.
Lontano da lei, no, non è possibile vivere. E, tra
scorsi appena diciotto giorni dalla partenza, «a spron
battuto, a cavallo »si riprecipita a Torino. Una sera
di gennaio del 1775 è con la signora in un palco al
Regio.
Ultimi disgusti. Questa volta la volontà lo
assiste. Riesce a finirla. Per evitare il rischio d ’una
ricaduta manda a un amico la propria parrucca: ciò
gli impedirà d ’uscir di casa e di tornare da colei,
«non essendo tollerato » mostrarsi senza treccia
«fuorché ne’ villani e marinari ».
La rottura era premeditata. In attesa del pretesto
per effettuarla, «già parecchi giorni prima» si «eia
sovvenuto di ripescare di sotto al cuscino quella
mezza
Cleopatra
». E d’allora, giù a scrivere, a poetare,
abbozzar scene, consultar grammatiche e classici,
badando a vincere ogni mala tentazione. È di que’
giorni l’episodio, di scolastica memoria, dell’Alfieri
che si fa legare alla seggiola per garantirsi la costanza
allo studio. «Dura e risibile necessità praticata più
volte » egli confessa. Della
Cleopatra
fece due riela
borazioni. La terza stesura fu rappresentata al teatro
Carignano il 16 giugno dell’anno medesimo. Dile
guato, ormai, il ricordo deU’ammaliatrice. «
Sp
è la fiamma che vorace ardea...
» si sfoga nel suo
primo sonetto, e stupirà, quasi, ripensando que’ pas
sati «
affannosi pianti
», tali da ridurlo in condizione
«
...che vivo non era e non estinto
».
Lady Morgan, venuta a Torino nel 1819, andò a
visitare il palazzo di Priè, di fianco alla chiesa di
San Carlo, e scriveva: «Il marchese (di Cambiano,
successore nella proprietà del palazzo) ci mostrò la
finestra ove l ’Alfieri passava le notti e i giorni in
contemplazione. Occorreva un ben leggero sforzo
d’immaginazione per convincersi che un vecchio sofà
di satin verde era il medesimo descritto dal poeta
come quello ch’era stato nascondiglio della sua prima
tragedia ». Agevole figurarcelo, l’Astigiano, quando
sbucava sotto i portici, prima col mantellone aggan
ciato, il cappello sugli occhi, torvo e ansioso, rilut
tante in cuor suo eppur docile ai voleri della dama,
poi, mesi dopo — vita mutata — franco e lieto,
prendendo tutt’altra direzione per andare, all'op
posto lato della piazza — sull'angolo di contrada
Nuova e Santa Teresa — dal conte Agostino Tana
a presentargli rime e saggi scenici e chiederne spas
sionato giudizio: quel conte Tana che, insieme con
padre Padaudi, fu dell’Alfieri il sagace e prezioso
consigliere.
Nel secolo
XVIII
piazza
S.
Carlo
—
piazza
d’Armi dapprima, indi Reale e in seguito, col go
verno francese, piazza Napoleone — era ritrovo,
qua
e
là,
di rivenduglioli che vi si collocavano con
le loro tende e le loro ceste, come d mostra là tela
del pittore Graneri, allievo dell’Olivero, conservata
nel a vico Museo d’Arte Antica. Tra un bancherot-
tok>e l'altro, perù, indugiavano anche eleganti gen-
37


















