
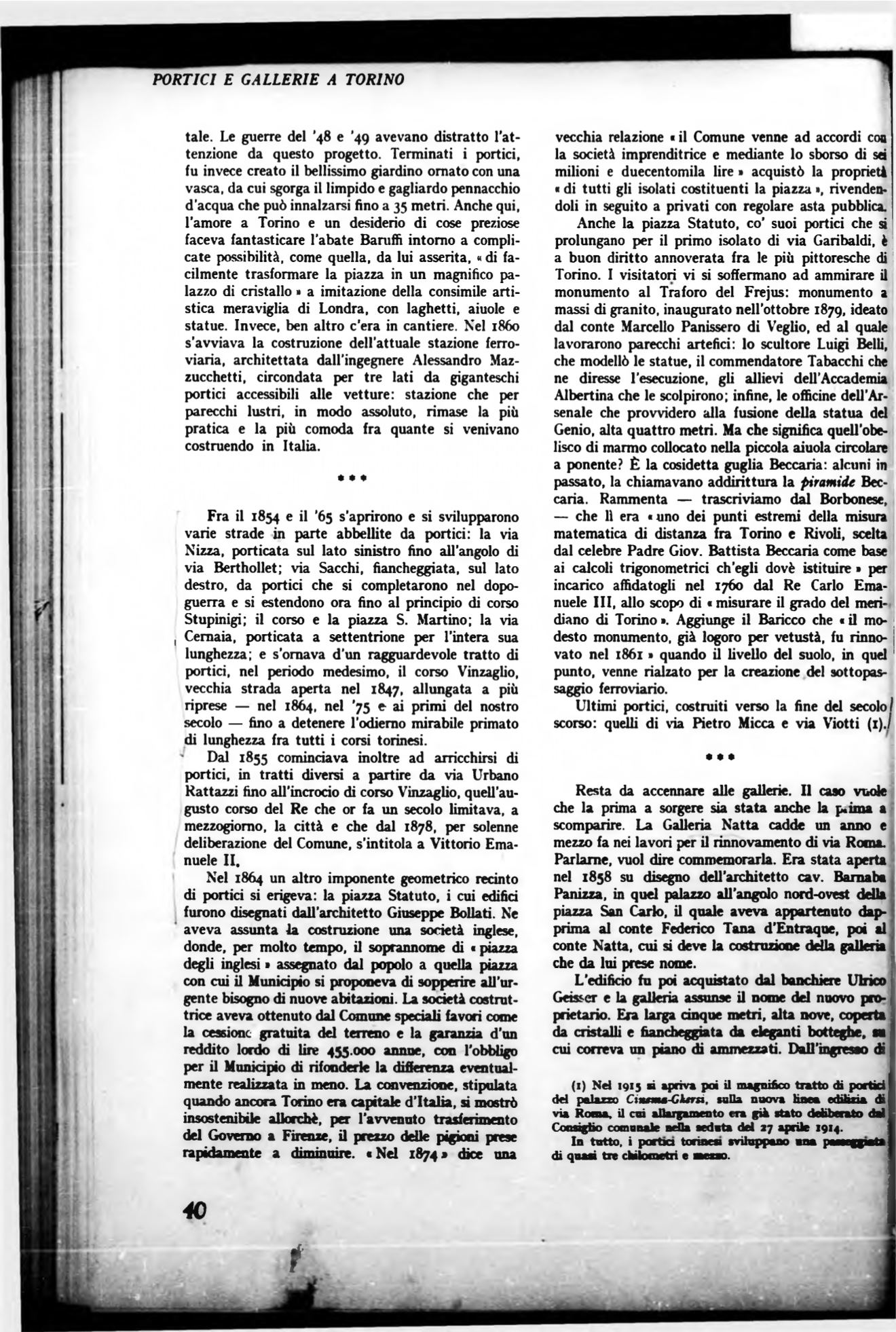
PORTICI E GALLERIE A TORINO
tale. Le guerre del '48 e '49 avevano distratto l'at
tenzione da questo progetto. Terminati i portici,
fu invece creato il bellissimo giardino ornato con una
vasca, da cui sgorga il limpido e gagliardo pennacchio
d'acqua che può innalzarsi fino a 35 metri. Anche qui,
l’amore a Torino e un desiderio di cose preziose
faceva fantasticare l’abate Baruffi intorno a compli
cate possibilità, come quella, da lui asserita, «di fa
cilmente trasformare la piazza in un magnifico pa
lazzo di cristallo » a imitazione della consimile arti
stica meraviglia di Londra, con laghetti, aiuole e
statue. Invece, ben altro c'era in cantiere. Nel 1860
s’avviava la costruzione dell’attuale stazione ferro
viaria, architettata dall’ingegnere Alessandro Maz-
zucchetti, circondata per tre lati da giganteschi
portici accessibili alle vetture: stazione che per
parecchi lustri, in modo assoluto, rimase la più
pratica e la più comoda fra quante si venivano
costruendo in Italia.
* * *
Fra il 1854 e il '65 s’aprirono e si svilupparono
varie strade in parte abbellite da portici: la via
Nizza, porticata sul lato sinistro fino all’angolo di
via Berthollet; via Sacchi, fiancheggiata, sul lato
destro, da portici che si completarono nel dopo
guerra e si estendono ora fino al principio di corso
Stupinigi; il corso e la piazza S. Martino; la via
, Cemaia, porticata a settentrione per l ’intera sua
lunghezza; e s’ornava d’un ragguardevole tratto di
portici, nel periodo medesimo, il corso Vinzaglio,
vecchia strada aperta nel 1847, allungata a più
riprese — nel 1864, nel '75 e ai primi del nostro
secolo — fino a detenere l ’odierno mirabile primato
di lunghezza fra tutti i corsi torinesi.
Dal 1855 cominciava inoltre ad arricchirsi di
portici, in tratti diversi a partire da via Urbano
Rattazzi fino airincrocio di corso Vinzaglio, quell’au
gusto corso del Re che or fa un secolo limitava, a
mezzogiorno, la città e che dal 1878, per solenne
deliberazione del Comune, s’intitola a Vittorio Ema
nuele II,
Nel 1864 un altro imponente geometrico recinto
di portici si erigeva: la piazza Statuto, i cui edifici
furono disegnati dall’architetto Giuseppe Bollati. Ne
aveva assunta la costruzione una società inglese,
donde, per molto tempo, il soprannome di «piazza
degli inglesi » assegnato dal popolo a quella piazza
con cui il Municipio si proponeva di sopperire all’ur
gente bisogno di nuove abitazioni. La società costrut
trice aveva ottenuto dal Comune speciali favori come
la cessione gratuita del terreno e la garanzia d’un
reddito lordo di lire 455.000 annue, con l’obbligo
per il Municipio di rifonderle la differenza eventual
mente realizzata in meno. La convenzione, stipulata
quando ancora Torino era capitale d’Italia, si mostrò
insostenibile allorché, per l'avvenuto trasferimento
del Governo a Firenze, il prezzo delle pigioni prese
rapidamente a diminuire. «Nel 1874» dice una
40
vecchia relazione «il Comune venne ad accordi con
la società imprenditrice e mediante lo sborso di sei
milioni e duecentomila lire » acquistò la proprietà
«di tutti gli isolati costituenti la piazza », rivenden
doli in seguito a privati con regolare asta pubblica.
Anche la piazza Statuto, co’ suoi portici che si
prolungano per il primo isolato di via Garibaldi, è
a buon diritto annoverata fra le più pittoresche di
Torino. I visitatori vi si soffermano ad ammirare il
monumento al Traforo del Frejus: monumento a
massi di granito, inaugurato nell'ottobre 1879, ideato
dal conte Marcello Panissero di Veglio, ed al quale
lavorarono parecchi artefici: lo scultore Luigi Belli,
che modellò le statue, il commendatore Tabacchi che
ne diresse l ’esecuzione, gli allievi deU’Accademia
Albertina che le scolpirono; infine, le officine dell’Ar-
senale che provvidero alla fusione della statua del
Genio, alta quattro metri. Ma che significa quell’obe
lisco di marmo collocato nella piccola aiuola circolare
a ponente? È la cosidetta guglia Beccaria: alcuni in
passato, la chiamavano addirittura la
piramide
Bec
caria. Rammenta — trascriviamo dal Borbonese,
— che lì era «uno dei punti estremi della misura
matematica di distanza fra Torino e Rivoli, scelta
dal celebre Padre Giov. Battista Beccaria come base
ai calcoli trigonometrici ch’egli dovè istituire » per
incarico affidatogli nel 1760 dal Re Carlo Ema
nuele III, allo scopo di «misurare il grado del meri
diano di Torino». Aggiunge il Baricco che «il mo
desto monumento, già logoro per vetustà, fu rinno
vato nel 1861 » quando il livello del suolo, in quel
punto, venne rialzato per la creazione del sottopas
saggio ferroviario.
Ultimi portici, costruiti verso la fine del secolo/
scorso: quelli di via Pietro Micca e via Viotti (1)./
• * *
Resta da accennare alle gallerie. Il caso vuole
che la prima a sorgere sia stata anche la p»ima a
scomparire. La Galleria Natta cadde un anno e
mezzo fa nei lavori per il rinnovamento di via Roma.
Parlarne, vuol dire commemorarla. Era stata aperta
nel 1858 su disegno dell’architetto cav. Barnaba
Panizza, in quel palazzo all’angolo nord-ovest della
piazza San Carlo, il quale aveva appartenuto dap
prima al conte Federico Tana d’Entraque, poi al
conte Natta, cui si deve la costruzione della galleria
che da lui prese nome.
L ’edificio fu poi acquistato dal banchiere Ulrico
Geisser e la galleria assunse il nome del nuovo pro
prietario. Era larga cinque metri, alta nove, coperta
da cristalli e fiancheggiata da eleganti botteghe, su
cui correva un piano di ammezzati. Dall’ingresso di
(1)
Nel
1915
si apriva pei il magnifico tratto di portici
del palazzo
Ciwnma-Gkrsi,
sulla nuova linea edilizia
di
via Roma, il cui allargamento era già stato deliberato
dal
Consiglio comunale nella seduta del
27
aprile
1914
.
In tutto, i portici torinesi sviluppano una pasteggiata
di quasi tre chilometri e mezzo.
t
■-


















