
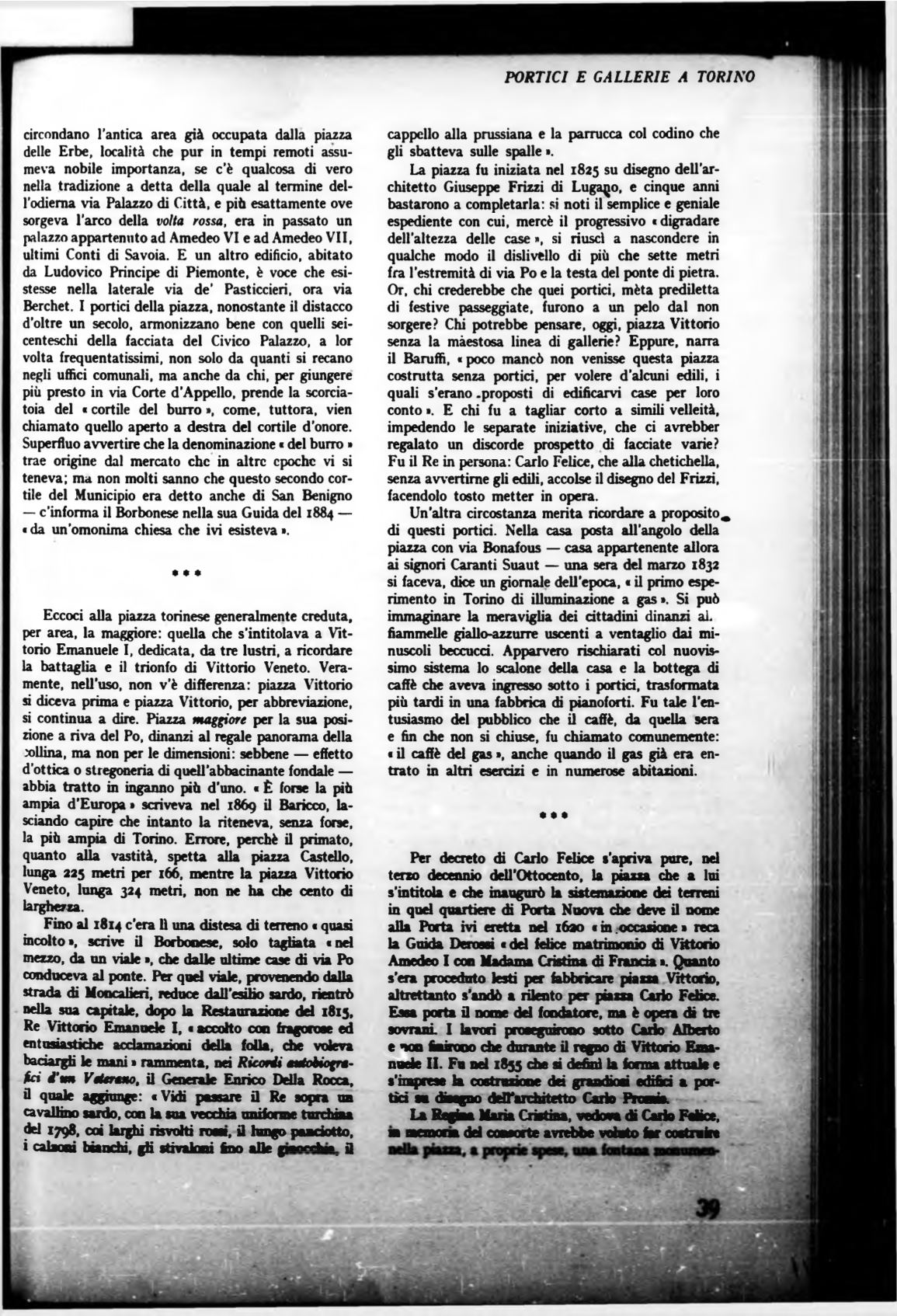
PORTICI E GALLERIE A TORINO
circondano l’antica area già occupata dalla piazza
delle Erbe, località che pur in tempi remoti assu
meva nobile importanza, se c’è qualcosa di vero
nella tradizione a detta della quale al termine del
l'odierna via Palazzo di Città, e più esattamente ove
sorgeva l ’arco della
volta rossa,
era in passato un
palazzo appartenuto ad Amedeo VI e ad Amedeo VII,
ultimi Conti di Savoia. E un altro edifìcio, abitato
da Ludovico Principe di Piemonte, è voce che esi
stesse nella laterale via de’ Pasticcieri, ora via
Berchet. I portici della piazza, nonostante il distacco
d’oltre un secolo, armonizzano bene con quelli sei
centeschi della facciata del Civico Palazzo, a lor
volta frequentatissimi, non solo da quanti si recano
negli uffici comunali, ma anche da chi, per giungere
più presto in via Corte d’Appello, prende la scorcia
toia del «cortile del burro », come, tuttora, vien
chiamato quello aperto a destra del cortile d ’onore.
Superfluo avvertire che la denominazione «del burro »
trae origine dal mercato chc in altre cpochc vi si
teneva; ma non molti sanno che questo secondo cor
tile del Municipio era detto anche di San Benigno
— c ’informa il Borbonese nella sua Guida del 1884 —
«da un’omonima chiesa che ivi esisteva ».
• * *
Eccoci alla piazza torinese generalmente creduta,
per area, la maggiore: quella che s’intitolava a Vit
torio Emanuele I, dedicata, da tre lustri, a ricordare
la battaglia e il trionfo di Vittorio Veneto. Vera
mente, nell’uso, non v ’è differenza: piazza Vittorio
si diceva prima e piazza Vittorio, per abbreviazione,
si continua a dire. Piazza
maggiore
per la sua posi
zione a riva del Po, dinanzi al regale panorama della
collina, ma non per le dimensioni: sebbene — effetto
d’ottica o stregoneria di quell’abbacinante fondale —
abbia tratto in inganno più d’uno. «È forse la più
ampia d’Europa » scriveva nel 1869 il Baricco, la
sciando capire che intanto la riteneva, senza forse,
la più ampia di Torino. Errore, perchè il primato,
quanto alla vastità, spetta alla piazza Castello,
lunga 225 metri per 166, mentre la piazza Vittorio
Veneto, lunga 324 metri, non ne ha che cento di
larghezza.
Fino al 1814 c’era
1
una distesa di terreno «quasi
incolto», scrive il Borbonese, solo tagliata «nel
mezzo, da un viale », che dalle ultime case di via Pò
conduceva al ponte. Per quel viale, provenendo dalla
strada di Moncalieri, reduce dall’esilio sardo, rientrò
nella sua capitale, dopo la Restaurazione del 1815,
Re Vittorio Emanuele I, <accolto con fragorose od
entusiastiche acclamazioni ddla folla, che voleva
baciargli le mani »rammenta, nd
Ricordi autobiogra
fici d’tm Veterano,
il Generale Enrico Ddla Rocca,
Q quale aggiunge: «Vidi passare il Re sopra un
cavallino sardo, con la sua vecchia uniforme turchina
dd 1798, coi larghi risvolti man, il lungo panciotto,
i calzoni bianchi, gli stivaloni fino alle p»*»*»». il
cappello alla prussiana e la parrucca col codino che
gli sbatteva sulle spalle ».
La piazza fu iniziata nel 1825 su disegno dell’ar
chitetto Giuseppe Frizzi di Lugano, e cinque anni
bastarono a completarla: si noti il semplice e geniale
espediente con cui, mercè il progressivo «digradare
dell’altezza delle case », si riuscì a nascondere in
qualche modo il dislivdlo di più che sette metri
fra l’estremità di via Po e la testa del ponte di pietra.
Or, chi crederebbe che quei portici, mèta prediletta
di festive passeggiate, furono a un pelo dal non
sorgere? Chi potrebbe pensare, oggi, piazza Vittorio
senza la màestosa linea di gallerie? Eppure, narra
il Baruffi, «poco mancò non venisse questa piazza
costrutta senza portid, per volere d ’alcuni edili, i
quali s’erano .proposti di edificarvi case per loro
conto ». E chi fu a tagliar corto a simili velleità,
impedendo le separate iniziative, che ci avrebber
regalato un discorde prospetto di facciate varie?
Fu il Re in persona: Carlo Felice, che alla chetichella,
senza avvertirne gli edili, accolse il disegno del Frizzi,
facendolo tosto metter in opera.
Un’altra circostanza merita ricordare a proposito
m
di questi portici. Nella casa posta all’angolo della
piazza con via Bonafous — casa appartenente allora
ai signori Caranti Suaut — una sera del marzo 1832
si faceva, dice un giornale dell’epoca, «il primo espe
rimento in Torino di illuminazione a gas». Si può
immaginare la meraviglia dei dttadini dinanzi al.
fiammelle giallo-azzurre uscenti a ventaglio dai mi
nuscoli beccucd. Apparvero rischiarati col nuovis
simo sistema lo scalone della casa e la bottega di
caffè che aveva ingresso sotto i portid, trasformata
più tardi in una fabbrica di pianoforti. Fu tale l ’en
tusiasmo del pubblico che Ù caffè, da quella sera
e fin che non si chiuse, fu chiamato comunemente:
«il caffè dd gas », anche quando il gas già era en
trato in altri esercizi e in numerose abitazioni.
• • •
Per decreto di Carlo Felice s’apriva pure, nd
terzo decennio dell’Ottocento, la piazza che a lui
s’intitola e die inaugurò la sistemazione dd terreni
in quel quartiere di Porta Nuova che deve il nome
alla Porta ivi eretta nd 1620 «in .occasione ■reca
la Guida Derossi ■ dd felice matrimonio di Vittorio
Amedeo I con Madama Cristina di Francia ». Quanto
s’era proceduto lesti per fabbricare piana Vittorio,
altrettanto s’andò a rilento per piana Cario Felice.
Essa porta il nome dd fondatore, ma è opera di tre
sovrani I lavori proseguirono sotto Cario Alberto
e non finirono die dorante il ragno di Vittorio Ema
nuele II. Fu nd 1855 che si definì la forma attuale e
s’imprese la costruzione dd grandiosi edifici a por
titi su disegno dell'architetto Cario Premia.
La Regina Maria Cristina, vedova di Cario Felice,
m memoria dd consorte avrebbe voluto far costruire


















