
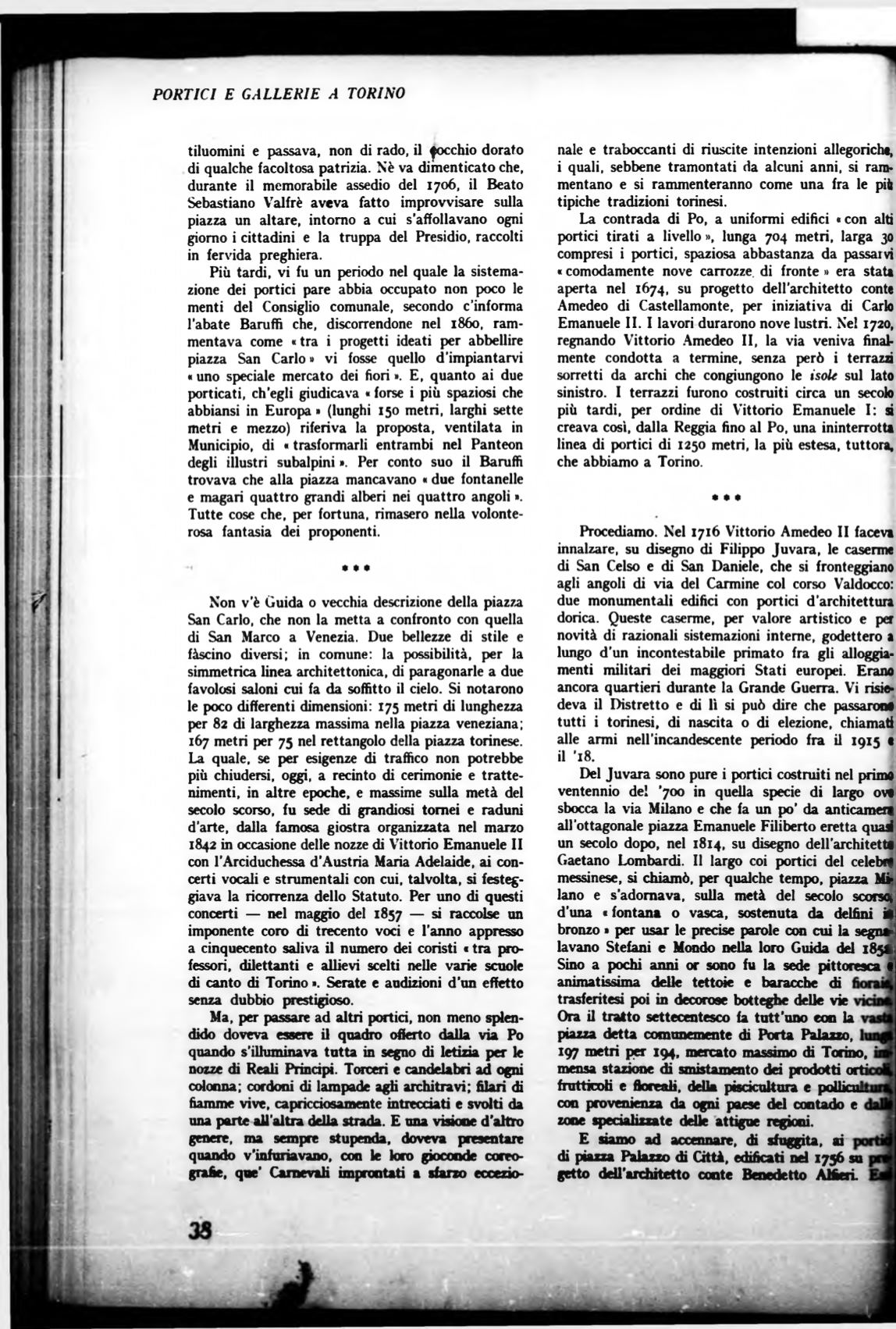
PORTICI E GALLERIE A TORINO
tiluomini e passava, non di rado, il ^occhio dorato
di qualche facoltosa patrizia. Nè va dimenticato che,
durante il memorabile assedio del 1706, il Beato
Sebastiano Valfrè aveva fatto improvvisare sulla
piazza un altare, intorno a cui s’affollavano ogni
giorno i cittadini e la truppa del Presidio, raccolti
in fervida preghiera.
Più tardi, vi fu un periodo nel quale la sistema
zione dei portici pare abbia occupato non poco le
menti del Consiglio comunale, secondo c’informa
l’abate Baruffi che, discorrendone nel 1860, ram
mentava come «tra i progetti ideati per abbellire
piazza San Carlo» vi fosse quello d'impiantarvi
«uno speciale mercato dei fiori ». E, quanto ai due
porticati, ch’egli giudicava «forse i più spaziosi che
abbiansi in Europa » (lunghi 150 metri, larghi sette
metri e mezzo) riferiva la proposta, ventilata in
Municipio, di «trasformarli entrambi nel Panteon
degli illustri subalpini ». Per conto suo il Baruffi
trovava che alla piazza mancavano «due fontanelle
e magari quattro grandi alberi nei quattro angoli ».
Tutte cose che, per fortuna, rimasero nella volonte
rosa fantasia dei proponenti.
* * *
Non v ’è Guida 0 vecchia descrizione della piazza
San Carlo, che non la metta a confronto con quella
di San Marco a Venezia. Due bellezze di stile e
fàscino diversi; in comune: la possibilità, per la
simmetrica linea architettonica, di paragonarle a due
favolosi saloni cui fa da soffitto il cielo. Si notarono
le poco differenti dimensioni: 175 metri di lunghezza
per 82 di larghezza massima nella piazza veneziana;
167 metri per 75 nel rettangolo della piazza torinese.
La quale, se per esigenze di traffico non potrebbe
più chiudersi, oggi, a recinto di cerimonie e tratte
nimenti, in altre epoche, e massime sulla metà del
secolo scorso, fu sede di grandiosi tornei e raduni
d’arte, dalla famosa giostra organizzata nel marzo
1842 in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele II
con l 'Arciduchessa d’Austria Maria Adelaide, ai con
certi vocali e strumentali con cui, talvolta, si festeg
giava la ricorrenza dello Statuto. Per uno di questi
concerti — nel maggio del 1857 — si raccolse un
imponente coro di trecento voci e l'anno appresso
a cinquecento saliva il ninnerò dei coristi «tra pro
fessori, dilettanti e allievi scelti nelle varie scuole
di canto di Torino ». Serate e audizioni d'un effetto
senza dubbio prestigioso.
Ma, per passare ad altri portici, non meno splen
dido doveva essere il quadro offerto dalla via Po
quando s'illuminava tutta in segno di letizia per le
nozze di Reali Principi. Torceri e candelabri ad ogni
colonna; cordoni di lampade agli architravi; filari di
fiamme vive, capricciosamente intrecciati e svolti da
una parte all’altra della strada. E una visione d’altro
genere, ma sempre stupenda, doveva presentare
quando v ’infuriavano, con le loro gioconde coreo
grafie, que’ Carnevali improntati a sfarzo eccezio
nale e traboccanti di riuscite intenzioni allegoriche,
i quali, sebbene tramontati da alcuni anni, si rara*
mentano e si rammenteranno come una fra le più
tipiche tradizioni torinesi.
La contrada di Po, a uniformi edifìci «con alti
portici tirati a livello », lunga 704 metri, larga 30
compresi i portici, spaziosa abbastanza da passarvi
«comodamente nove carrozze, di fronte » era stata
aperta nel 1674, su progetto dell’architetto conte
Amedeo di Castellamonte, per iniziativa di Carlo
Emanuele I I .I lavori durarono nove lustri. Nel 1720,
regnando Vittorio Amedeo II, la via veniva final
mente condotta a termine, senza però i terrazzi
sorretti da archi che congiungono le
isole
sul lato
sinistro. I terrazzi furono costruiti circa un secolo
più tardi, per ordine di Vittorio Emanuele I; si
creava così, dalla Reggia fino al Po, una ininterrotta
linea di portici di 1250 metri, la più estesa, tuttora,
che abbiamo a Torino.
• * *
Procediamo. Nel 1716 Vittorio Amedeo II faceva
innalzare, su disegno di Filippo Juvara, le caserme
di San Celso e di San Daniele, che si fronteggiano
agli angoli di via del Carmine col corso Valdocco:
due monumentali edifici con portici d ’architettura
dorica. Queste caserme, per valore artistico e per
novità di razionali sistemazioni interne, godettero a
lungo d ’un incontestabile primato fra gli alloggia
menti militari dei maggiori Stati europei. Erano
ancora quartieri durante la Grande Guerra. Vi risie*
deva il Distretto e di lì si può dire che passarono
tutti i torinesi, di nascita o di elezione, chiamati
alle armi nell’incandescente periodo fra il 1915
il ’i8.
Del Juvara sono pure i portici costruiti nel primo
ventennio de! '700 in quella specie di largo ovt
sbocca la via Milano e che fa un po’ da anticamera
all’ottagonale piazza Emanuele Filiberto eretta quasi
un secolo dopo, nel 1814, su disegno dell’architetto
Gaetano Lombardi. Il largo coi portici del celebri
messinese, si chiamò, per qualche tempo, piazza Mi»
lano e s'adornava, sulla metà del secolo scorso
d’una • fontana o vasca, sostenuta da delfini fe
bronzo » per usar le precise parole con cui la segna»
lavano Stefani e Mondo nella loro Guida del 1851
Sino a pochi anni or sono fu la sede pittoresca «
animatissima delle tettoie e baracche di
trasferitesi poi in decorose botteghe delle vie '
Ora il tratto settecentesco fa tu tt’uno con la
piazza detta comunemente di Porta Palazzo,
197 metri per 194, mercato massimo di Torino, *
mensa stazione di smistamento dei prodotti orti
frutticoli e floreali, della piscicultura e palliai
con provenienza da ogni paese del contado e
zone specializzate delle attigue regioni.
E siamo ad accennare, di sfuggita, ai
di piazza Palazzo di Città, edificati nel 1736 su
getto dell’architetto conte Benedetto Alfieri.


















