
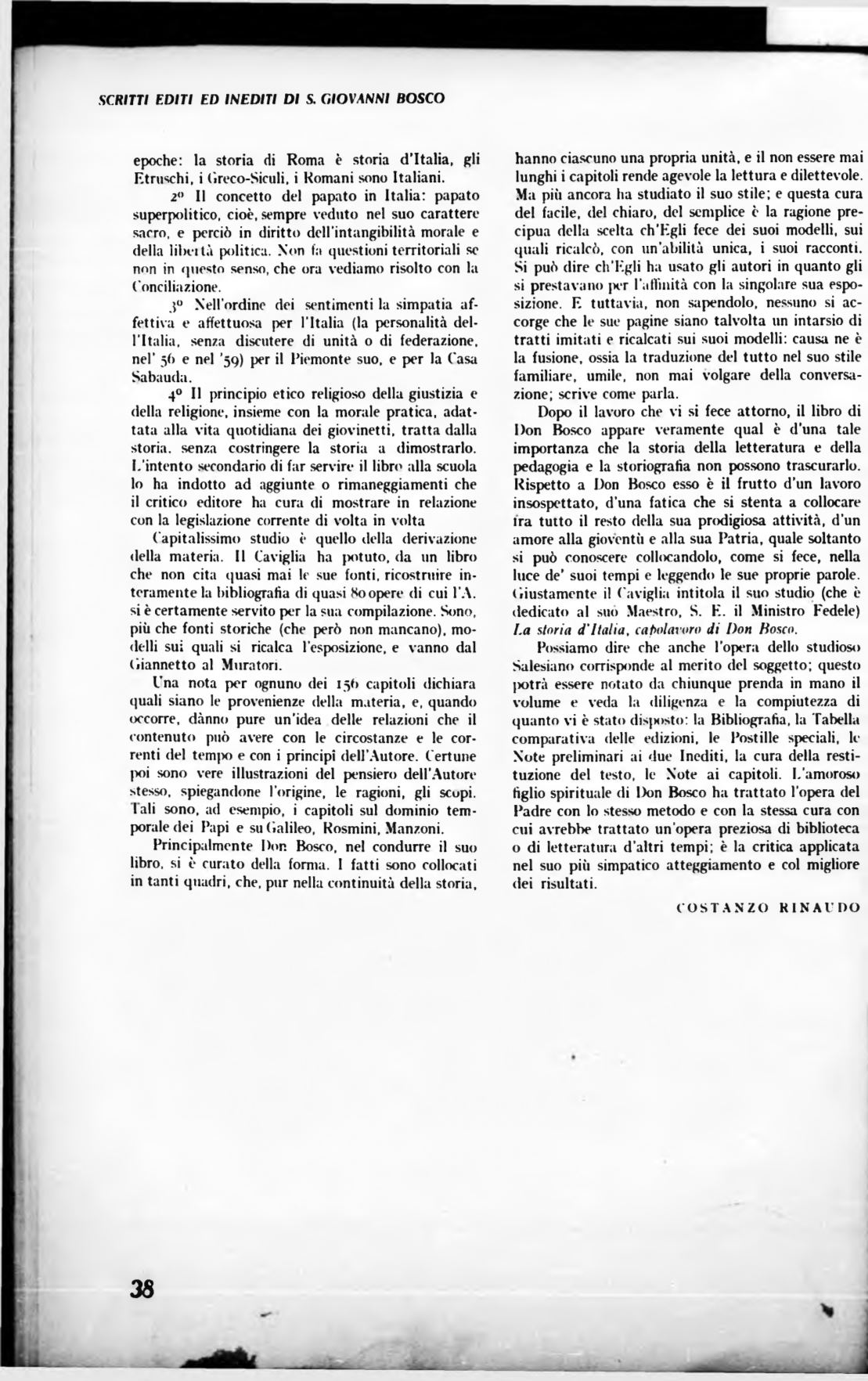
SCRITTI EDITI ED INEDITI DI S. GIOVANNI
BOSCO
epoche: la storia di Roma è storia d ’Italia, gli
Etruschi, i Greco-Siculi, i Romani sono Italiani.
2° Il concetto del papato in Italia: papato
superpolitico, cioè, sempre veduto nel suo carattere
sacro, e perciò in diritto dell’intangibilità morale e
della libei tà politica. Non fa questioni territoriali se
non in questo senso, che ora vediamo risolto con la
Conciliazione.
3° Nell'ordine dei sentimenti la simpatia af
fettiva e affettuosa per l’Italia (la personalità del
l'Italia, senza discutere di unità o di federazione,
nel’ 56 e nel *59) per il Piemonte suo, e per la Casa
Sabauda.
40 11 principio etico religioso della giustizia e
della religione, insieme con la morale pratica, adat
tata alla vita quotidiana dei giovinetti, tratta dalla
storia, senza costringere la storia a dimostrarlo.
L ’intento secondario di far servire il libre' alla scuola
10 ha indotto ad aggiunte o rimaneggiamenti che
11 critico editore ha cura di mostrare in relazione
con la legislazione corrente di volta in volta
Capitalissimo studio è quello della derivazione
della materia. Il Caviglia ha potuto, da un libro
che non cita quasi mai le sue fonti, ricostruire in
teramente la bibliografia di quasi 80opere di cui l’A.
si è certamente servito per la sua compilazione. Sono,
più che fonti storiche (che però non mancano), mo
delli sui quali si ricalca l’esposizione, e vanno dal
Giannetto al Muratori.
Una nota per ognuno dei 156 capitoli dichiara
quali siano le provenienze della materia, e, quando
occorre, dànno pure un’idea delle relazioni che il
contenuto può avere con le circostanze e le cor
renti del tempo e con i principi delI’Autore. Certune
poi sono vere illustrazioni del pensiero dell’Autore
stesso, spiegandone l’origine, le ragioni, gli scupi.
I ali sono, ad esempio, i capitoli sul dominio tem
porale dei Papi e su Galileo, Kosmini, Manzoni.
Principalmente Don Bosco, nel condurre il suo
libro, si è curato della forma. I fatti sono collocati
in tanti quadri, che, pur nella continuità della storia,
hanno ciascuno una propria unità, e il non essere mai
lunghi i capitoli rende agevole la lettura e dilettevole.
Ma più ancora ha studiato il suo stile; e questa cura
del facile, del chiaro, del semplice è la ragione pre
cipua della scelta ch’Egli fece dei suoi modelli, sui
quali ricalcò, con un’abilità unica, i suoi racconti.
Si può dire ch’Egli ha usato gli autori in quanto gli
si prestavano per l'affinità con la singolare sua espo
sizione. E tuttavia, non sapendolo, nessuno si ac
corge che le sue pagine siano talvolta un intarsio di
tratti imitati e ricalcati sui suoi modelli: causa ne è
la fusione, ossia la traduzione del tutto nel suo stile
familiare, umile, non mai volgare della conversa
zione; scrive come parla.
Dopo il lavoro che vi si fece attorno, il libro di
Don Bosco appare veramente qual è d’una tale
importanza che la storia della letteratura e della
pedagogia e la storiografia non possono trascurarlo.
Rispetto a Don Bosco esso è il frutto d’un lavoro
insospettato, d’una fatica che si stenta a collocare
ira tutto il resto della sua prodigiosa attività, d’un
amore alla gioventù e alla sua Patria, quale soltanto
si può conoscere collocandolo, come si fece, nella
luce de’ suoi tempi e leggendo le sue proprie parole.
Giustamente il Caviglia intitola il suo studio (che è
dedicato al suo Maestro, S. E. il Ministro Fedele)
La storia d'Italia, capolavoro di Don Bosco.
Possiamo dire che anche l’opera dello studioso
Salesiano corrisponde al merito del soggetto; questo
jx>trà essere notato da chiunque prenda in mano il
volume e veda la diligenza e la compiutezza di
quanto vi è stato disposto: la Bibliografia, la Tabella
comparativa delle edizioni, le Postille speciali, le
Note preliminari ai due Inediti, la cura della resti
tuzione del testo, le Note ai capitoli. L’amoroso
tìglio spirituale di Don Bosco ha trattato l’opera del
Padre con lo stesso metodo e con la stessa cura con
cui avrebbe trattato un’opera preziosa di biblioteca
o di letteratura d’altri tempi; è la critica applicata
nel suo più simpatico atteggiamento e col migliore
dei risultati.
C O S T A N Z O H I N A UDO
38


















