
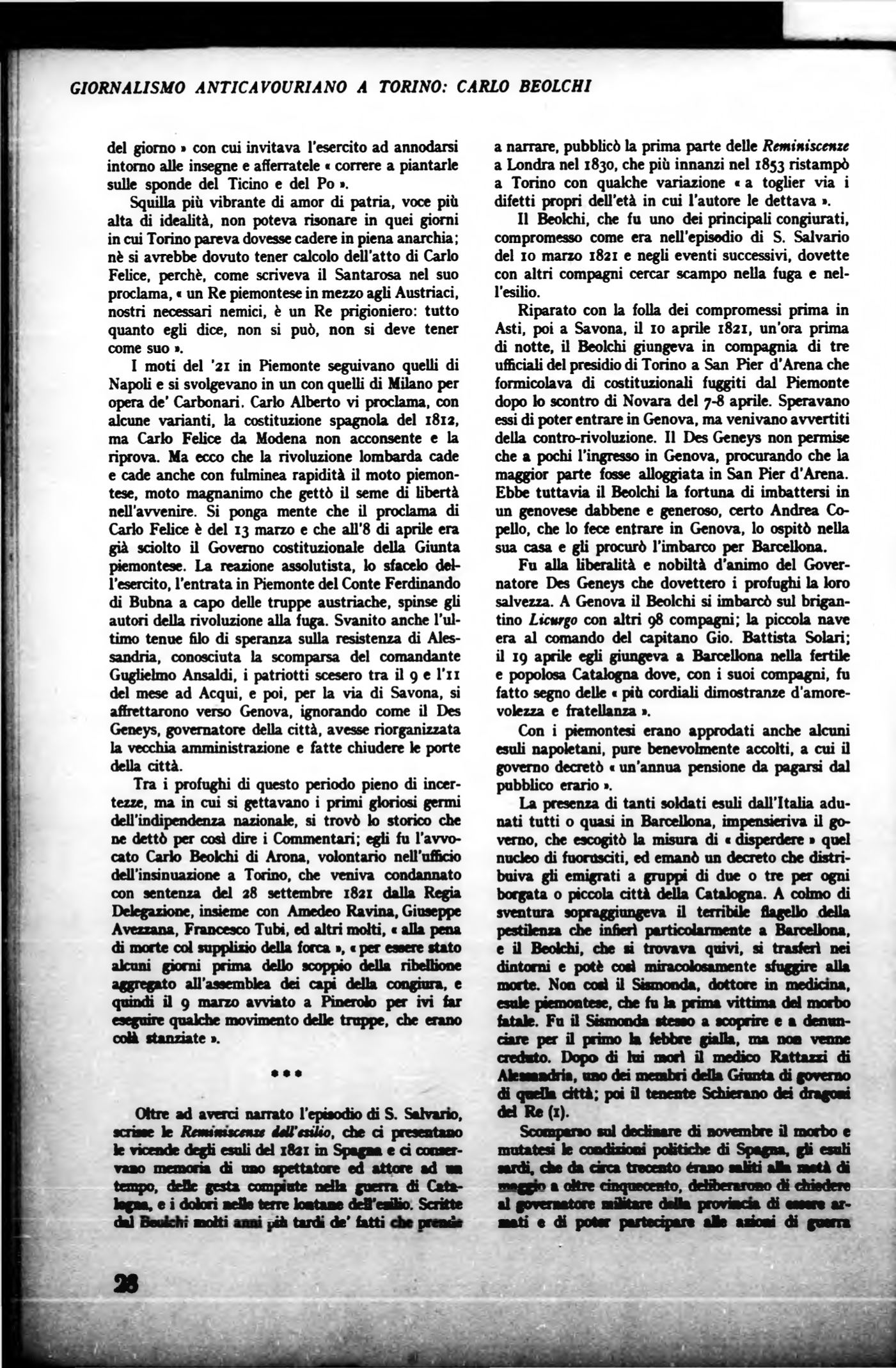
G IO R N A L I SM O A N T I C A V O U R I A N O A TO R INO : CARLO BEO LCH I
del giorno » con cui invitava l’esercito ad annodarsi
intorno alle insegne e afferratele «correre a piantarle
sulle sponde del Ticino e del Po ».
Squilla più vibrante di amor di patria, voce più
alta di idealità, non poteva risonare in quei giorni
in cui Torino pareva dovesse cadere in piena anarchia;
nè si avrebbe dovuto tener calcolo dell’atto di Carlo
Felice, perchè, come scriveva il Santarosa nel suo
proclama, «un Re piemontese in mezzo agli Austriaci,
nostri necessari nemici, è un Re prigioniero: tutto
quanto egli dice, non si può, non si deve tener
come suo ».
I
moti del ’2i in Piemonte seguivano quelli di
Napoli e si svolgevano in un con quelli di Milano per
opera de* Carbonari. Carlo Alberto vi proclama, con
alcune varianti, la costituzione spagnola del 1812,
ma Carlo Felice da Modena non acconsente e la
riprova. Ma ecco che la rivoluzione lombarda cade
e cade anche con fulminea rapidità il moto piemon
tese, moto magnanimo che gettò il seme di libertà
nell'avvenire. Si ponga mente che il proclama di
Carlo Felice è del 13 marzo e che all’8 di aprile era
già sciolto il Governo costituzionale della Giunta
piemontese. La reazione assolutista, lo sfacelo del
l’esercito, l ’entrata in Piemonte del Conte Ferdinando
di Bubna a capo delle truppe austriache, spinse gli
autori della rivoluzione alla fuga. Svanito anche l’ul
timo tenue filo di speranza sulla resistenza di Ales
sandria, conosciuta la scomparsa del comandante
Guglielmo Ansaldi, i patriotti scesero tra il 9 e l’u
del mese ad Acqui, e poi, per la via di Savona, si
affrettarono verso Genova, ignorando come il Des
Geneys, governatore della città, avesse riorganizzata
la vecchia amministrazione e fatte chiudere le porte
della città.
Tra i profughi di questo periodo pieno di incer
tezze, ma in cui si gettavano i primi gloriosi germi
dell’indipendenza nazionale, si trovò lo storico che
ne dettò per così dire i Commentari; egli fu l’avvo
cato Carlo Beokhi di Arona, volontario nell’ufficio
dell’insinuazione a Traino, che veniva condannato
con sentenza del 28 settembre 1821 dalla Regia
Delegazione, insieme con Amedeo Ravina, Giuseppe
Avezzana, Francesco Tubi, ed altri molti, «alla pena
di morte c d supplizio della forca », «per essere stato
alcuni giorni prima dello scoppio della ribellione
aggregato all’assemblea dei capi della congiura, e
quindi il 9 marzo avviato a Pinerolo per ivi far
eseguire qualche movimento delle troppe, che erano
colà stanziate >.
• • •
Oltre ad averci narrato l’episodio di S. Salvano,
scrisse le
Remmscetue idi'esilio,
che d presentano
le vicende degli esuli del 1821 in Spagna e d conser
vano memoria di nno spettatole ed attore ad va
tempo, delle gesta comprate nella guerra di Cata
logna, e i dolori nelle terre lontane defl'esflio. Scritte
-1 - 1
------ t A ? --------- • - ? * - A . - i » J - * l-A A *
----------
*
-
asu Pff/ivTff moni
utu u n ii oc utxxi
prvTMfv
a narrare, pubblicò la prima parte delle
Reminiscenze
a Londra nel 1830, che più innanzi nel 1853 ristampò
a Torino con qualche variazione « a toglier via i
difetti propri dell’età in cui l ’autore le dettava ».
Il
Beolchi, che fu uno dei principali congiurati,
compromesso come era nell’episodio di S. Salvario
del 10 marzo 1821 e negli eventi successivi, dovette
con altri compagni cercar scampo nella fuga e nel
l’esilio.
Riparato con la folla dei compromessi prima in
Asti, poi a Savona, il 10 aprile 1821, un’ora prima
di notte, il Beolchi giungeva in compagnia di tre
ufficiali del presidio di Torino a San Pier d’Arena che
formicolava di costituzionali fuggiti dal Piemonte
dopo lo scontro di Novara del 7-8 aprile. Speravano
essi di poter entrare in Genova, ma venivano avvertiti
della contro-rivoluzione. Il Des Geneys non permise
che a pochi l’ingresso in Genova, procurando che la
maggior parte fosse alloggiata in San Pier d ’Arena.
Ebbe tuttavia il Beolchi la fortuna di imbattersi in
un genovese dabbene e generoso, certo Andrea Co-
pello, che lo fece entrare in Genova, lo ospitò nella
sua casa e gli procurò l’imbarco per Barcellona.
Fu alla liberalità e nobiltà d’animo del Gover
natore Des Geneys che dovettero i profughi la loro
salvezza. A Genova il Beolchi si imbarcò sul brigan
tino
Licurgo
con altri 98 compagni; la piccola nave
era al comando del capitano Gio. Battista Solari;
il 19 aprile egli giungeva a Barcellona nella fertile
e popolosa Catalogna dove, con i suoi compagni, fu
fatto segno delle «più cordiali dimostranze d’amore
volezza e fratellanza ».
Con i piemontesi erano approdati anche alcuni
esuli napoletani, pure benevolmente accolti, a cui il
governo decretò «un’annua pensione da pagarsi dal
pubblico erario ».
La presenza di tanti soldati esuli dall’Italia adu
nati tutti o quasi in Barcellona, impensieriva il go
verno, che escogitò la misura di «disperdere » quel
nucleo di fuorusciti, ed emanò un decreto che distri
buiva gli emigrati a gruppi di due o tre per ogni
borgata o piccola rittà della Catalogna. A colmo di
sventura sopraggiungeva il terribile flagello della
pestilenza che infierì particolarmente a Barcellona,
e il Beolchi, che si trovava quivi, si trasferì nei
dintorni e potè cori miracolosamente sfuggire alla
morte. Non cori il Sismonda, dottore in mediana,
esule piemontese, che fu la prima vittima del morbo
fatale. Fn il Sismonda stesso a scoprire e a denun
ciare per il primo la febbre gialla, ma non venne
creduto. Dopo di lui morì il medico Rattazzi di
AirMandria, mio dei membri della Giunta di governo
di qaeOa dttà; poi il tenente Schierano dei dragoni
del Re (1).
Scomparso sul declinare di novembre il morbo e
mutatesi le condizioni politiche di Spagna, gli esali
sardi, die da circa trecento èrano saliti afla metà di
iM jpn a oltre cinquecento, deliberarono di chiedere
al governatore militare della provincia di essere ar
mati e di poter partecipare afle azioni di guerra
38


















