
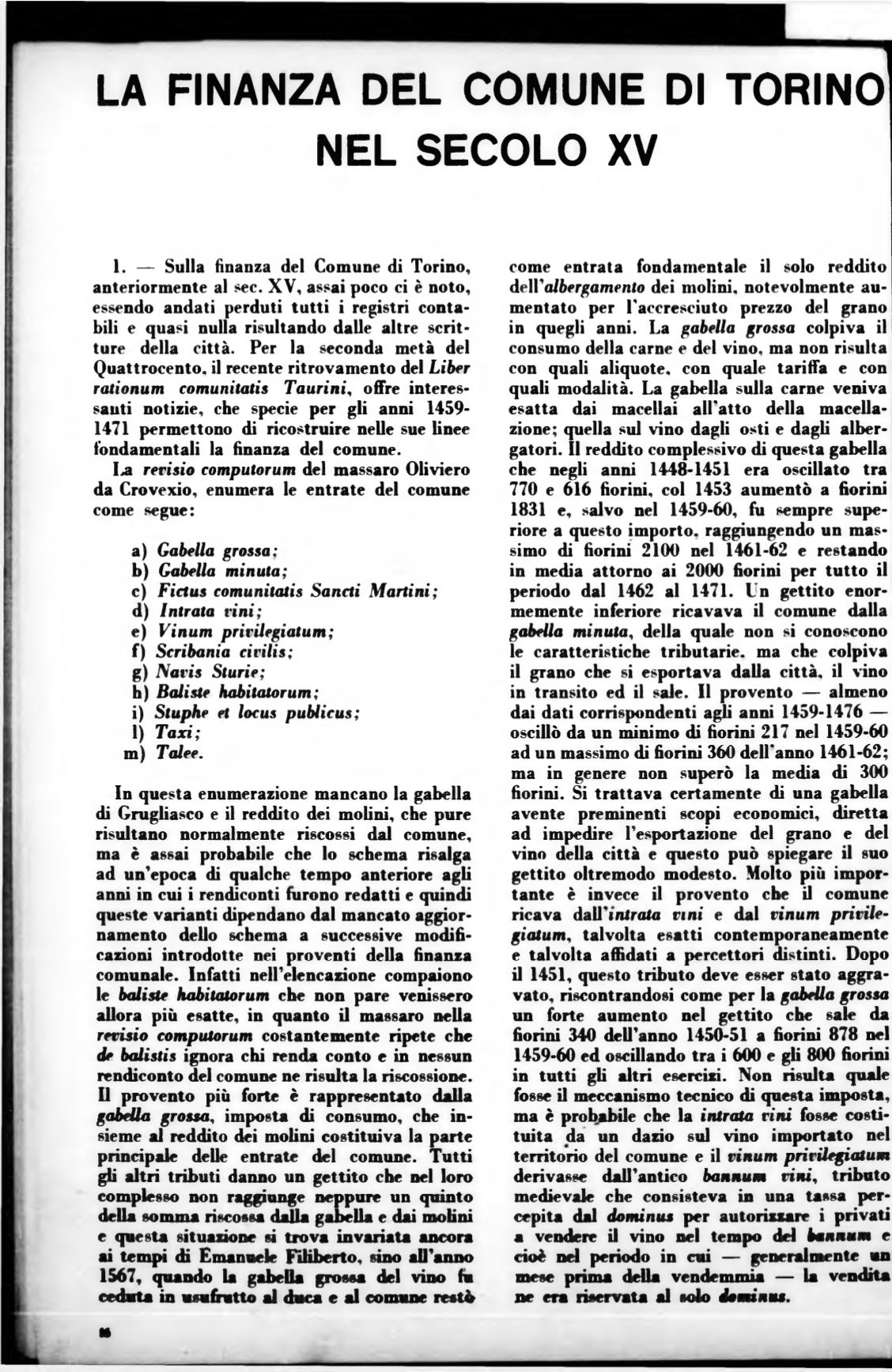
LA FINANZA DEL COMUNE DI TORINO
NEL SECOLO XV
1. — Sulla finanza del Comune dì Torino,
anteriormente al sec. XV, assai poco ci è noto,
essendo andati perduti tutti i registri conta
bili e quasi nulla risultando dalle altre scrit
ture della città. Per la seconda metà del
Quattrocento, il recente ritrovamento del
Liber
rationum comunitatis Taurini
, offre interes
santi notizie, che specie per gli anni 1459-
1471 permettono di ricostruire nelle sue linee
fondamentali la finanza del comune.
I>a
revisio computorum
del massaro Oliviero
da Crovexio, enumera le entrate del comune
come segue:
a)
Gabella grossa
:
b)
Gabella minuta;
c)
Fictus comunitatis Sancti Martini;
d)
Intrata vini;
e)
Vinum pririlegiatum;
f)
Scribania ci vilis;
g)
Navis Sturie;
h)
Baliste habitatorum;
i)
Stuphe et locus publicus;
1)
Taxi;
m)
Talee.
In questa enumerazione mancano la gabella
di Grugliasco e il reddito dei molini, che pure
risultano normalmente riscossi dal comune,
ma è assai probabile che lo schema risalga
ad un'epoca di qualche tempo anteriore agli
anni in cui i rendiconti furono redatti e quindi
queste varianti dipendano dal mancato aggior
namento dello schema a successive modifi
cazioni introdotte nei proventi della finanza
comunale. Infatti neirelencazione compaiono
le
baliste habitatorum
che non pare venissero
allora più esatte, in quanto il massaro nella
revisio computorum
costantemente ripete che
de balistis
ignora chi renda conto e in nessun
rendiconto del comune ne risulta la riscossione.
Il provento più forte è rappresentato dalla
gabella grossa
, imposta di consumo, che in
sieme al reddito dei molini costituiva la parte
principale delle entrate del comune. Tutti
gli altri tributi danno un gettito che nel loro
complesso non raggiunge neppure un quinto
della somma riscossa dalla gabella e dai molini
e questa situazione si trova invariata ancora
ai tempi di Emanuele Filiberto, sino all'anno
1567, quando la gabella grossa del vino fu
ceduta in usufrutto al duca e al comune restò
come entrata fondamentale il solo reddito
de\Valbergamelo
dei molini. notevolmente au
mentato per l'accresciuto prezzo del grano
in quegli anni. La
gabella grossa
colpiva il
consumo della carne e del vino, ma non risulta
con quali aliquote, con quale tariffa e con
quali modalità. La gabella sulla carne veniva
esatta dai macellai all'atto della macella
zione; quella sul vino dagli osti e dagli alber
gatori. Il reddito complessivo di questa gabella
che negli anni 1448-1451 era oscillato tra
770 e 616 fiorini, col 1453 aumentò a fiorini
1831 e, salvo nel 1459-60, fu sempre supe
riore a questo importo, raggiungendo un mas
simo di fiorini 2100 nel 1461-62 e restando
in media attorno ai
2000
fiorini per tutto il
periodo dal 1462 al 1471. Un gettito enor
memente inferiore ricavava il comune dalla
gabella minuta
, della quale non si conoscono
le caratteristiche tributarie, ma che colpiva
il grano che si esportava dalla città, il vino
in transito ed il sale. Il provento — almeno
dai dati corrispondenti agli anni 1459-1476 —
oscillò da un minimo di fiorini 217 nel 1459-60
ad un massimo di fiorini 360 dell'anno 1461-62;
ma in genere non superò la media di 300
fiorini. Si trattava certamente di una gabella
avente preminenti scopi economici, diretta
ad impedire l'esportazione del grano e del
vino della città e questo può spiegare il suo
gettito oltremodo modesto. Molto più impor
tante è invece il provento che il comune
ricava dall'mirala
vini
e dal
vinum privile
-
giatum
, talvolta esatti contemporaneamente
e talvolta affidati a percettori distinti. Dopo
il 1451, questo tributo deve esser stato aggra
vato, riscontrandosi come per la
gabella grossa
un forte aumento nel gettito che sale da
fiorini 340 dell'anno 1450-51 a fiorini 878 nel
1459-60 ed oscillando tra i 600 e gli 800 fiorini
in tutti gli altri esercizi. Non risulta quale
fosse il meccanismo tecnico di questa imposta,
ma è probabile che la
intrata vini
fosse costi
tuita da un dazio sul vino importato nel
territorio del comune e il
vinum privilegiatum
derivasse dall'antico
bannum vini
, tributo
medievale che consisteva in una tassa per
cepita dal
dominus
per autorizzare i privati
a vendere il vino nel tempo del
bannum
e
cioè nel periodo in cui — generalmente un
mese prima della vendemmia — la vendita
ne
era riservata al solo
dominus.
M


















