
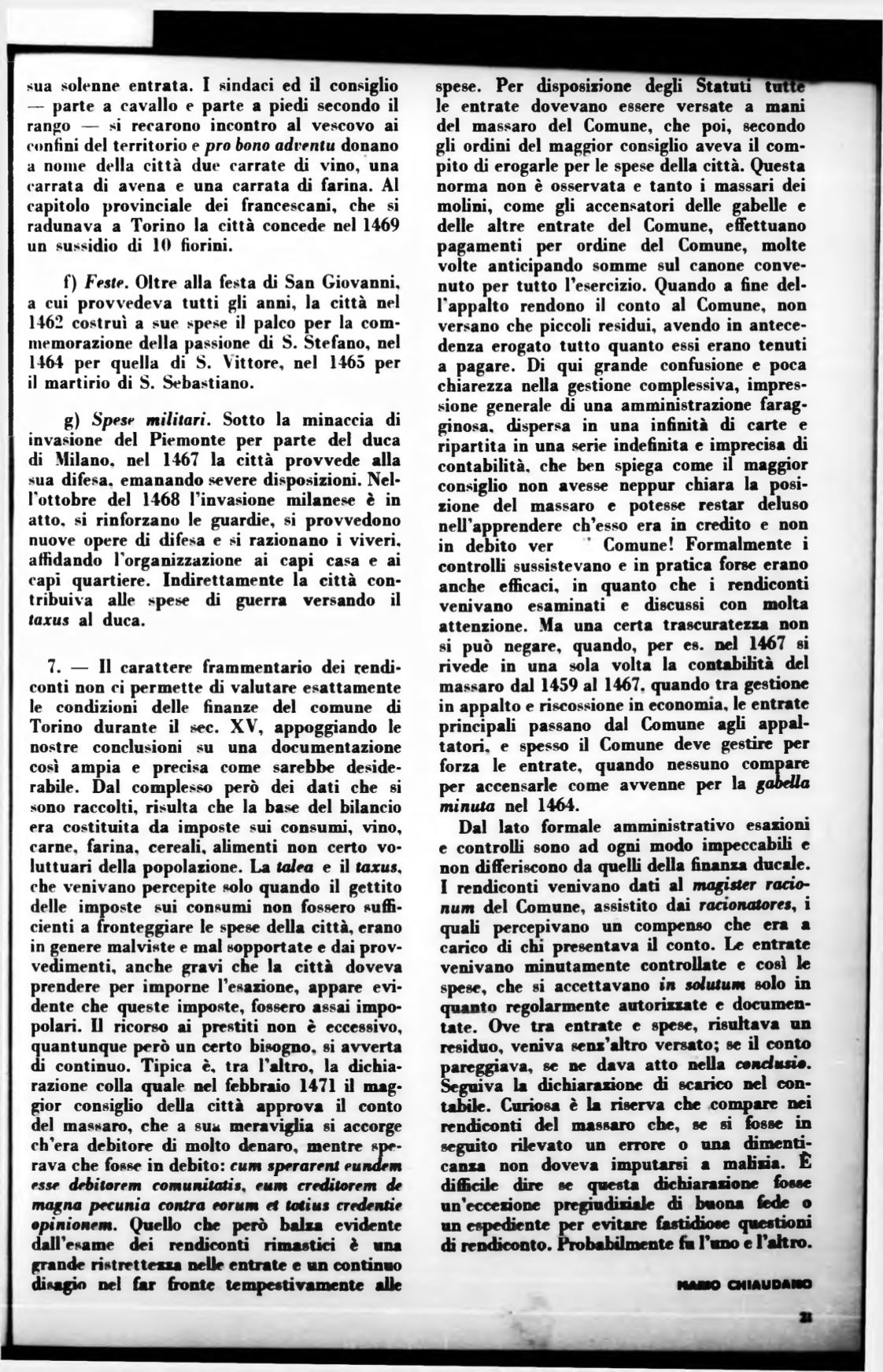
sua solenne entrata. I sindaci ed il consiglio
— parte a cavallo e parte a piedi secondo il
rango — si recarono incontro al vescovo ai
confini del territorio e
prò bono adventu
donano
a nome della città due carrate di vino, una
carrata di avena e una carrata di farina. Al
capitolo provinciale dei francescani, che si
radunava a Torino la città concede nel 1469
un sussidio di
10
fiorini.
f)
Feste.
Oltre alla festa di San Giovanni,
a cui provvedeva tutti gli anni, la città nel
1462 costruì a sue spese il palco per la com
memorazione della passione di S. Stefano, nel
1464 per quella di S. Vittore, nel 1465 per
il martirio di S. Sebastiano.
g)
Spese militari.
Sotto la minaccia di
invasione del Piemonte per parte del duca
di Milano, nel 1467 la città provvede alla
sua difesa, emanando severe disposizioni. Nel
l'ottobre del 1468 l'invasione milanese è in
atto, si rinforzano le guardie, si provvedono
nuove opere di difesa e si razionano i viveri,
affidando l'organizzazione ai capi casa e ai
capi quartiere. Indirettamente la città con
tribuiva alle spese di guerra versando il
taxus
al duca.
7.
— Il carattere frammentario dei rendi
conti non ci permette di valutare esattamente
le condizioni delle finanze del comune di
Torino durante il sec. XV, appoggiando le
nostre conclusioni su una documentazione
così ampia e precisa come sarebbe deside
rabile. Dal complesso però dei dati che si
sono raccolti, risulta che la base del bilancio
era costituita da imposte sui consumi, vino,
carne, farina, cereali, alimenti non certo vo
luttuari della popolazione. La
talea
e il
taxus
,
che venivano percepite solo quando il gettito
delle imposte sui consumi non fossero suffi
cienti a fronteggiare le spese della città, erano
in genere malviste e mal sopportate e dai prov
vedimenti, anche gravi che la città doveva
prendere per imporne l’esazione, appare evi
dente che queste imposte, fossero assai impo
polari. Il ricorso ai prestiti non è eccessivo,
quantunque però un certo bisogno, si avverta
di continuo. Tipica è, tra l'altro, la dichia
razione colla quale nel febbraio 1471 il mag
gior consiglio della città approva il conto
del massaro, che a sua meraviglia si accorge
ch'era debitore di molto denaro, mentre spe
rava che fosse in debito: rum
sperarent eundem
esse debitorem comunitatis
,
eum creditorem de
magna pecunia conira eorum et totius credentie
opinionem.
Quello che però balza evidente
dall'esame dei rendiconti rimastici è una
grande ristrettezza nelle entrate e un continuo
disagio nel far fronte tempestivamente alle
spese. Per disposizione degli StatutT tn
le entrate dovevano essere versate a mani
del massaro del Comune, che poi, secondo
gli ordini del maggior consiglio aveva il com
pito di erogarle per le spese della città. Questa
norma non
è
osservata e tanto i massari dei
molini, come gli accensatori delle gabelle e
delle altre entrate del Comune, effettuano
pagamenti per ordine del Comune, molte
volte anticipando somme sul canone conve
nuto per tutto l'esercizio. Quando a fine del
l'appalto rendono il conto al Comune, non
versano che piccoli residui, avendo in antece
denza erogato tutto quanto essi erano tenuti
a pagare. Di qui grande confusione e poca
chiarezza nella gestione complessiva, impres
sione generale di una amministrazione farag-
ginosa, dispersa in una infinità di carte e
ripartita in una serie indefinita e imprecisa di
contabilità, che ben spiega come il maggior
consiglio non avesse neppur chiara la posi
zione del massaro e potesse restar deluso
nell'apprendere ch'esso era in credito e non
in debito ver
Comune! Formalmente i
controlli sussistevano e in pratica forse erano
anche efficaci, in quanto che i rendiconti
venivano esaminati e discussi con molta
attenzione. Ma una certa trascuratezza non
si può negare, quando, per es. nel 1467 si
rivede in una sola volta la contabilità del
massaro dal 1459 al 1467. quando tra gestione
in appalto e riscossione in economia, le entrate
principali passano dal Comune agli appal
tatori. e spesso il Comune deve gestire per
forza le entrate, quando nessuno compare
per accensarle come avvenne per la
gabella
minuta
nel 1464.
Dal lato formale amministrativo esazioni
e controlli sono ad ogni modo impeccabili e
non differiscono da quelli della finanza ducale.
I rendiconti venivano dati al
magister rado
-
num
del Comune, assistito dai
racionatores
, i
quali percepivano un compenso che era a
carico di chi presentava il conto. Le entrate
venivano minutamente controllate e così le
spese, che si accettavano
in soluium
solo in
q u a n t o
regolarmente autorizzate e documen
tate. Ove tra entrate e spese, risultava un
residuo, veniva senz’altro versato; se il conto
pareggiava, se ne dava atto nella
condusio.
Seguiva la dichiarazione di scarico nel con
tabile. Curiosa è la riserva che compare nei
rendiconti del massaro che, se si fosse in
seguito rilevato un errore o una dimenti
canza non doveva imputarsi a malizia. È
difficile dire se questa dichiarazione fosse
un'eccezione pregiudiziale di buona fede o
un espediente per evitare fastidiose questioni
di rendiconto. Probabilmente fu l'uno e l'altro.
M A A IO C H IA U O A H O


















