
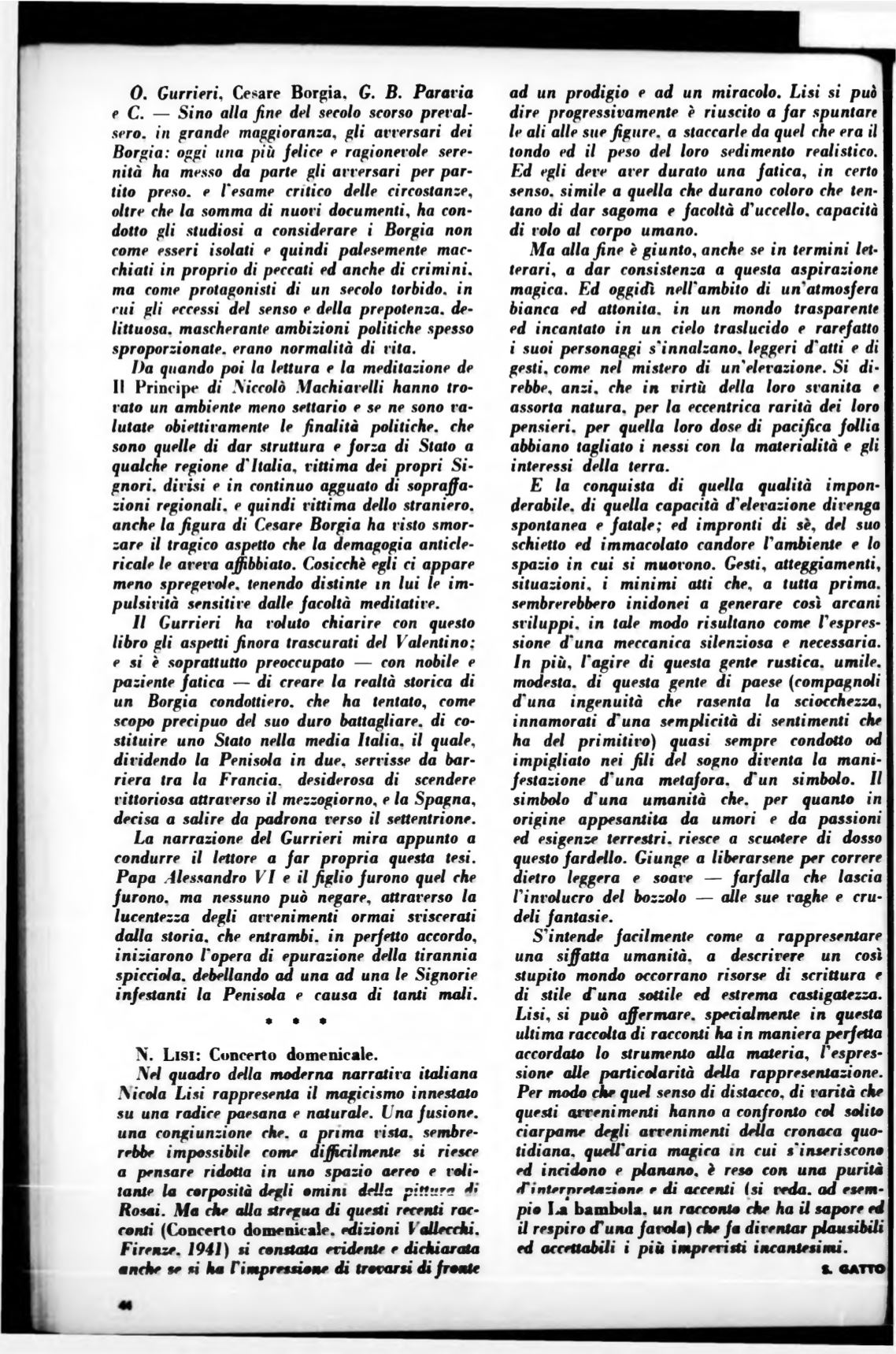
0 . Gurrieri,
Cesare Borgia,
G. B. Paravia
e C.
—
Sino
alla
fine del secolo scorso preval
sero. in grande maggioranza
,
gli avversari dei
Borgia: oggi una più felice e ragionevole sere
nità ha messo da parte gli avversari per par
tito preso, e l'esame critico delle circostanze
,
oltre che la somma di nuovi documenti, ha con
dotto gli studiosi a considerare i Borgia non
come esseri isolati e quindi palesemente mac
chiati in proprio di peccati ed anche di crimini,
ma come protagonisti di un secolo torbido, in
cui gli eccessi del senso e della prepotenza, de
littuosa. mascherante ambizioni politiche spesso
sproporzionate, erano normalità di vita.
Da quando poi la lettura e la meditazione de
Il Principe
di Niccolo Machiavelli hanno tro
vato un ambiente meno settario e se ne sono va
lutate obiettivamente le finalità politiche, che
sono quelle di dar struttura e forza di Stato a
qualche regione d'Italia
,
vittima dei propri Si
gnori. divisi e in continuo agguato di sopraffa
zioni regionali, e quindi vittima dello straniero,
anche la figura di Cesare Borgia ha visto smor
zare il tragico aspetto che la demagogia anticle
ricale le aveva affibbiato. Cosicché egli ci appare
meno spregevole, tenendo distinte in lui le im
pulsività sensitive dalle facoltà meditative.
Il
Gurrieri ha voluto chiarire con questo
libro gli aspetti finora trascurati del Valentino:
e si è soprattutto preoccupato
—
con nobile e
paziente fatica
—
di creare la realtà storica di
un Borgia condottiero
,
che ha tentato
,
come
scopo precipuo del suo duro battagliare, di co
stituire uno Stato nella media Italia, il quale,
dividendo la Penisola in due
,
servisse da bar
riera tra la Francia, desiderosa di scendere
vittoriosa attraverso il mezzogiorno, e la Spagna,
decisa a salire da padrona verso il settentrione.
La narrazione del Gurrieri mira appunto a
condurre il lettore a far propria questa tesi.
Papa Alessandro VI e il figlio furono quel che
furono, ma nessuno può negare
,
attraverso la
lucentezza degli avvenimenti ormai sviscerati
dalla storia, che entrambi, in perfetto accordo
,
iniziarono l'opera di epurazione della tirannia
spicciola, debellando ad una ad una le Signorie
infestanti la Penisola e causa di tanti mali.
• * *
N. Lisi: Concerto domenicale.
Nel quadro della moderna narrativa italiana
!\icola Lisi rappresenta il magicismo innestato
su una radice paesana e naturale. Una fusione,
una congiunzione che. a prima vista, sembre
rebbe impossibile come difficilmente si riesce
a pensare ridotta in uno spazio aereo e voli
tante la corposità degli omini della, pittar? 4*
Rosai. Ma che alla stregua di questi recenti rac
conti
(Concerto domenicale,
edizioni Vallecchi.
Firenze. 1941) si constata evidente e dichiarata
anche se si ha Vimpressione di trovarsi di fronte
ad un prodigio e ad un miracolo. Lisi si può
dire progressivamente è riuscito a far spuntare
le ali alle sue figure, a staccarle da quel che era il
tondo ed il peso del loro sedimento realistico.
Ed egli deve aver durato una fatica
,
in certo
senso, simile a quella che durano coloro che ten
tano di dar sagoma e facoltà d'uccello, capacità
di volo al corpo umano.
Ma alla fine è giunto, anche se in termini let
terari, a dar consistenza a questa aspirazione
magica. Ed oggidì nell'ambito di un atmosfera
bianca ed attonita, in un mondo trasparente
ed incantato in un cielo traslucido e rarefatto
i suoi personaggi s'innalzano, leggeri d'atti e di
gesti, come nel mistero di un'elevazione. Si di
rebbe,, anzi, che in virtù della loro svanita e
assorta natura, per la eccentrica rarità dei loro
pensieri, per quella loro dose di pacifica follia
abbiano tagliato i nessi con la materialità e gli
interessi della terra.
E la conquista di quella qualità impon
derabile. di quella capacità d'elevazione divenga
spontanea e fatale; ed impronti di
se,
del suo
schietto ed immacolato candore l'ambiente e lo
spazio in cui si muovono. Gesti
,
atteggiamenti,
situazioni, i minimi atti che
,
a tutta prima,
sembrerebbero inidonei a generare così arcani
sviluppi, in tale modo risultano come l'espres
sione d'una meccanica silenziosa e necessaria.
In più
,
l'agire di questa gente rustica, umile,
modesta, di questa gente di paese
(campagnoli
d'una ingenuità che rasenta la sciocchezza
,
innamorati d'una semplicità di sentimenti che
ha del primitivo) quasi sempre condotto od
impigliato nei fili del sogno diventa la mani
festazione d'una metafora, d'un simbolo. Il
simbolo d'una umanità che. per quanto in
origine appesantita da umori e da passioni
ed esigenze terrestri, riesce a scuotere di dosso
questo fardello. Giunge a liberarsene per correre
dietro leggera e soave
—
farfalla che lascia
l'involucro del bozzolo
—
alle sue vaghe e cru
deli fantasie.
S'intende facilmente come a rappresentare
una siffatta umanità, a descrivere un così
stupito mondo occorrano risorse di scrittura e
di stile d’una sottile ed estrema castigatezza.
Lisi
,
si può affermare, specialmente in questa
ultima raccolta di racconti ha in maniera perfetta
accordato lo strumento alla materia
,
l'espres
sione alle particolarità della rappresentazione.
Per modo che quel senso di distacco
,
di varità che
questi avvenimenti hanno a confronto col solito
ciarpame degli avvenimenti della cronaca quo
tidiana. quell'aria magica in cui s'inseriscono
ed incidono e planano, è reso con una purità
iT
i
nt*rprelazione e di accenti lsi veda, ad esem
pio
l a bambola,
un racconto che ha il sapore ed
il respiro
<f
una favola
)
che fa direntar plausibili
ed accettabili i più imprevisti incantesimi.
S. G A T TO


















