
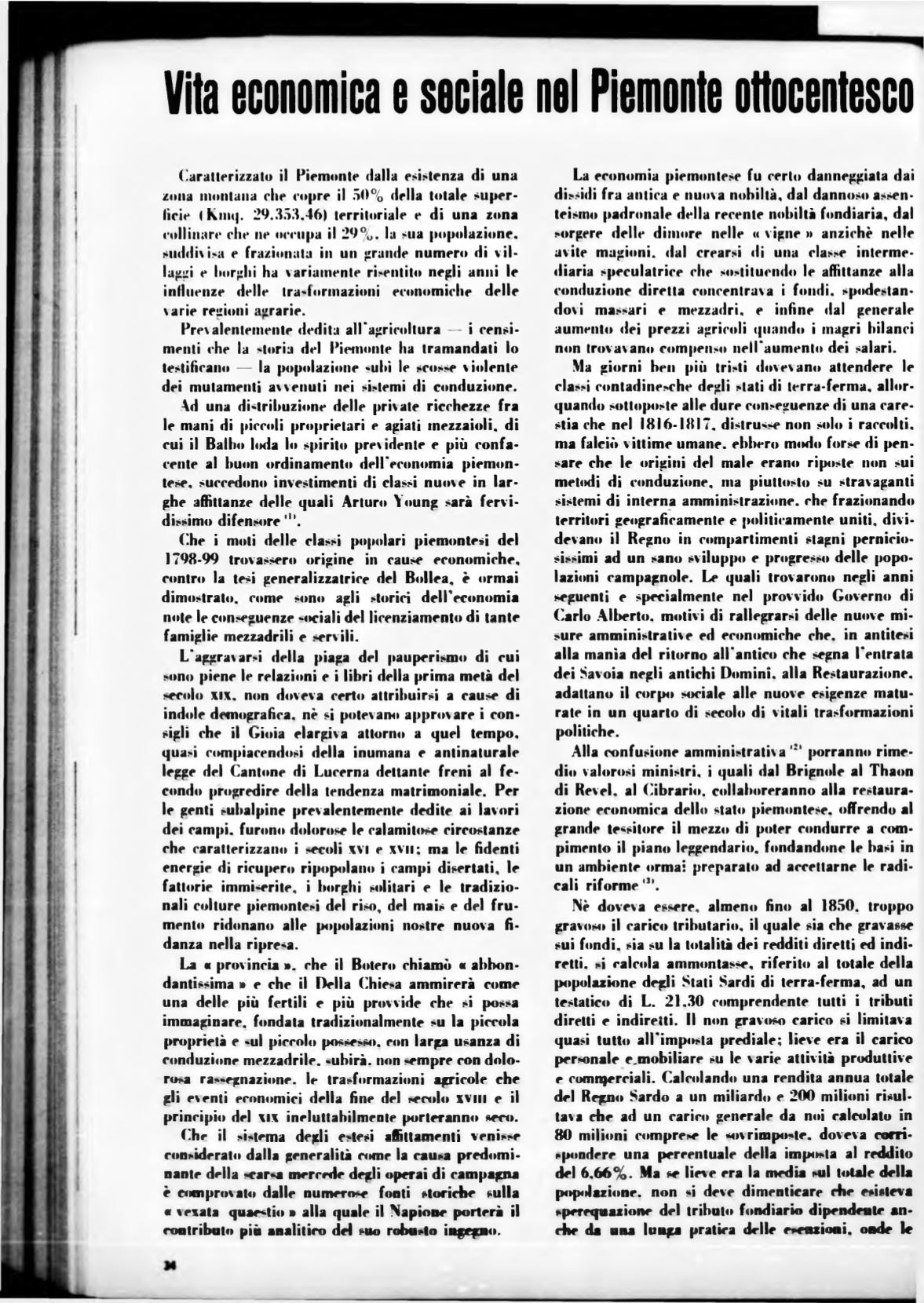
VitaeconomicaesocialoolPiemonteotocentesco
Caratterizzato il Piemonte dalla esistenza di una
zona montana che copre il 50% della totale super
fìcie <kmq. 29.353.46) territoriale e di una zona
collinare clic ne occupa il 29%. la Mia popolazione.
suddi\i.«a e frazionata in un grande numero di vil
la n i e (torelli ha variamente risentito negli anni le
influenze delle trasformazioni economiche delle
\arie regioni agrarie.
Prevalentemente dedita all'agricoltura — i censi
menti che la storia del Piemonte ha tramandati lo
testificano — la popolazione -ulti le scosse violente
dei mutamenti avvenuti nei sistemi di conduzione.
Ad una distribuzione delle primate ricchezze fra
le mani di piccoli proprietari e agiati inezzaioli. di
cui il Balbo loda lo spirito prendente e più confa
cente al buon ordinamento dell'economia piemon
tese, succedono investimenti di classi nuo\e in la r
ghe affittanze delle quali Arturo Young sarà fervi
dissimo difensore"’.
Che i moti delle classi popolari piemontesi del
1798-99 trovassero origine in cause economiche,
contro la tesi generaiizzatrice del Bollea, è ormai
dimostrato, come sono agli storici dell'economia
note le conseguenze -ociali del licenziamento di tante
famiglie mezzadrili e servili.
L'aggravarsi della piaga del pauperismo di cui
Mino piene le relazioni e i libri della prima metà del
secolo x i\. non doveva certo attribuirsi a cause di
indole demografica, nè si potevano approvare i con
sigli che il Gioia elargiva attorno a quel tempo,
quasi compiacendosi della inumana e antinaturale
legge del Cantone di Lucerna dettante freni al fe
condo progredire della tendenza matrimoniale. Per
le genti subalpine prevalentemente dedite ai lavori
dei campi, furono dolorose le calamitose circostanze
che caratterizzano i secoli xvt e xvii; ma le fidenti
energie di ricupero ripopolano i campi disertati, le
fattorie immiserite, i borghi solitari e le tradizio
nali colture piemontesi del riso, del mais e del f ru
mento ridonano alle popolazioni nostre nuova fi
danza nella ripresa.
La « provincia ». che il Bolero chiamò « abbon
dantissima » e che il Della Chiesa ammirerà come
una delle più fertili e più provvide che si possa
immaginare, fondata tradizionalmente su la piccola
proprietà e «ul piccolo possessi», con larga usanza di
conduzione mezzadrile, -ubirà. non sempre con dolo
rosa ras-egnazione. le trasformazioni agricole che
gli eventi economici della fine del secolo xviii e il
principio del xix ineluttabilmente porteranno seni.
Che il sistema degli estesi affinamenti venisse
considerato dalla generalità nmir la causa predomi
nante della <ir*a mercede degli operai di campagna
è comprovato dalle numerose fonti Mnrirbe sulla
• texata quaestio » alla quale il Napione porterà il
contributo più analitico del suo robusto ingegno.
La economia piemontese fu certo danneggiata dai
dividi fra antica e nuova nobiltà, dal dannoso assen
teismo padronale della recente nobiltà fondiaria, dal
sorgere delle dimore nelle « vigne » anziché nelle
avite magioni, dal crearsi di una classe interme
diaria speculatrice che sostituendo le affittanze alla
conduzione diretta concentrava i fondi, spodestan
dovi massari e mezzadri, e infine dal generale
aumento dei prezzi agricoli (piando i magri bilanci
non trovavano compenso iieH'aumenlo dei salari.
Ma giorni ben più tristi dovevano attendere le
classi contadinesche degli stati di terra-ferma, allor
quando sottoposte alle dure conseguenze di una care
stia che nel 1816-1817. distrusse non solo i raccolti,
ma falciò vittime umane, ebbero modo forse di pen
sare che le origini del male erano riposte non sui
metodi di conduzione, ma piuttosto su stravaganti
sistemi di interna amministrazione, che frazionando
territori geograficamente e politicamente uniti, divi
devano il Regno in compartimenti stagni pernicio
sissimi ad un sano sviluppo e progresso delle popo
lazioni campagnole. Le quali trovarono negli anni
seguenti e specialmente nel provvido Governo di
Carlo Alberto, motivi di rallegrarsi delle nuove mi
sure amministrative ed economiche che. in antitesi
alla manìa del ritorno all'antico che segna l'entrata
dei Savoia negli antichi Domini, alla Restaurazione,
adattano il corpo sociale alle nuove esigenze matu
rate in un quarto di secolo di vitali trasformazioni
politiche.
Alla confusione amministrativa <2>porranno rime
dio valorosi ministri, i quali dal Brignole al Thaon
di Revel. al Cibrario. collahoreranno alla restaura
zione economica dello stato piemontese, offrendo al
grande tessitore il mezzo di poter condurre a com
pimento il piano leggendario, fondandone le basi in
un ambiente ormai preparalo ad accettarne le radi
cali riforme ,J>.
Nè doveva essere, almeno fino al 1850. troppo
gravoso il carico tributario, il quale sia rhe gravasse
sui fondi, sia su la totalità dei redditi diretti ed indi
retti. si calcola ammontasse, riferito al totale della
popolazione degli Stati Sardi di terra-ferma, ad un
testatico di L. 21.30 comprendente tutti i tributi
diretti e indiretti. Il non gravoso carico si limitava
quasi tutto all'imposta prediale; lieve era il carico
personale e.mobiliare su le varie attività produttive
e commerciali. Calcolando una rendita annua totale
del Regno Sardo a un miliardo e 200 milioni risul
tava che ad un carico generale da noi calcolato in
80 milioni comprese le sovrimposte, doveva rorri-
spondere una perrentuale della importa al reddito
del 6.66% . Ma se lieve era la media sul totale della
p<»p«4azionc. non si deve dimenticare rhe esisteva
sperequazione del tributo fondiario dipendente an
che da una lunga pratica delle esenzioni, onde le


















