
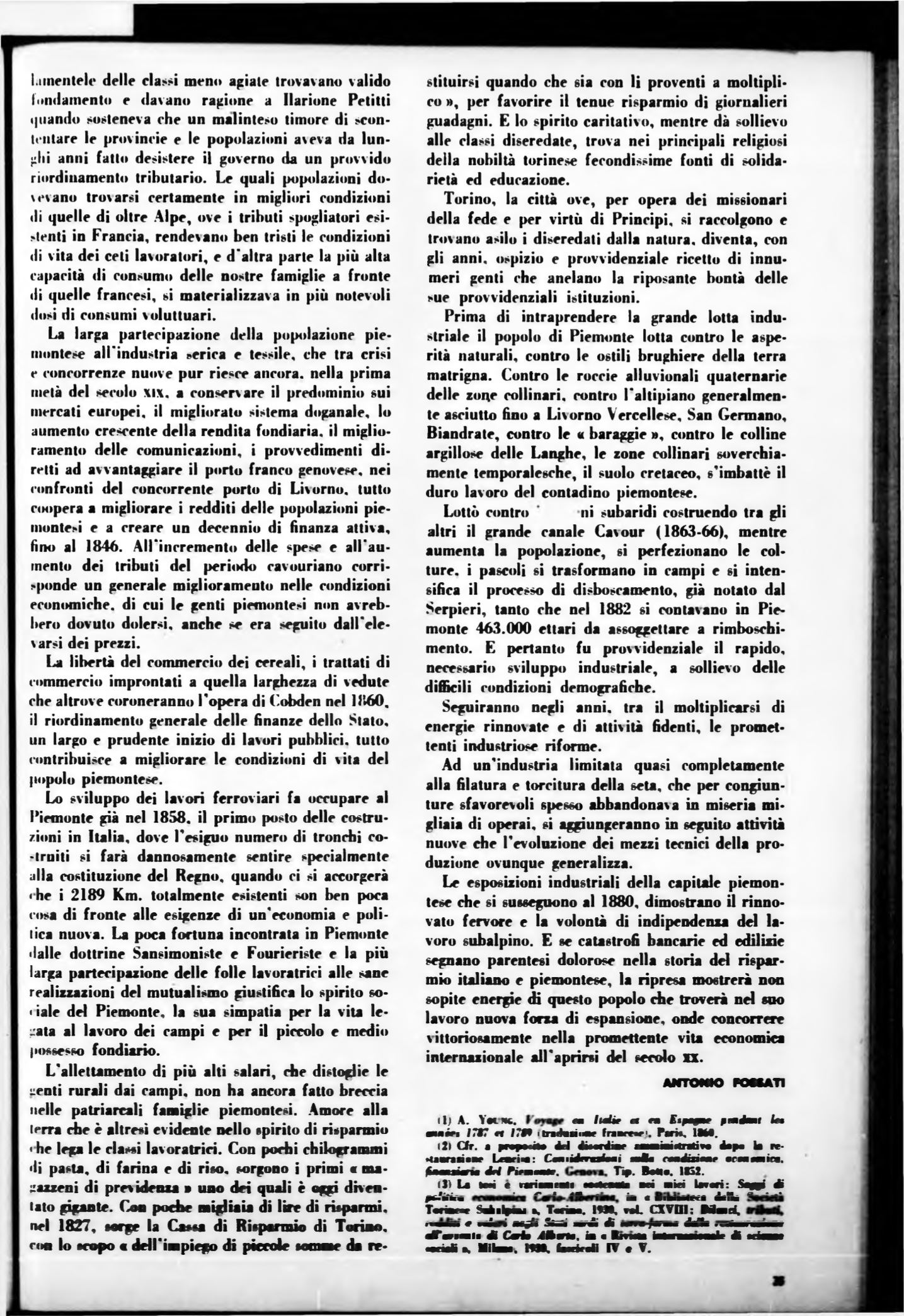
I.imeliteli* delle classi meno agiate trovavano valido
fondamento e davano ragione a llarione Petitti
•piando sosteneva ehe un malinteso timore di scon
tentare le provincie e le popolazioni aveva da lun
ghi anni fatto desistere il governo da un provvido
riordinamento tributario. Le quali popolazioni do
vevano trovarsi certamente in migliori condizioni
«li quelle di oltre Alpe, ove i tributi spogliatori esi
benti in Francia, rendevano ben tristi le condizioni
di vita dei celi lavoratori, e d 'altra parte la più alta
capacità di consumo delle nostre famiglie a fronte
di quelle francesi, si materializzava in più notevoli
dosi di consumi voluttuari.
La larga partecipazione della popolazione pie
montese all'industria nerica e tessile, che tra crisi
e concorrenze nuove pur riesce ancora, nella prima
metà del secolo xix. a conservare il predominio sui
mercati europei, il migliorato sistema doganale, lo
aumento crescente della rendita fondiaria, il miglio
ramento delle comunicazioni, i provvedimenti d i
retti ad avvantaggiare il porto franco genovese, nei
confronti del concorrente porto di Livorno, tutto
coopera a migliorare i redditi delle popolazioni pie
montesi e a creare un decennio di finanza attiva,
fino al 1846. All'incremento delle spese e a ll'au
mento dei tributi del periodo cavouriano corri
sponde un generale migliorameuto nelle condizioni
economiche, di cui le genti piemontesi non avreb
bero dovuto dolersi, anche se era seguito dall'ele-
varsi dei prezzi.
La libertà del commercio dei cereali, i trattati di
commercio improntati a quella larghezza di vedute
che altrove coroneranno l'opera di Cobden nel 1J160,
il riordinamento generale delle finanze dello Stato,
un largo e prudente inizio di lavori pubblici, tutto
contribuisce a migliorare le condizioni di vita del
popolo piemontese.
Lo sviluppo dei lavori ferroviari fa occupare al
Piemonte già nel 1858, il primo posto delle costru
zioni in Italia, dove l'esiguo numero di tronchi co-
-truiti si farà dannosamente sentire specialmente
alla costituzione del Regno, quando ci si accorgerà
«he i 2189 Km. totalmente esistenti son ben poca
cosa di fronte alle esigenze di un'economia e poli
tica nuova. La poca fortuna incontrata in Piemonte
«lalle dottrine Sansimoniste e Fourieriste e la più
larga partecipazione delle folle lavoratrici alle sane
realizzazioni del mutualismo giustifica lo spirito so-
• iale del Piemonte, la sua simpatia per la vita le
gata al lavoro dei campi e per il piccolo e medio
possesso fondiario.
L'allettamento di più alti salari, rhe distoglie le
iienti rurali dai campi, non ha ancora fatto breccia
nelle patriarcali famiglie piemontesi. Amore alla
terra rhe è altresì evidente nello spirito di risparmio
«he lega le riassi lavoratrici. Con pochi chilogrammi
«li pasta, di farina e di riso, sorgono i primi a ma
gazzeni di previdenza » uno dei quali è oggi diven
tato gigante. Con poche migliaia di lire di risparmi,
nel 1827, sorge la Cassa di Risparmio di
Torino,
c«*n lo
scopo
« dell*impiego
di piccole somme da
re
stituirsi quando che sia con li proventi a moltipli
co », per favorire il tenue risparmio di giornalieri
guadagni. E lo spirito caritativo, mentre dà sollievo
alle classi diseredate, trova nei principali religiosi
deila nobiltà torinese fecondissime fonti di solida
rietà ed educazione.
Torino, la città ove, per opera dei missionari
della fede e per virtù di Principi, si raccolgono e
trovano asilo i diseredati dalla natura, diventa, con
gli anni, ospizio e provvidenziale ricetto di innu
meri genti rhe anelano la riposante bontà delle
sue provvidenziali istituzioni.
Prima di intraprendere la grande lotta indu
striale il popolo di Piemonte lotta contro le aspe
rità naturali, contro le ostili brughiere della terra
matrigna. Contro le roccie alluvionali quaternarie
delle zone collinari, contro l'altipiano generalmen
te asciutto fino a Livorno Vercellese, San Germano,
Biandrate, contro le « baraggie », contro le colline
argillose delle Langhe, le zone collinari soverchia
mente temporalesche, il suolo cretaceo, s'imbattè il
duro lavoro del contadino piemontese.
Lottò contro
ni subaridi costruendo tra gli
altri il grande canale Cavour (1863-66), mentre
aumenta la popolazione, si perfezionano le col
ture. i pascoli si trasformano in campi e si inten
sifica il processo di disboscamento, già notato dal
Serpieri, tanto che nel 1882 si contavano in Pie
monte 463.000 ettari da assoggettare a rimboschi
mento. E pertanto fu provvidenziale il rapido,
necessario sviluppo industriale, a sollievo delle
diffìcili condizioni demografiche.
Seguiranno negli anni, tra il moltiplicarsi di
energie rinnovate e di attività fidenti, le promet
tenti industriose riforme.
Ad un'industria limitata quasi completamente
alla filatura e torcitura della seta, che per congiun
ture sfavorevoli spesso abbandonava in miseria mi
gliaia di operai, si aggiungeranno in seguito attività
nuove che l'evoluzione dei mezzi tecnici della pro
duzione ovunque generalizza.
Le esposizioni industriali della capitale piemon
tese che si susseguono al
1880,
dimostrano il rinno
vato fervore e la volontà di indipendenza del la
voro subalpino. E se catastrofi bancarie ed edilizie
segnano parentesi dolorose nella storia del rispar
mio italiano e piemontese, la ripresa mostrerà non
sopite energie di questo popolo die troverà nel suo
lavoro nuova forza di espansione, onde concorrere
vittoriosamente nella promettente vita economica
internazionale all'aprirsi del secolo
XX.
ANTONIO POSSATI
11) A. Y m k .
em Italie et e» Etpmgme prm immt le*
mmée t
1717
et
I W ttrattari «tur (ra n rr tr 1. P ark . IMO.
12) Cfr. a pw pw fc i d rl f c w f c t mauaiairtrativ* dopo U rr-
M iw n iia T L rarioi :
Comtidermxiomi mllm rtméitiome
* r—— i n .
| b m im
dei Piemmmte.
Tip. Boti*. 1852.
I)) U I n i « u f i i r i r « M i o ri miri lavori:
Smggà &
___! •>-■_
-------------•
•*"» - a
* —
- -
•
_
____ -1-11 _ g -----»->■
^nliicu
n i
f Dina
to t
evi nrila
Toriato* ^ « I
mm
t. Torino. 19», voi. CXVIII: M i r i ,
- -
- -» — • -------*- g -----• — -*-•
A l
J - i l - ------------------ ?------
(IVBW
W
MHvl NBpH Ami iW W Hvfw'jmWn MNB ih H W N N
«0*orroota
é i Cmim
i l » , la o Imaa iM fm nm lr 41 trina»
•orioli a. Mi!— .
Ma.
f—ricoli IV • ¥.


















