
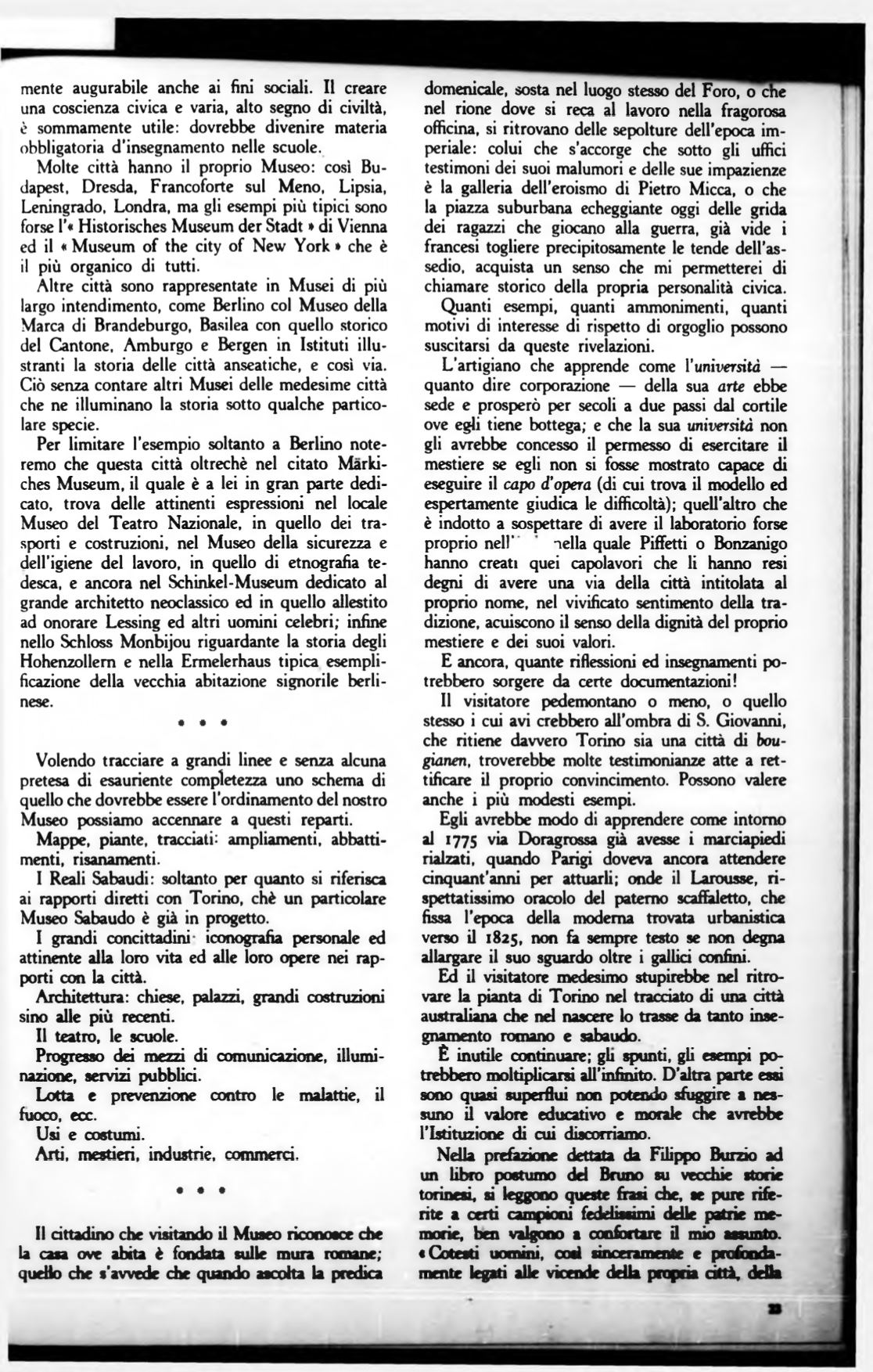
mente augurabile anche ai fini sociali. Il creare
una coscienza civica e varia, alto segno di civiltà,
è
sommamente utile: dovrebbe divenire materia
obbligatoria d’insegnamento nelle scuole.
Molte città hanno il proprio Museo: così Bu
dapest, Dresda, Francoforte sul Meno, Lipsia,
Leningrado, Londra, ma gli esempi più tipici sono
forse l’«Historisches Museum der Stadt * di Vienna
ed il «Museum of thè city of New York * che è
il più organico di tutti.
Altre città sono rappresentate in Musei di più
largo intendimento, come Berlino col Museo della
Marca di Brandeburgo, Basilea con quello storico
del Cantone, Amburgo e Bergen in Istituti illu
stranti la storia delle città anseatiche, e così via.
Ciò senza contare altri Musei delle medesime città
che ne illuminano la storia sotto qualche partico
lare specie.
Per limitare l’esempio soltanto a Berlino note
remo che questa città oltreché nel citato Marki-
ches Museum, il quale è a lei in gran parte dedi
cato, trova delle attinenti espressioni nel locale
Museo del Teatro Nazionale, in quello dei tra
sporti e costruzioni, nel Museo della sicurezza e
dell’igiene del lavoro, in quello di etnografia te
desca, e ancora nel Schinkel-Museum dedicato al
grande architetto neoclassico ed in quello allestito
ad onorare Lessing ed altri uomini celebri; infine
nello Schloss Monbijou riguardante la storia degli
Hohenzollem e nella Ermelerhaus tipica esempli
ficazione della vecchia abitazione signorile berli
nese.
* * •
Volendo tracciare a grandi linee e senza alcuna
pretesa di esauriente completezza uno schema di
quello che dovrebbe essere l’ordinamento del nostro
Museo possiamo accennare a questi reparti.
Mappe, piante, tracciati: ampliamenti, abbatti
menti, risanamenti.
I
Reali Sabaudi: soltanto per quanto si riferisca
ai rapporti diretti con Torino, chè un particolare
Museo Sabaudo è già in progetto.
I grandi concittadini iconografia personale ed
attinente alla loro vita ed alle loro opere nei rap
porti con la città.
Architettura: chiese, palazzi, grandi costruzioni
sino alle più recenti.
II teatro, le scuole.
Progresso dei mezzi di comunicazione, illumi
nazione, servizi pubblici.
Lotta e prevenzione contro le malattie, il
fuoco, ecc.
Usi e costumi.
Arti, mestieri, industrie, commerci.
• • •
Il cittadino che visitando il Museo riconosce che
la casa ove abita
è
fondata sulle mura romane;
quello che s’avvede che quando ascolta la predica
domenicale, sosta nel luogo stesso del Foro, o cne
nel rione dove si reca al lavoro nella fragorosa
officina, si ritrovano delle sepolture dell’epoca im
periale: colui che s’accorge che sotto gli uffici
testimoni dei suoi malumori e delle sue impazienze
è la galleria dell’eroismo di Pietro Micca, o che
la piazza suburbana echeggiante oggi delle grida
dei ragazzi che giocano alla guerra, già vide i
francesi togliere precipitosamente le tende dell’as
sedio, acquista un senso che mi permetterei di
chiamare storico della propria personalità civica.
Quanti esempi, quanti ammonimenti, quanti
motivi di interesse di rispetto di orgoglio possono
suscitarsi da queste rivelazioni.
L ’artigiano che apprende come l'università —
quanto dire corporazione — della sua
arte
ebbe
sede e prosperò per secoli a due passi dal cortile
ove egli tiene bottega; e che la sua
università
non
gli avrebbe concesso il permesso di esercitare il
mestiere se egli non si fosse mostrato capace di
eseguire il
capo d'opera
(di cui trova il modello ed
espertamente giudica le difficoltà); quell’altro che
è indotto a sospettare di avere il laboratorio forse
proprio nell’
nella quale Piffetti o Bonzanigo
hanno creati quei capolavori che li hanno resi
degni di avere una via della città intitolata al
proprio nome, nel vivificato sentimento della tra
dizione, acuiscono il senso della dignità del proprio
mestiere e dei suoi valori.
E ancora, quante riflessioni ed insegnamenti po
trebbero sorgere da certe documentazioni!
Il visitatore pedemontano o meno, o quello
stesso i cui avi crebbero all’ombra di S. Giovanni,
che ritiene davvero Torino sia una città di
bou-
gianen,
troverebbe molte testimonianze atte a ret
tificare il proprio convincimento. Possono valere
anche i più modesti esempi.
Egli avrebbe modo di apprendere come intorno
al 1775 via Doragrossa già avesse i marciapiedi
rialzati, quando Parigi doveva ancora attendere
cinquantanni per attuarli; onde il Larousse, ri-
spettatissimo oracolo del paterno scaffaletto, che
fissa l’epoca della moderna trovata urbanistica
verso il 1825, non fa sempre testo se non degna
allargare il suo sguardo oltre i gallici confini.
Ed il visitatore medesimo stupirebbe nel ritro
vare la pianta di Torino nel tracciato di una città
australiana che nel nascere lo trasse da tanto inse
gnamento romano e sabaudo.
£ inutile continuare; gli spunti, gli esempi po
trebbero moltiplicarsi all’infinito. D’altra parte essi
sono quasi superflui non potendo sfuggire a nes
suno il valore educativo e morale che avrebbe
l’istituzione di cui discorriamo.
Nella prefazione dettata da Filippo Bimbo ad
un
libro postumo del Bruno su vecchie storie
torinesi, si leggono queste frasi che, se pure rife
rite a certi campioni fedelissimi delle patrie me
morie, ben valgono a confortare il mio assunto.
«Cotesti uomini, cosi sinceramente e profonda
mente legati alle vicende della propria città, della


















