
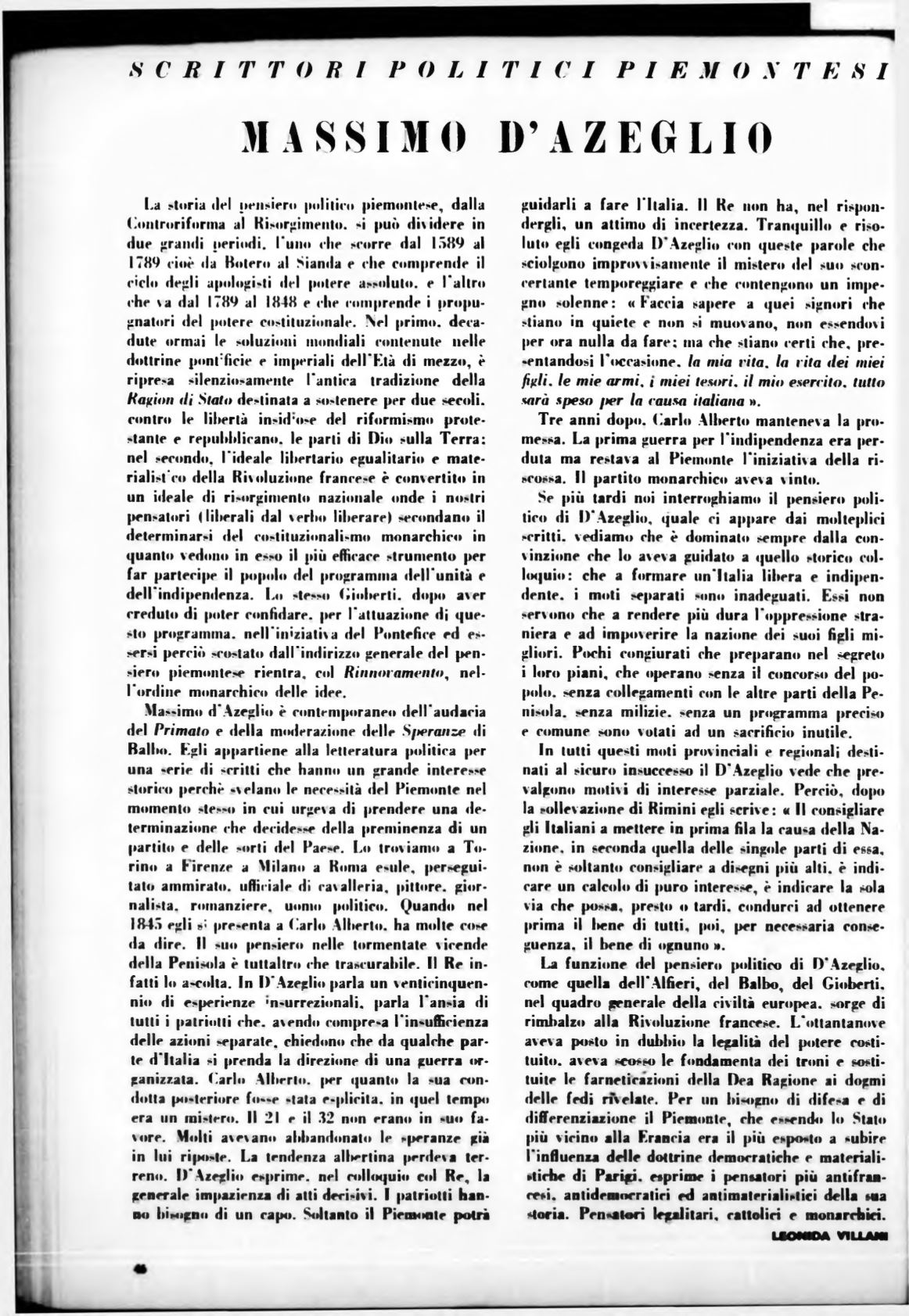
S C R I T T O R I P O L I T I C I P I E M O X T E S I
MA S S I MO D’ A Z E G L I O
[.a storia «lei pensiero pulitini piemontese, dalla
Controriforma al Risorgimento, si può di\idere in
due grandi periodi, l'uno che scorre dal 1589 al
1789
rioè da Bolero al Sianda e elle comprende il
ciclo degli apologisti del potere assoluto. e l'altro
che \a dal
1789
al
1848
e elle comprende i propu
gnatori del potere costituzionale. Nel primo, deca
dute ormai le soluzioni mondiali contenute nelle
dottrine pont:ficie e imperiali dell'Ftà di mezzo, è
ripresa silenziosamente l'antica tradizione della
Kafiion di Stato
destinata a sostenere per due secoli,
contro le libertà insidiose del riformismo prote
stante e repulddicano. le parti di Dio sulla Terra:
nel secondo, l'ideale libertario egualitario e mate-
rialist'co della Rivoluzione francese è convertito in
un ideale di risorgimento nazionale onde i nostri
pensatori (liberali dal verbo liberare) secondano il
determinarsi del costituzionalismo monarchico in
quanto vedono in esso il più efficace strumento per
far partecipe il popolo del programma dell'unità e
dell'indipendenza. Lo
stesso
Gioberti, dopo aver
creduto di poter confidare, per l'attuazione di que
sto programma, nell'iniziativa del Pontefice ed es
sersi perciò scostato dall'indirizzo generale del pen
siero piemontese rientra, col
Rinnovamento
, nel
l'ordine monarchico delle idee.
Massimo d'Azeglio è contemporaneo dell'audacia
del
Primato
e della moderazione delle
S/teranze
di
Balbo. Figli appartiene alla letteratura politica per
una *erie di scritti che hanno un grande interesse
storico perchè «velano le necessità del Piemonte nel
momento stesso in cui urgeva di prendere una de
terminazione che decidesse della preminenza di un
partito e delle sorti del Paese. Lo troviamo a To
rino a Firenze a Milano a Roma esule, persegui
tato ammirato, ufficiale di cavalleria, pittore, gior
nalista, romanziere, uomo politico. Quando nel
184ó egli s: presenta a darlo Alberto, ha molte cose
da dire. Il suo pensiero nelle tormentate vicende
della Penisola è tuttaltro che trascurabile. Il Re in
fatti lo ascolta. In I)*Azeglio parla un venticinquen
nio di esperienze ’n-urrezionali. parla l'ansia di
tutti i patriotti che. avendo compresa l'insufficienza
delle azioni separate, chiedono che da qualche par
te d'Italia si prenda la direzione di una guerra or
ganizzata. Carlo Alberto. |wr quanto la sua con
dotta posteriore fo—e «tata esplicita, in quel tempo
era un mistero. Il
21
e il
32
non erano in
suo
fa
vore.
Molti avevano abbandonato le
speranze già
in lui riposte. La tendenza allM*rtina perdeva ter
reno. I)*Azeglio esprime, nel colloquio col
R e ,
la
generale impazienza di atti derisiti. I patriotti han
no
bisogno
di un rapo. Soltanto il Pienn»nte potrà
guidarli a fare l'Italia. Il Re non ha, nel rispon
dergli, un attimo di incertezza. Tranquillo e riso
luto egli congeda l) Azeglio eon queste parole che
sciolgono improvvisamente il mistero del suo sron-
eertante temporeggiare e che contengono un impe
gno solenne : « Faccia sapere a quei signori che
stiano in quiete e non si muovano, non essendovi
per ora nulla da fare: ma che stiano certi che, pre
sentandosi l'occasione,
la mia vita, la vita (lei miei
finii, le mie armi,
j
miei tesori, il mio esercito, tutto
sarà speso
/ter la causa italiana
».
Tre anni dopo. Carlo Alberto manteneva la pro
messa. La prima guerra per l'indipendenza era per
duta ma restava al Piemonte l'iniziativa della ri
scossa. Il partito monarrhico aveva vinto.
Se più tardi noi interroghiamo il pensiero poli
tico di I)'Azeglio, quale ri appare dai moltepliri
srritti. vediamo rhe è dominato sempre dalla con
vinzione che lo aveva guidato a quello storico col
loquio: che a formare un'Italia libera e indipen
dente. i moti separati
sono
inadeguati. Essi non
servono che a rendere più dura l'oppressione stra
niera e ad impoverire la nazione dei suoi figli mi
gliori. Pochi congiurati rhe preparano nel segreto
i loro piani, rhe operano senza il concorso del po
polo. senza collegamenti con le altre parti della Pe
nisola. senza milizie, senza un programma preriso
e romune sono volati ad un sarrifirio inutile.
In tutti questi moti provinriali e regionali desti
nati al siruro insuccesso il D"Azeglio vede rhe pre
valgono motivi di interesse parziale. Perriò, dopo
la sollevazione di Rimini egli scrive: « Il consigliare
gli Italiani a mettere in prima fila la rau*a della Na
zione. in seronda quella delle singole parti di essa,
non è soltanto ronsigliare a disegni più alti, è indi-
rare un calcolo di puro interesse, è indirare la sola
via rhe possa, presto o tardi, condurri ad ottenere
prima il Itene di tutti, poi, per necessaria conse
guenza. il bene di ognuno ».
La funzione del pensiero politico di D*Azeglio,
rome quella dell'Alfieri, del Balbo, del Gioberti,
nel quadro generale della riviltà europea, sorge di
rimbalzo alla Rivoluzione franrese. L'ottantanove
aveva posto in dubbio la legalità del potere costi
tuito. aveva scosso le fondamenta dei troni e sosti
tuite le farnetirazioni della Dea Ragione ai dogmi
delle fedi melate. Per un bisogno di difesa e di
differenziazione il Piemonte, rhe essendo lo Stato
più virino alla Francia era il più esporto a subire
l'influenza delle dottrine demorratiche e materiali-
etiche di Parigi, esprime i pensatori più antifran-
resi. antidemorratiri ed antimaterialistici della sua
storia. Pensatori legalitari, cattolici e monarchici.
U O N ItM VILLANI


















