
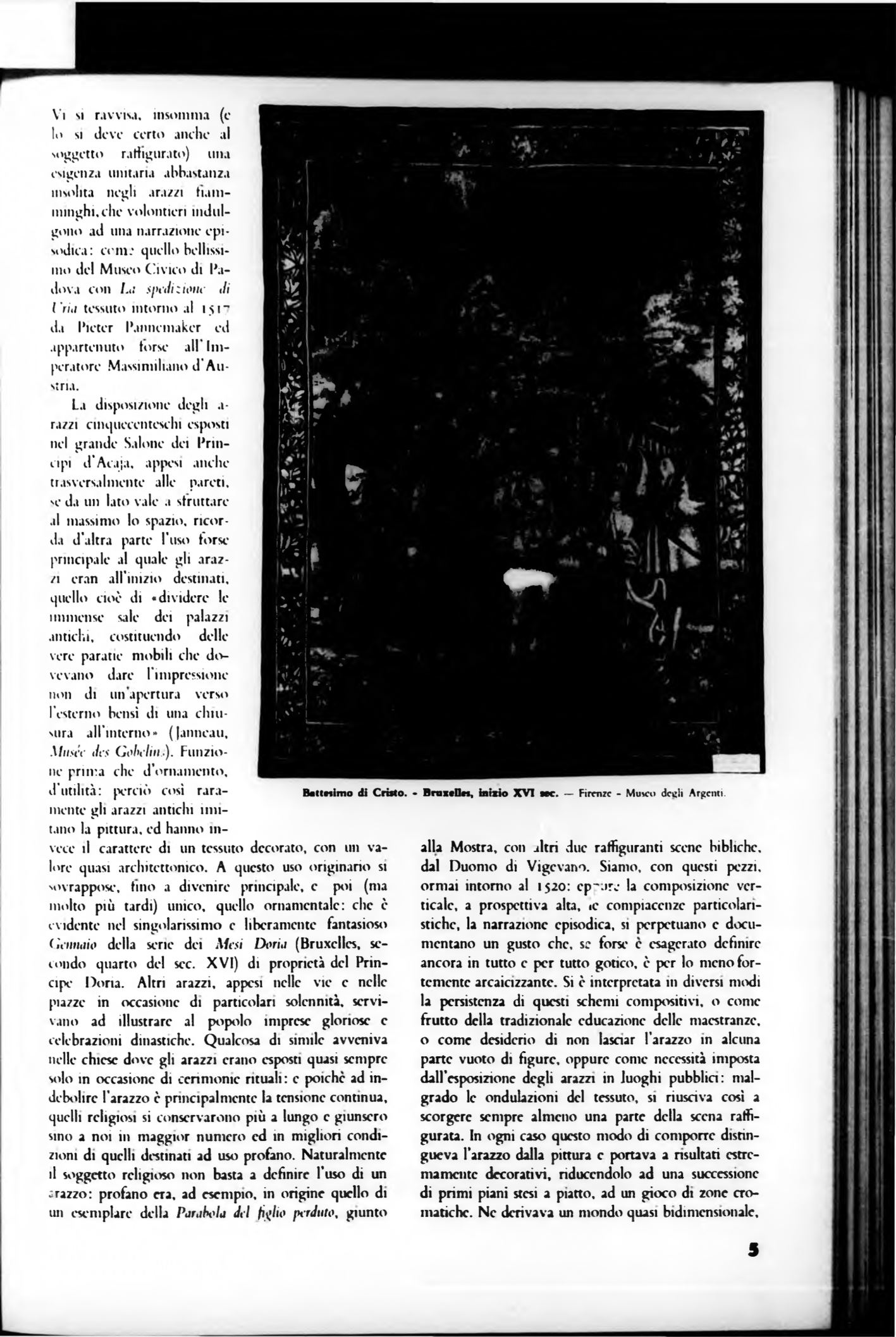
< : ' L
'
a
- ' :
I \
A]
!
' V
i-
'■“ / . y - '
VV-
j «
r - ^
pY r ^
^
m
/
» • : * >
. • w r*«*
Ù > ' ^
^ ' ftiV
gfc*
l ÀS; ,
y(T r
r#* ?
ti)*.'
m
1
i r
jV-*|■
'
IW-I
”1
_■
*v/; *
*- »
1
|.v,l
m
** ju
Battesimo di Cristo. - Bruxelles, inizio XVI sec. —
Firenze
-
Musco devili Argenti.
Vi si ravvisa, in somm a (c
10 si deve certo anche al
soggetto
raffigurato)
una
esigenza unitaria abbastanza
insolita negli arazzi fiam
minghi, che volontien mdiil-
gono ad una narrazione ep i
sodica: cen i.' quello bellissi
mo del Museo C iv ico di Pa
dova et>n
l.iispedizione ili
Cria
tessuto intorno al 1 5 1 7
da l'ieter l’ annemaker ed
appartenuti) torse all Im
peratore Massimiliano d 'A u
stria.
La disposizione degli a-
razzi cinquecenteschi esposti
nel grande Salone dei Prin
cipi d ’ Acaja, appesi anche
trasversalmente alle pareti,
ve da un lato vale .1 sfruttare
al massimo lo spazio, ric o r
da d ’altra parte l’ uso forse
principale al quale gli araz
zi cran all’inizio destinati,
quello cioè di «dividere le
immense sale dei palazzi
antichi, costituendo
delle
vere paratie mobili che d o
vevano dare l’impressione
non di un apertura verso
l’esterno bensì di una ch iu
sura all'interno» (Janncau,
Muséc des Gobelin.;).
Funzio
ne prima che d ’ ornamento,
d 'utilità: perciò così rara
mente gli arazzi antichi im i
tano la pittura, ed hanno in
vece il carattere di un tessuto decorato, con 1111 va
lore quasi architettonico. A questo uso originario si
sovrappose, tino a diven ire principale, e poi (ma
molto più tardi) unico, quello ornamentale: che è
evidente nel singolarissimo e liberamente fantasioso
Gennaio
della serie dei
M esi Doria
(Bruxelles, se
condo quarto del sec. X V I) di proprietà del Prin
cipe Doria. Altri arazzi, appesi nelle vie e nelle
piazze in occasione di particolari solennità, servi
vano ad illustrare al popolo imprese gloriose c
celebrazioni dinastiche. Qualcosa di simile avven iva
nelle chiese dove gli arazzi erano esposti quasi sempre
stilo in occasione di cerimonie rituali: e poiché ad in
debolire l’arazzo è principalmente la tensione continua,
quelli religiosi si conservarono più a lungo e giunsero
sino a noi in m aggior numero ed in m igliori condi
zioni di quelli destinati ad uso profano. Naturalmente
11 soggetto religioso non basta a definire l’ uso di un
; razzo: profano era, ad esempio, in origine quello di
un esemplare della
Parabola del figlio perduto,
giunto
alla Mostra, con jlt r i due raffiguratiti scene bibliche,
dal Duom o di V igevano . Siamo, con questi pezzi,
o rm ai intorno al 15 2 0 : e p '.ir ^ la composizione ver
ticale, a prospettiva alta, ic compiacenze particolari
stiche, la narrazione episodica, si perpetuano e docu
mentano un gusto che, se forse e esagerato definire
ancora in tutto e per tutto gotico, è per lo meno for
temente arcaicizzante. Si è interpretata in diversi modi
la persistenza di questi schemi compositivi, o come
fru tto della tradizionale educazione delle maestranze,
o come desiderio di non lasciar l’arazzo in alcuna
parte vuoto di figu re, oppure come necessità imposta
da ll’esposizione degli arazzi in Juogh i p u bb lio : mal
g rado le ondulazioni del tessuto, si riusciva così a
scorgere sempre almeno una parte della scena raffi
gurata. In ogni caso questo modo di comporre distin
gu eva l’arazzo dalla pittura c portava a risultati estre
mamente decorativi, riducendolo ad una successione
di prim i piani stesi a piatto, ad un g io co di zone cro
matiche. N e derivava un mondo quasi bidimensionale.
5


















