
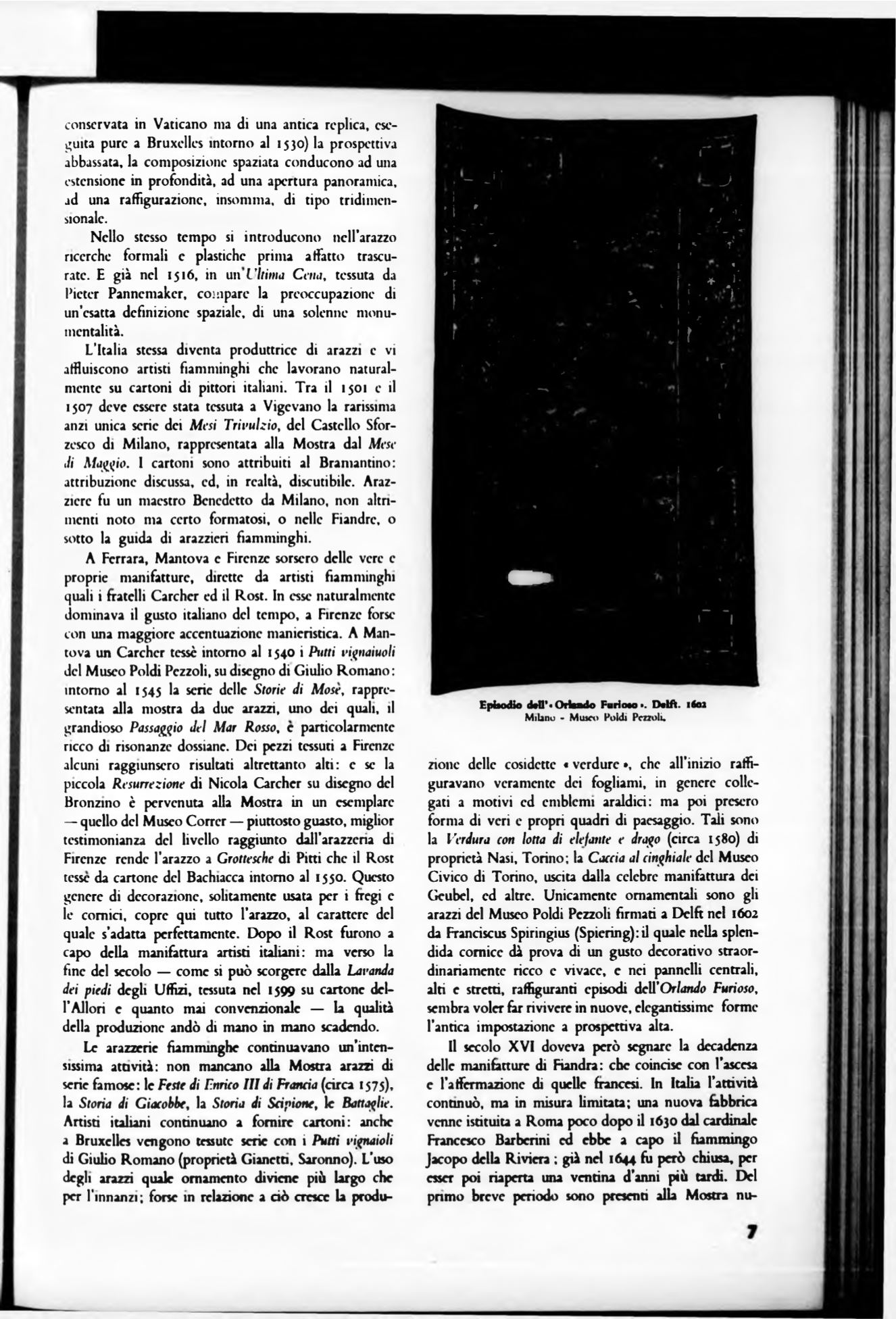
conservata in Vaticano ma di una antica replica, ese
guita pure a Bruxelles intorno al 1530 ) la prospettiva
abbassata, la composizione spaziata conducono ad una
estensione in profondità, ad una apertura panoramica,
ad una raffigurazione, insomma, di tipo tridimen
sionale.
N ello stesso tempo si in troducono nell’arazzo
ricerche form ali e plastiche prima affatto trascu
rate. E già nel 15 16 , in
un Ultima C a ia ,
tessuta da
Pieter Pannemaker, co;:ipare la preoccupazione di
un’esatta definizione spaziale, di una solenne monu
m e n t a li .
L ’Italia stessa diventa produttrice di arazzi e vi
affluiscono artisti fiamm inghi che lavorano natural
mente su cartoni di pittori italiani. T ra il 15 0 1 e il
1507 deve essere stata tessuta a V igevano la rarissima
anzi unica serie dei
M esi T rivu lz io ,
del Castello Sfor
zesco di M ilano, rappresentata alla Mostra dal
Mese
J i M aggio.
1
cartoni sono attribuiti al Bramantino:
attribuzione discussa, ed, in realtà, discutibile. Araz
ziere fu un maestro Benedetto da M ilano, non altri
menti noto ma certo formatosi, o nelle Fiandre, o
sotto la guida di arazzieri fiamm inghi.
A Ferrara, M an tova e Firenze sorsero delle vere e
proprie manifatture, dirette da artisti fiamm inghi
quali i fratelli Carcher ed il R o st. In esse naturalmente
dom inava il gusto italiano del tempo, a Firenze forse
con una m aggiore accentuazione manieristica. A Man
tova un Carcher tessè intorno al 1540 i
Putti vignaiuoli
del Museo Poldi Pczzoli, su disegno di G iu lio R om an o :
intorno al 1545 la serie delle
Storie di Mose,
rappre
sentata alla mostra da due arazzi, uno dei quali, il
grandioso
Passaggio del Mar Rosso,
e particolarmente
ricco di risonanze dossiane. Dei pezzi tessuti a Firenze
alcuni raggiunsero risultati altrettanto alti: e se la
piccola
Resurrezione
di N icola Carcher su disegno del
Bronzino è pervenuta alla Mostra in un esemplare
— quello del Museo Co rrer — piuttosto guasto, m iglior
testimonianza del livello raggiunto dall’arazzena di
Firenze rende l’arazzo a
Grottesche
di Pitti che il Rost
tesse da cartone del Bachiacca intorno al 1550 . Questo
genere di decorazione, solitamente usata per i fregi e
le com ici, copre qui tutto l’arazzo, al carattere del
quale s’adatta perfettamente. Dopo il R o st furono a
capo della manifattura artisti italiani: ma verso la
fine del secolo — come si può scorgere dalla
Lavanda
dei piedi
degli U ffizi, tessuta nel 1599 su cartone del-
l’ A llori e quanto mai convenzionale — la qualità
della produzione andò di mano in mano scadendo.
Le arazzerie fiamm inghe continuavano un’ inten
sissima attività: non mancano alla Mostra arazzi di
serie famose: le
Feste di F.nrico I I I di F ronda
(circa 1575).
la
Storia di Giacobbe,
la
Storia di Scipione,
le
Battaglie.
Artisti italiani continuano a forn ire carton i: anche
a Bruxelles vengono tessute serie con i
Putti vignaioli
di G iu lio R om an o (proprietà Gianotti, Saronno). L ’ uso
degli arazzi quale ornamento diviene più largo che
per l'innanzi; forse in relazione a ciò cresce la produ-
. -
j
:
r
A
L 1 f • •,
’ i
'
1
r
•! ’
j
•*
^ .■ - ■ ’ -
,
1*
■
*
. - -• •
»1
*
*
^
.V
*
'
; y
v ’
1
v
* ~
r * .
i
\ r "
\
>
1 • * J ;
' 1 •
i
1 1 ’
r
' ' _
.
> *
'
v
\ ’ r.
■ •
:
t
•
«
- v . v
,
- *
-
r
„
- -
*•
i
i
,
■
* *■*>
1
1
1
^
1
4
M B *
1
r ~i
1
Epiiodio cUtr. Orlando Furioso •. Delft. 1602
Milano - Musco Poldi Prazoii.
zionc delle cosidctte « verdure », che all’ inizio raffi
guravano veramente dei fogliam i, in genere colle
gati a m otivi ed emblem i araldici: ma poi presero
forma di veri e propri quadri di paesaggio. T a li sono
la
Verdura con lotta di elefante
e
drago
(circa 1580) di
proprietà Nasi, To rino ; la
Caccia al cinghiale
del Museo
C iv ico di Torino , uscita dalla celebre manifattura dei
Geubel, ed altre. Unicamente ornamentali sono gli
arazzi del Musco Poldi Pezzoli firmati a D elft nel 1602
da Franciscus Spiringius (Sp icring ):il quale nella splen
dida cornice dà prova di un gusto decorativo straor
dinariamente ricco e vivace, e nei pannelli centrali,
alti e stretti, raffiguranti episodi dell
'O rlando Furioso,
sembra vo ler far rivivere in nuove, elegantissime forme
l’antica impostazione a prospettiva alta.
Il secolo X V I doveva però segnare la decadenza
delle manifatture di Fiandra: che coincise con l’ascesa
e l’affermazione di quelle francesi. In Italia l'attività
continuò, ma in misura lim itata; una nuova fabbrica
venne istituita a R om a poco dopo il 16 30 dal cardinale
Francesco Barberini ed ebbe a capo il fiamm ingo
Ja cop o della R iv ie ra ; già nel 1644 fu però chiusa, per
esser poi riaperta una ventina d ’anni più tardi. Del
primo breve periodo sono presenti alla Mostra nu-


















