
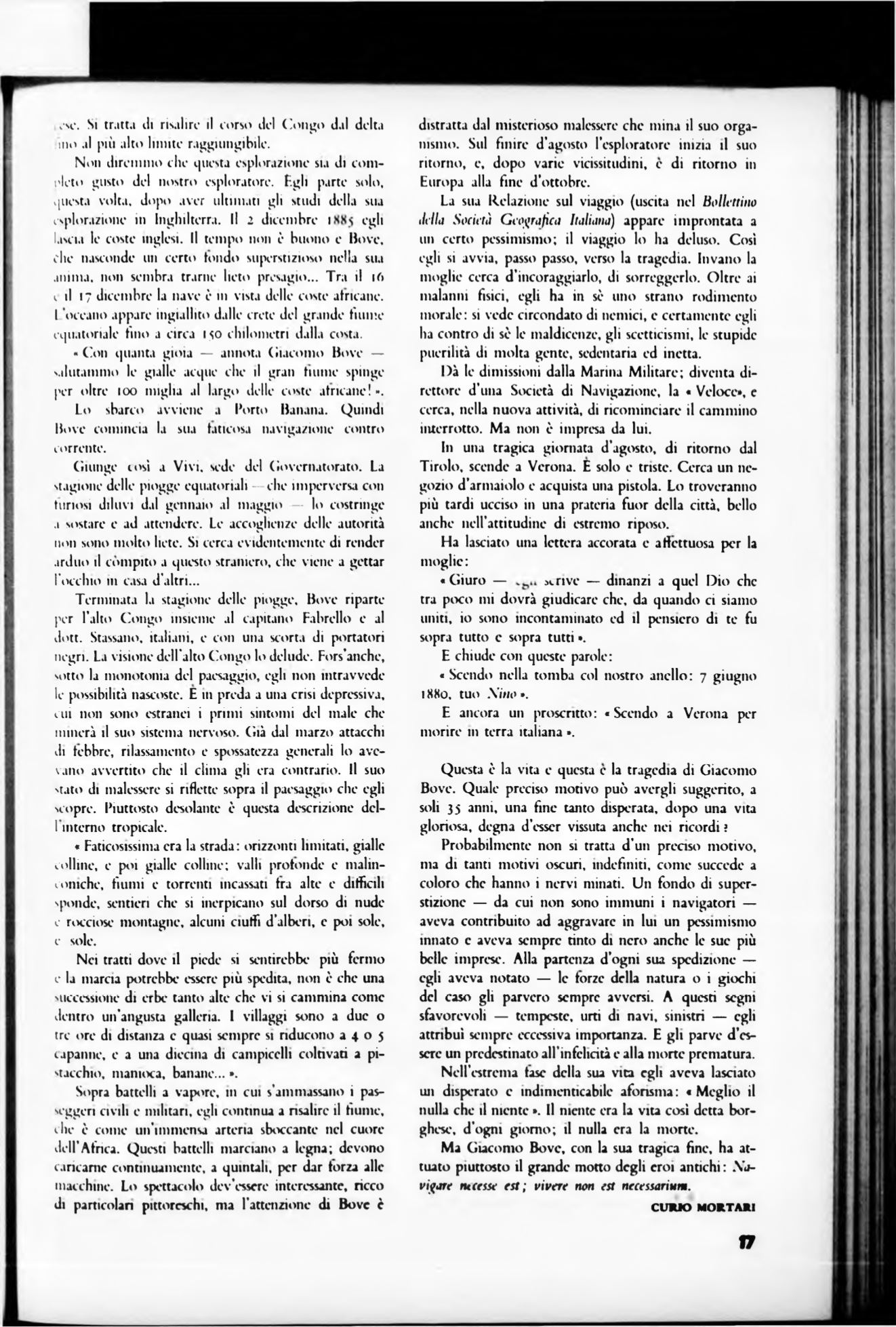
,'sc. Si tratta ili risalirò il corso del C o n g o dal delta
;ino al più alto limite raggiungibile.
Non diremmo che questa esplorazione sia di com
pleto gusto del nostro esploratore. Egli parte solo,
questa volta, dopo aver ultimati gli studi della sua
esplorazione in Inghilterra. Il 2 dicembre i
egli
lascia le coste inglesi. Il tempo non è buono e Bove,
che nasconde un certo tondo superstizioso nella sua
anima, non sembra trarne lieto presagio... T ra il
i(t
i il 17 dicembre la nave è 111 vista delle coste africane.
I oceano appare ingiallito dalle crete del grande fiume
equatoriale fino a circa 150 chilometri dalla costa.
«C on quanta gioia — annota G iacom o Bove —
salutammo le gialle acque che il gran fiume spinge
per oltre 100 miglia al largo delle coste africane! ».
Lo sbarco avviene a Porto Banana. Quindi
Bove comincia la sua faticosa navigazione contro
corrente.
Giunge così a V iv i, sede del Governatorato. La
stagione delle piogge equatoriali — che imperversa con
furiosi diluvi dal gennaio al maggio — lo costringe
a sostare e ad attendere. Le accoglienze delle autorità
non sono molto liete. Si cerca evidentemente di render
arduo il compito a questo straniero, che viene a gettar
l’occhio 111 casa d ’altri...
Term inata la stagione delle piogge. Bove riparte
per l’alto C ongo insieme al capitano Fabrello e al
dott. Stassano, italiani, e con una scorta di portatori
negri. La visione dell’alto C o n g o lo delude. Fors’anchc,
sotto la monotonia del paesaggio, egli non intravvede
le possibilità nascoste. E 111 preda a una crisi depressiva,
cui 11011 sono estranei i prim i sintomi del male che
minerà il suo sistema nervoso. Già dal marzo attacchi
di febbre, rilassamento e spossatezza generali lo ave
vano avvertito che il clima gli era contrario. Il suo
stato di malessere si riflette sopra il paesaggio che egli
scopre. Piuttosto desolante è questa descrizione dcl-
I intcmo tropicale.
« Faticosissima era la strada : orizzonti limitati, gialle
colline, e poi gialle colline; valli profonde e malin
coniche, fium i e torrenti incassati tra alte e difficili
sponde, sentieri che si inerpicano sul dorso di nude
e rocciose montagne, alcuni ciuffi d ’alberi, e poi sole,
e sole.
Nei tratti dove il piede si sentirebbe più fermo
e la marcia potrebbe essere più spedita, non è che una
successione di erbe tanto alte che vi si camm ina come
dentro un’angusta galleria. I villaggi sono a due o
tre ore di distanza e quasi sempre si riducono a
4.
o 5
capanne, e a una diecina di campicclli coltivati a pi
stacchio, manioca, banane... ».
Sopra battelli a vapore, 111 cui s’ammassano i pas
seggeri civili e militari, egli continua a risalire il fiume,
che è come un’immensa arteria sboccante nel cuore
dell’ Africa. Questi battelli marciano a legna; devono
caricarne continuamente, a quintali, per dar forza alle
macchine. Lo spettacolo dev’essere interessante, ricco
di particolari pittoreschi, ma l’attenzione di Bo ve è
distratta dal misterioso malessere che mina il suo o rga
nismo. Sul finire d ’agosto l’esploratore inizia il suo
ritorno, e, dopo varie vicissitudini, c di ritorno in
Europa alla fine d ’ottobre.
La sua Relazione sul viaggio (uscita nel
Bollettino
licita Società Geografica Italiana)
appare improntata a
un certo pessim ismo; il viaggio lo ha deluso. Così
egli si avvia, passo passo, verso la tragedia. Invano la
m oglie cerca d ’ incoraggiarlo, di sorreggerlo . O ltre ai
malanni fisici, egli ha in sò uno strano rodimento
m orale: si vede circondato di nem ici, e certamente egli
ha contro di sò le maldicenze, gli scetticismi, le stupide
puerilità di molta gente, sedentaria ed inetta.
Dà le dimissioni dalla Marina M ilitare ; diventa di
rettore d ’ una Società di Navigazione, la « Veloce», e
cerca, nella nuova attività, di ricom inciare il camm ino
interrotto. M a non è impresa da lui.
In una tragica giornata d ’agosto, di ritorno dal
T iro lo , scende a Verona. E solo e triste. Cerca un ne
gozio d ’arm aiolo e acquista una pistola. L o troveranno
più tardi ucciso in una prateria fuo r della città, bello
anche ncU’attitudinc di estremo riposo.
Ha lasciato una lettera accorata e affettuosa per la
m og lie:
« G iu ro —
scrive — dinanzi a quel D io che
tra poco mi dov rà giudicare che, da quando ci siamo
uniti, io sono incontaminato ed il pensiero di te fu
sopra tutto e sopra tutti ».
E chiude con queste parole:
« Scendo nella tomba col nostro an ello : 7 giugno
1H80, tuo
S in o
».
E ancora un proscritto: «Scendo a Verona per
morire 111 terra italiana ».
Questa è la vita e questa c la tragedia di G iacom o
B o ve . Quale preciso motivo può avergli suggerito, a
soli 35 anni, una fine tanto disperata, d opo una vita
gloriosa, degna d ’esser vissuta anche nei ricordi ;
Probabilmente non si tratta d ’ un preciso m otivo,
ma di tanti m otivi oscuri, indefiniti, com e succede a
co loro che hanno i nervi minati. Un fondo di super
stizione — da cui non sono immuni i navigato ri —
aveva contribuito ad aggravare in lui un pessimismo
innato e aveva sempre tinto di nero anche le sue più
belle imprese. Alla partenza d ’ogn i sua spedizione —
egli aveva notato — le torze della natura o i giochi
del caso gli parvero sempre avversi. A questi segni
sfavorevo li — tempeste, urti di navi, sinistri — egli
attribuì sempre eccessiva importanza. E g li parve d ’es
sere un predestinato all’infelicità e alla morte prematura.
NcH’cstrema fase della sua vita egli aveva lasciato
un disperato e indimenticabile aforisma : « Meglio il
nulla che il niente ». Il mente era la vita così detta bor
ghese, d’ogm giorno; il nulla era la morte.
Ma Giacomo Bove, con la sua tragica fine, ha at
tuato piuttosto il grande motto degli eroi antichi :
Na
vigare rucesse est; vivere non est necessariutn.
CURIO MORTARI
17


















