
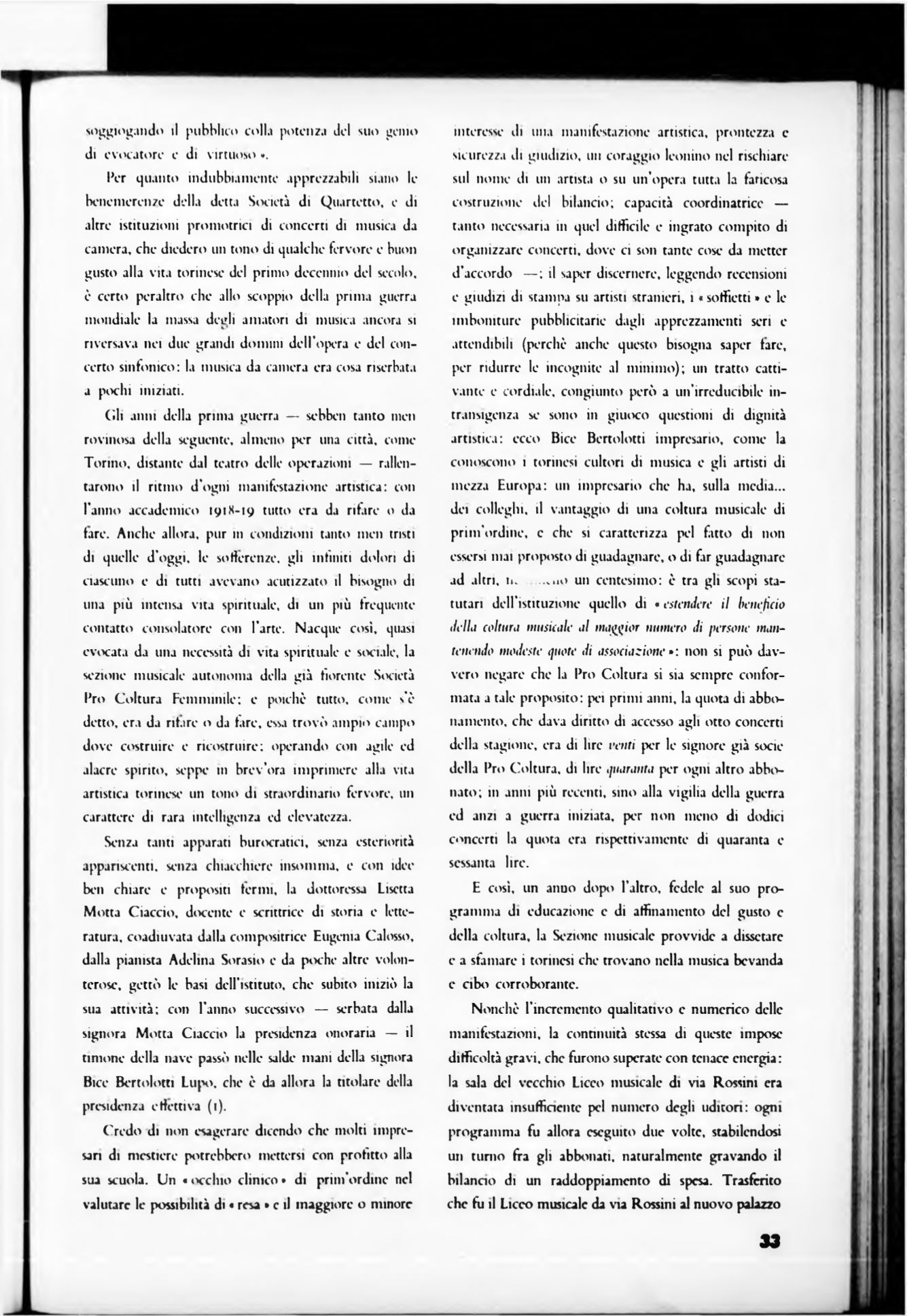
soggiogando il pubblico colla potenza del suo genio
di evocatore e di virtuoso *.
Per quanto indubbiamente apprezzabili siano le
benemerenze della detta Società di Quartetto, e di
altre istituzioni promotrici di concerti di musica da
camera, che diedero un tono di qualche fervore e buon
gusto alla vita torinese del primo decennio del secolo,
è certo peraltro che allo scoppio della prima guerra
mondiale la massa dcvli amatori di musica ancora si
riversava nei due grandi domini dell’opera e del con
certo sinfonico: la musica da camera era cosa riserbata
a pochi iniziati.
Cìlt .111111 della prima guerra — sebben tanto nien
rovinosa della seguente, almeno per una città, come
Tonno, distante dal teatro delle operazioni — rallen
tarono il ritmo d ’ogni manifestazione artistica: con
l'anno accademico 191S-19 tutto era da rifare o da
tare. Anche allora, pur 111 condizioni tanto meli tristi
di quelle d’oggi, le sofferenze, gli infiniti dolori di
ciascuno e di tutti avevano acutizzato il bisogno di
una più intensa vita spirituale, di un più frequente
contatto consolatore con l’arte. Nacque così, quasi
evocata da una necessità di vita spirituale e sociale, la
sezione musicale autonoma della già fiorente Società
Pro Coltura Femminile; e poiché tutto, come s’ò
detto, era da rifare o da fare, essa trovò ampio campo
dove costruire e ricostruire: operando con agile ed
alacre spirito, seppe 111 brev’ora imprimere alla vita
artistica torinese un tono di straordinario fervore. 1111
carattere di rara intelligenza ed elevatezza.
Senza tanti apparati burocratici, senza esteriorità
appariscenti, senza chiacchiere insomma, e con idee
ben chiare e propositi termi, la dottoressa Lisetta
Motta Ciaccio, docente e scrittrice di storia e lette
ratura. coadiuvata dalla compositrice Eugenia Calosso,
dalla pianista Adelma Sorasio e da pix'ho altre volon
terose, gettò le basi dell’istituto, che subito iniziò la
sua attività: con l'anno successivo — serbata dalla
signora Motta Ciaccio la presidenza onoraria — il
timone della nave passò nelle salde mani della signora
Bice Bcrtolotti Lupo, che è da allora la titolare della
presidenza effettiva (1).
Credo di non esagerare dicendo che molti impre
sari di mestiere potrebbero mettersi con profitto alla
sua scuola. Un «occhio clinico * di prim’ordine nel
valutare le possibilità di «resa »e il maggiore o minore
interesse ili 1111.1 manifestazione artistica, prontezza e
sicurezza di giudizio,
1111
coraggio leonino nel rischiare
sul nome di
1111
artista o su un’opera tutta la faticosa
costruzione del bilancio; capacità coordinatrice —
tanto necessaria in quel difficile e ingrato compito di
organizzare concerti, dove ci son tante cose da metter
d’accordo — ; il saper discernere, leggendo recensioni
e giudizi di stampa su artisti stranieri,
1
«soffietti » e le
imbonitine pubblicitarie dagli apprezzamenti seri e
attendibili (perchè anche questo bisogna saper tare,
per ridurre le incognite al minimo); un tratto catti
vante e cordiale, congiunto però a un’irreducibile in
transigenza se' sono in giuoco questioni di dignità
artistica: ecco Bice Bertolotti impresario, come la
conoscono 1 torinesi cultori di musica e gli artisti di
mezza Europa: un impresario che ha, sulla m ed ia-
dei colleglli, il vantaggio di una coltura musicale di
prim'ordine, e che si caratterizza pel fitto di
11011
essersi mai proposto di guadagnare, o di far guadagnare
ad altri, iu ..„u o un centesimo: è tra gli scopi sta
tutari dell’istituzione quello di «
estendere il beneficio
della coltura musicale al maggior numero di persone man
tenendo modeste quote di associazione
»: non si può dav
vero negare che la Pro Coltura si sia sempre confor
mata a tale proposito: pei primi anni, la quota di abbo
namento, che dava diritto di accesso agli otto concerti
della stagione, era di lire
venti
per le signore già socie
della Pro Coltura, di lire
quaranta
per ogni altro abbo
nato; in anni più recenti, sino alla vigilia della guerra
ed anzi a guerra iniziata, per non meno di dodici
concerti la quota era rispettivamente di quaranta e
sessanta lire.
E così, un anno dopo l’altro, fedele al suo pro
gramma di educazione e di affinamento del gusto e
della coltura, la Sezione musicale provvide a dissetare
e a sfamare i torinesi che trovano nella musica bevanda
e cibo corroborante.
Nonché l’incremento qualitativo e numerico delle
manifestazioni, la continuità stessa di queste impose
difficoltà gravi, che furono superate con tenace energia:
la sala del vecchio Liceo musicale di via Rossini era
diventata insufficiente pel numero degli uditon: ogni
programma fu allora eseguito due volte, stabilendosi
un turno fra gli abbonati, naturalmente gravando il
bilancio di un raddoppiamento di spesa. Trasferito
che fu il Liceo musicale da via Rossini al nuovo palazzo
33


















