
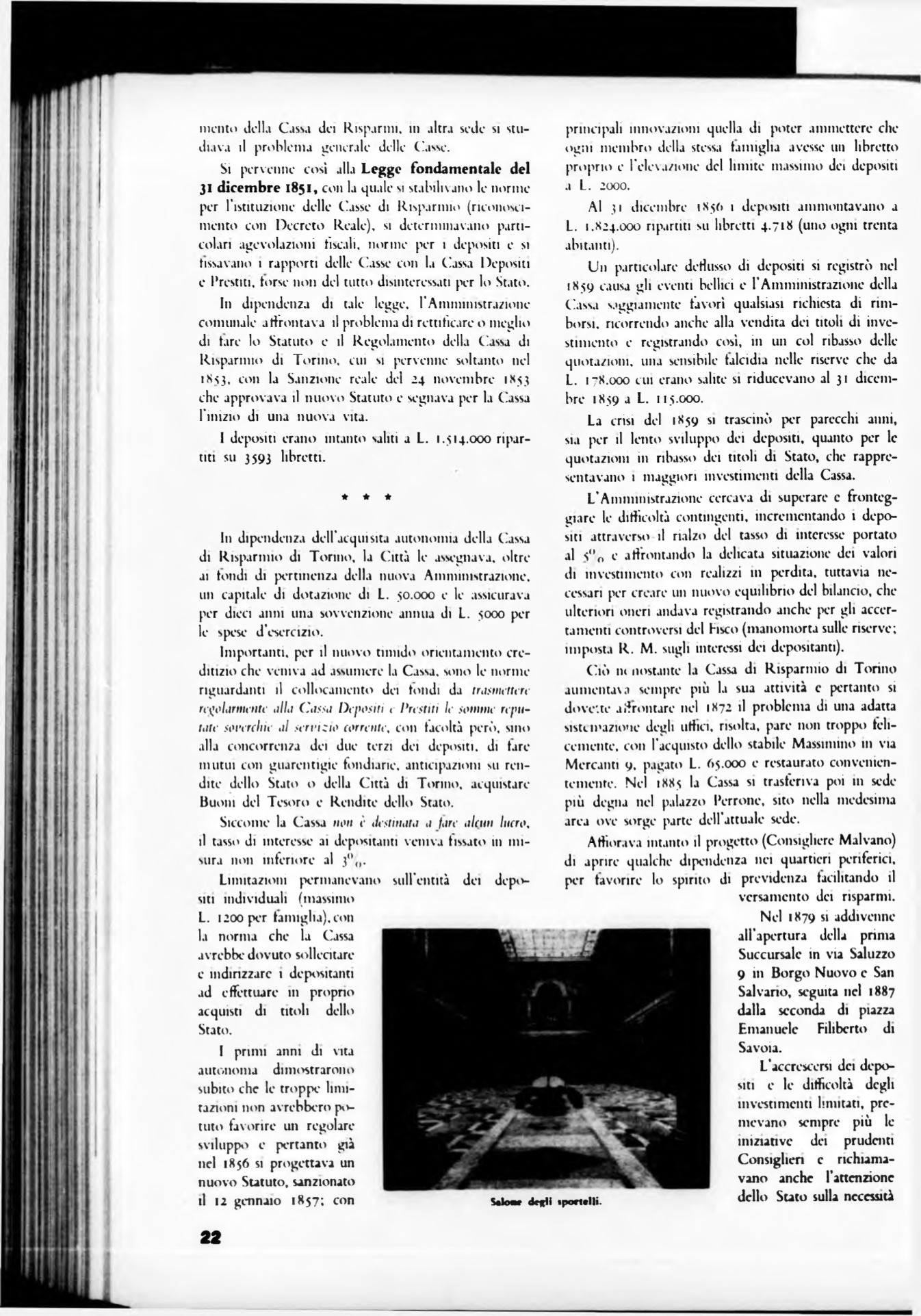
monto della Cassa dei Risparmi, in altra sede si stu
diava il problema generale delle Casse.
Si pervenne così alla Legge fondamentale del
31 dicembre 18 5 1, con la quale si stabilivano le norme
per l’istituzione delle Classe di Risparmio (riconosci
mento con Decreto Reale), si determinavano parti
colari agevolazioni fiscali, norme per 1 depositi e si
fissavano 1 rapporti delle Casse con la Classa Depositi
e Prestiti, torse 11011 del tutto disinteressati per lo Stato.
In dipendenza di tale legge, l'Amministrazione
comunale affrontava il problema di rettificare o meglio
di tare lo Statuto e il Regolamento della Cassa di
Risparmio di Torino, cui si pervenne soltanto nel
1 Ss3. con la Sanzione reale del 24 novembre 1853
che approvava il nuovo Statuto e segnava per la Classa
l’inizio di una nuova vita.
I
depositi erano intanto saliti a L. 1.514.000 ripar
titi su 3593 libretti.
★ * *
In dipendenza dell’acquisita autonomia della Classa
di Risparmio di Torino, la Città le assegnava, oltre
ai tondi di pertinenza della nuova Amministrazione,
un capitale di dotazione di L. 50.000 e le assicurava
per dieci anni una sovvenzione annua di L. 5000 per
le spese d’esercizio.
Importanti, per il nuovo timido orientamento cre
ditizio che veniva ad assumere la Cassa, sono le norme
riguardanti il collocamento dei tondi da
trasmettere
regolarmente alla Cassa Depositi e Prestili le somme repu
tine soverchie
.1/
servizio corrente
, con facoltà però, sino
alla concorrenza dei due terzi dei depositi, di tare
mutui con guarentigie fondiarie, anticipazioni su ren
dite dello Stato o della Città di Torino, acquistare
Buoni del Tesoro e Rendite dello Stato.
Siccome la Cassa
non è destinata a fare alcun lucro,
il tasso di interesse ai depositanti veniva fissato in mi
sura non inferiore al 3 °0.
Limitazioni permanevano sull’entità dei dept>-
siti individuali (massimo
L. 1200 per famiglia), con
la norma che la Cassa
avrebbe dovuto sollecitare
e indirizzare 1 depositanti
ad effettuare in proprio
acquisti di titoli dello
Stato.
I
primi anni di vita
autonoma dimostrarono
subito che le troppe limi
tazioni non avrebbero p»>-
tuto favorire un regolare
sviluppo e pertanto già
nel 1856 si progettava un
nuovo Statuto, sanzionato
il 12 gennaio 1857; con
principali innovazioni quella di poter ammettere che
ogni membro della stessa famiglia avesse 1111 libretto
proprio e l’elevazione del limite massimo dei depositi
a L.
2000
.
Al 31 dicembre 1856 1 depositi ammontavano a
L. 1.S24.000 ripartiti su libretti 4.718 (uno ogni trenta
abitanti).
U11 particolare deflusso di depositi si registrò nel
1859 causa gli eventi bellici e l’ Amministrazione della
Cassa saggiamente favorì qualsiasi richiesta di rim
borsi. ricorrendo anche alla vendita dei titoli di inve
stimento e registrando così, in un col ribasso delle
quotazioni, una sensibile falcidia nelle riserve che da
L. 178.000 cui erano salite si riducevano al 31 dicem
bre 1859 a L. 115.000.
La crisi del 1859 si trascinò per parecchi anni,
sia per il lento sviluppo dei depositi, quanto per le
quotazioni in ribasso dei titoli di Stato, che rappre
sentavano 1 maggiori investimenti della Cassa.
L ’ Amministrazione cercava di superare c fronteg
giare le difficoltà contingenti, incrementando 1 depo
siti attraverso il rialzo del tasso di interesse portato
al 5 °0 e affrontando la delicata situazione dei valori
di investimento con realizzi 111 perdita, tuttavia ne
cessari per creare un nuovo equilibrio del bilancio, che
ulteriori oneri andava registrando anche per gli accer
tamenti controversi del Fisco (manomorta sulle riserve;
imposta R . M. sugli interessi dei depositanti).
C iò m nostante la Cassa di Risparmio di Torino
aumentaci sempre più la sua attività e pertanto si
dovette affrontare nel 1872 il problema di una adatta
sistemazione degli uffici, risolta, pare non troppo feli
cemente. con l’acquisto dello stabile Massimino 111 via
Mercanti 9. pagato L. 65.000 e restaurato convenien
temente. Nel 1885 la Cassa si trasferiva poi 111 sede
più degna nel palazzo Perrone, sito nella medesima
area ove sorge parte dell’attuale sede.
Affiorava intanto il progetto (Consigliere Malvano)
di aprire qualche dipendenza nei quartieri periferici,
per favorire lo spirito di previdenza facilitando il
versamento dei risparmi.
Nel 1879 si addivenne
all’apertura della prima
Succursale in via Saluzzo
9 in Borgo Nuovo e San
Salvano, seguita nel 1887
dalla seconda di piazza
Emanuele Filiberto di
Savoia.
L’accrescersi dei depo
siti e le difficoltà degli
investimenti limitati, pre
mevano sempre più le
iniziative dei prudenti
Consiglien e richiama
vano anche l’attenzione
dello Stato sulla necessità
Salone degli (portelli.
22


















