
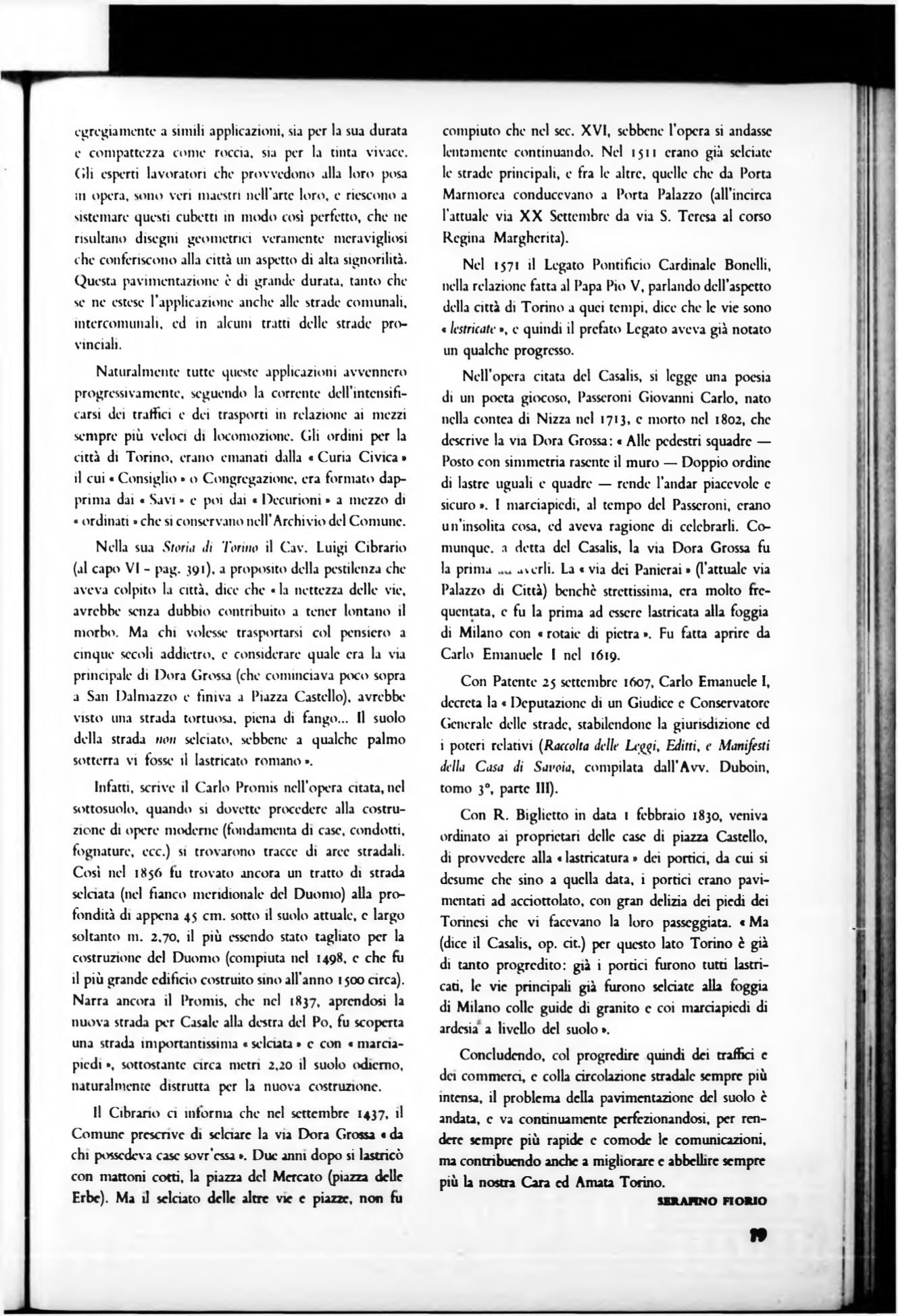
egregiamente a simili applicazioni, sia per la sua durata
e compattezza come roccia, sia per la tinta vivace,
(ìli esperti lavoratori che provvedono alla loro posa
ili
opera, sono veri maestri neU’arte loro, e riescono a
sistemare questi cubetti in modo così perfetto, che ne
risultano disegni geometrici veramente meravigliosi
che conferiscono alla città un aspetto di alta signorilità.
Questa pavimentazione è di grande durata, tanto elu
se ne estese l’applicazione anche alle strade comunali,
intercomunali, ed in alcuni tratti delle strade pro
vinciali.
Naturalmente tutte queste applicazioni avvennero
progressivamente, seguendo la corrente deU’intcnsifi-
carsi dei traffici e dei trasporti in relazione ai mezzi
sempre più veloci di locomozione. Cìli ordini per la
città di Torino, erano emanati dalla « Curia Civica »
il cui « Consiglio » o Congregazione, era formato dap
prima dai « Savi » e poi dai « Decurioni » a mezzo di
«ordinati »che si conservano nell’ Archivio del Comune.
Nella sua
Storili di Torino
il Cav. Luigi Cibrario
(al capo VI - pag. 391), a proposito della pestilenza che
aveva colpito la città, dice che « la nettezza delle vie,
avrebbe senza dubbio contribuito a tener lontano il
morbo. Ma chi volesse trasportarsi col pensiero a
cinque secoli addietro, c considerare quale era la via
principale di Dora Grossa (che cominciava poco sopra
a San Dalmazzo e finiva a Piazza Castello), avrebbe
visto una strada tortuosa, piena di fango... Il suolo
della strada
non
selciato, sebbene a qualche palmo
sotterra vi fosse il lastricato romano ».
Infatti, scrive il Carlo Promis nell’opera citata, nel
sottosuolo, quando si dovette procedere alla costru
zione di opere moderne (fondamenta di case, condotti,
fognature, ecc.) si trovarono tracce di aree stradali.
Così nel 1856 tu trovato ancora un tratto di strada
selciata (nel fianco meridionale del Duomo) alla pro
fondità di appena 45 cm. sotto il suolo attuale, e largo
soltanto m. 2,70, il più essendo stato tagliato per la
costruzione del Duomo (compiuta nel 1498, c che fu
il più grande edificio costruito sino all’anno 1500 arca).
Narra ancora il Promis, che nel 1837, aprendosi la
nuova strada per Casale alla destra del Po, fu scoperta
una strada importantissima « selciata * e con « marcia
piedi », sottostante arca metn 2,20 il suolo odierno,
naturalmente distrutta per la nuova costruzione.
Il
Cibrano ci intornia che nel settembre 1437, il
Comune prescrive di selciare la via Dora Grossa « da
chi possedeva case sovr’essa *. Due anni dopo si lastricò
con mattoni cotti, la piazza del Mercato (piazza delle
Erbe). Ma il selciato delle altre vie e piazze, non fu
compiuto che nel scc.
X V I ,
sebbene l’opera si andasse
lentamente continuando. Nel 15 11 erano già selciate
le strade principali, c fra le altre, quelle che da Porta
Marmorea conduccvano a Porta Palazzo (all’incirca
l’attuale via
X X
Settembre da via S. Teresa al corso
Regina Margherita).
Nel 1571 il Legato Pontificio Cardinale Bonelli,
nella relazione fatta al Papa Pio
V ,
parlando dell’aspetto
della città di Torino a quei tempi, dice che le vie sono
«
lestricate
», e quindi il prefato Legato aveva già notato
un qualche progresso.
Nell’ opera citata del Casalis, si legge una poesia
di un poeta giocoso, Passeroni Giovanni Carlo, nato
nella contea di Nizza nel 17 13 , e morto nel 1802, che
descrive la via Dora Grossa : « Alle pedestri squadre —
Posto con simmetria rasente il muro — Doppio ordine
di lastre uguali e quadre — rende l’andar piacevole e
sicuro ».
I
marciapiedi, al tempo del Passeroni, erano
un’insolita cosa, ed aveva ragione di celebrarli. Co
munque. n detta del Casalis, la via Dora Grossa fu
la prima
averli. La « via dei Panierai » (l’attuale via
Palazzo di Città) benché strettissima, era molto fre
quentata, c fu la prima ad essere lastricata alla foggia
di Milano con « rotaie di pietra ». Fu fatta aprire da
Carlo Emanuele
I
nel 1619.
Con Patente 25 settembre 1607, Carlo Emanuele
I,
decreta la « Deputazione di un Giudice e Conservatore
Generale delle strade, stabilendone la giurisdizione ed
i poteri relativi (
Raccolta delle Leggi, Editti, e Manifesti
della Casa di Savoia,
compilata dall’ A w . Duboin,
tomo 3°, parte III).
Con R . Biglietto in data 1 febbraio 1830, veniva
ordinato ai proprietari delle case di piazza Castello,
di provvedere alla « lastricatura » dei portici, da cui si
desume che sino a quella data, i portici erano pavi
mentati ad acciottolato, con gran delizia dei piedi dei
Torinesi che vi facevano la loro passeggiata. « Ma
(dice il Casalis, op. cit.) per questo lato Torino è già
di tanto progredito: già i portici furono tutti lastri
cati, le vie principali già furono selciate alla foggia
di Milano colle guide di granito e coi marciapiedi di
ardesia a livello del suolo ».
Concludendo, col progredire quindi dei traffici e
dei commerci, e colla circolazione stradale sempre più
intensa, il problema della pavimentazione del suolo è
andata, e va continuamente perfezionandosi, per ren
dere sempre più rapide e comode le comunicazioni,
ma contribuendo anche a migliorare e abbellire sempre
più la nostra Cara ed Amata Torino.
SERAFINO
F I
ORIO
ff


















