
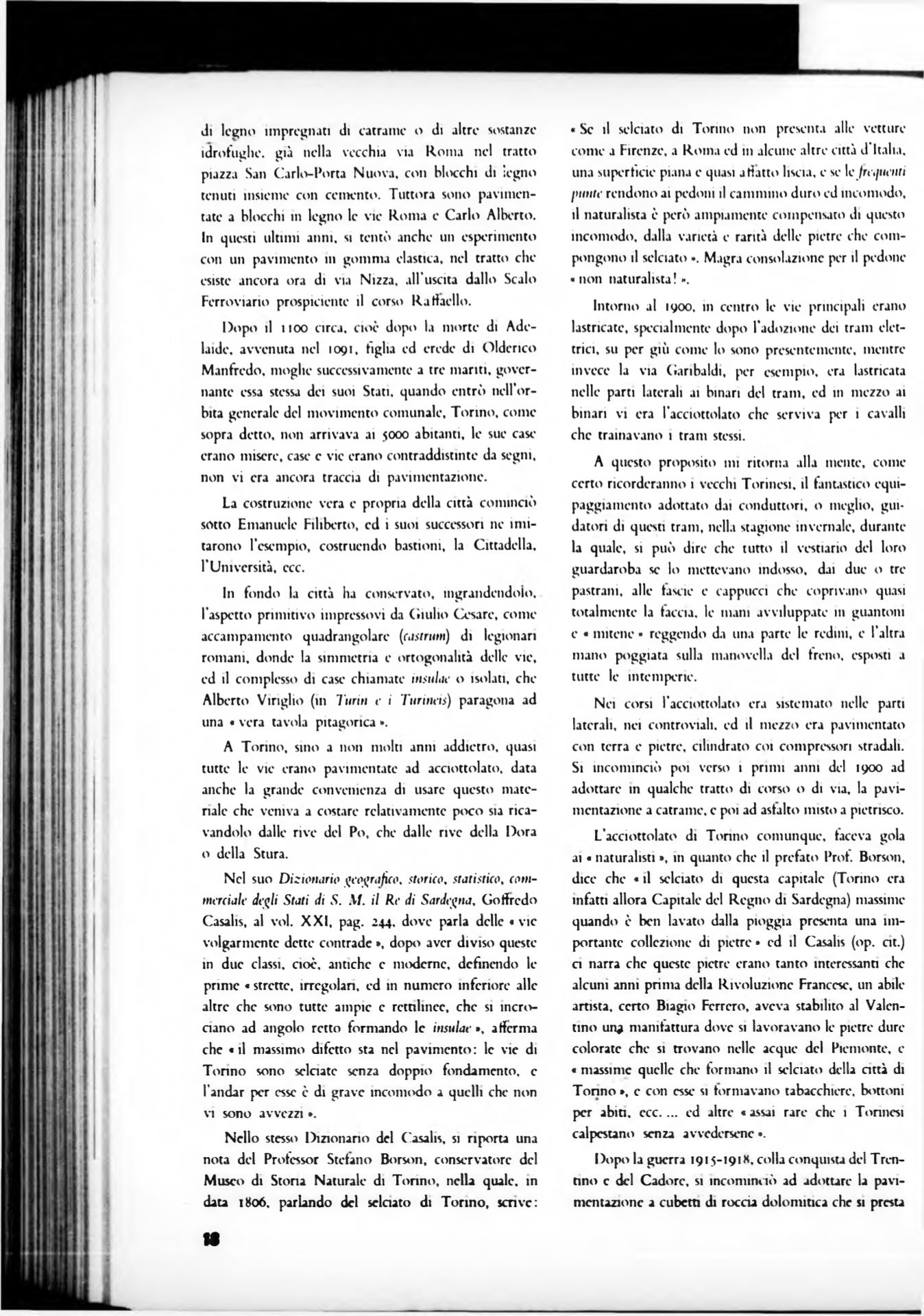
di legno impregnati di catrame o di altre sostanze
idrofughe, già nella vecchia via Roma nel tratto
piazza San Carlo-Porta Nuova, con blocchi di legno
tenuti insieme con cemento. Tuttora sono pavimen
tate a blocchi m legno le vie Roma e Carlo Alberto.
In questi ultimi anni, si tentò anche un esperimento
con un pavimento 111 gomma elastica, nel tratto che
esiste ancora ora di via Nizza, all’ uscita dallo Scalo
Ferroviario prospiciente il corso Raffaello.
Dopo il i
i o o
circa, cioè dopo la morte di Ade
laide, avvenuta nel 1091, figlia ed erede di Oldenco
Manfredo, moglie successivamente a tre mariti, gover
nante essa stessa dei suoi Stati, quando entrò nell’or
bita generale del movimento comunale, Torino, come
sopra detto, non arrivava ai 5000 abitanti, le sue case
erano misere, case e vie erano contraddistinte da segni,
non vi era ancora traccia di pavimentazione.
La costruzione vera e propria della città cominciò
sotto Emanuele Filiberto, ed i suoi successori ne imi
tarono l’esempio, costruendo bastioni, la Cittadella,
l’ Università, ecc.
In fondo la città ha conservato, ingrandendolo,
l’aspetto primitivo impressovi da Giulio Cesare, come
accampamento quadrangolare (
castrum
) di legionari
romani, donde la simmetria e ortogonalità delle vie,
ed il complesso di case chiamate
insula?
o isolati, che
Alberto Viriglio (111
Turiti e i Turineis)
paragona ad
una « vera tavola pitagorica ».
A Torino, sino a non molti anni addietro, quasi
tutte le vie erano pavimentate ad acciottolato, data
anche la grande convenienza di usare questo mate
riale che veniva a costare relativamente poco sia rica
vandolo dalle rive del Po, che dalle rive della Dora
o della Stura.
Nel suo
Dizionario geografico, storico, statistico, com
merciali- digli Stati di S. M. il Re di Sardegna,
Goffredo
Casalis, al voi. XX I, pag. 244. dove parla delle « vie
volgarmente dette contrade », dopo aver diviso queste
in due classi, cioè, antiche e moderne, definendo le
prime « strette, irregolari, ed in numero inferiore alle
altre che sono tutte ampie e rettilinee, che si incro
ciano ad angolo retto formando le
insulae »,
afferma
che «il massimo difetto sta nel pavimento: le vie di
Tonno sono selciate senza doppio fondamento, e
l'andar per esse è di grave incomodo a quelli che non
vi sono avvezzi ».
Nello stesso Dizionario del Casalis, si riporta una
nota del Professor Stetano Borson, conservatore del
Museo di Stona Naturale di Torino, nella quale, in
data 1806. parlando del selciato di Tonno, scnvc:
« Se il selciato di Torino non presenta alle vetture
come a Firenze, a Roma ed 111 alcune altre città d’ Italia,
una superficie piana e quasi affatto liscia, e se
\cjri\juenti
lìmite
rendono ai pedoni il cammino duro ed incomodo,
il naturalista è però ampiamente compensato di questo
incomodo, dalla varietà e rarità delle pietre che com
pongono il selciato ». Magra consolazione per il pedone
« non naturalista! ».
Intorno al 1900. in centro le vie principali erano
lastricate, specialmente dopo l’adozione dei tram elet
trici, su per giù come lo sono presentemente, mentre
invece la via Garibaldi, per esempio, era lastricata
nelle parti laterali ai binari del tram, ed 111 mezzo ai
binari vi era l’acciottolato che serviva per 1 cavalli
che trainavano 1 tram stessi.
A questo proposito 1111 ritorna alla mente, come
certo ricorderanno 1 vecchi Torinesi, il fantastico equi
paggiamento adottato dai conduttori, o meglio, gui
datori di questi tram, nella stagione invernale, durante
la quale, si può dire che tutto il vestiario del loro
guardaroba se lo mettevano indosso, dai due o tre
pastrani, alle tascie e cappucci che coprivano quasi
totalmente la taccia, le mani avviluppate 111 guantoni
e « mitene » reggendo da una parte le redini, e l’altra
mano poggiata sulla manovella del freno, esposti a
tutte le intemperie.
Nei corsi l'acciottolato era sistemato nelle parti
laterali, nei controviali, ed il mezzo era pavimentato
con terra e pietre, cilindrato coi compressori stradali.
Si incominciò poi verso 1 primi anni del 1900 ad
adottare in qualche tratto di corso o di via, la pavi
mentazione a catrame, e poi ad astalto misto a pietrisco.
L’acciottolato di Tonno comunque, faceva gola
ai « naturalisti », 111 quanto che il prefato Prof. Borson,
dice che « il selciato di questa capitale (Torino era
infatti allora Capitale del Regno di Sardegna) massime
quando è ben lavato dalla pioggia presenta una im
portante collezione di pietre » ed il Casalis (op. cit.)
ci narra che queste pietre erano tanto mteressann che
alcuni anni prima della Rivoluzione Francese, un abile
artista, certo Biagio Ferrerò, aveva stabilito al Valen
tino un^ manifattura dove si lavoravano le pietre dure
colorate che si trovano nelle acque del Piemonte, e
« massime quelle che formano il selciato della città di
Tonno *, e con esse si tornavano tabacchiere, bottoni
per abin. e c c .... ed altre « assai rare che 1 Tonnesi
calpestano senza avvedersene ».
Dopo la guerra 19 15-19 18 , colla conquista del Tren-
nno e del Cadore, si incominciò ad adottare la pavi
mentazione a cubetti di roccia dolomitica che si presu
l i


















