
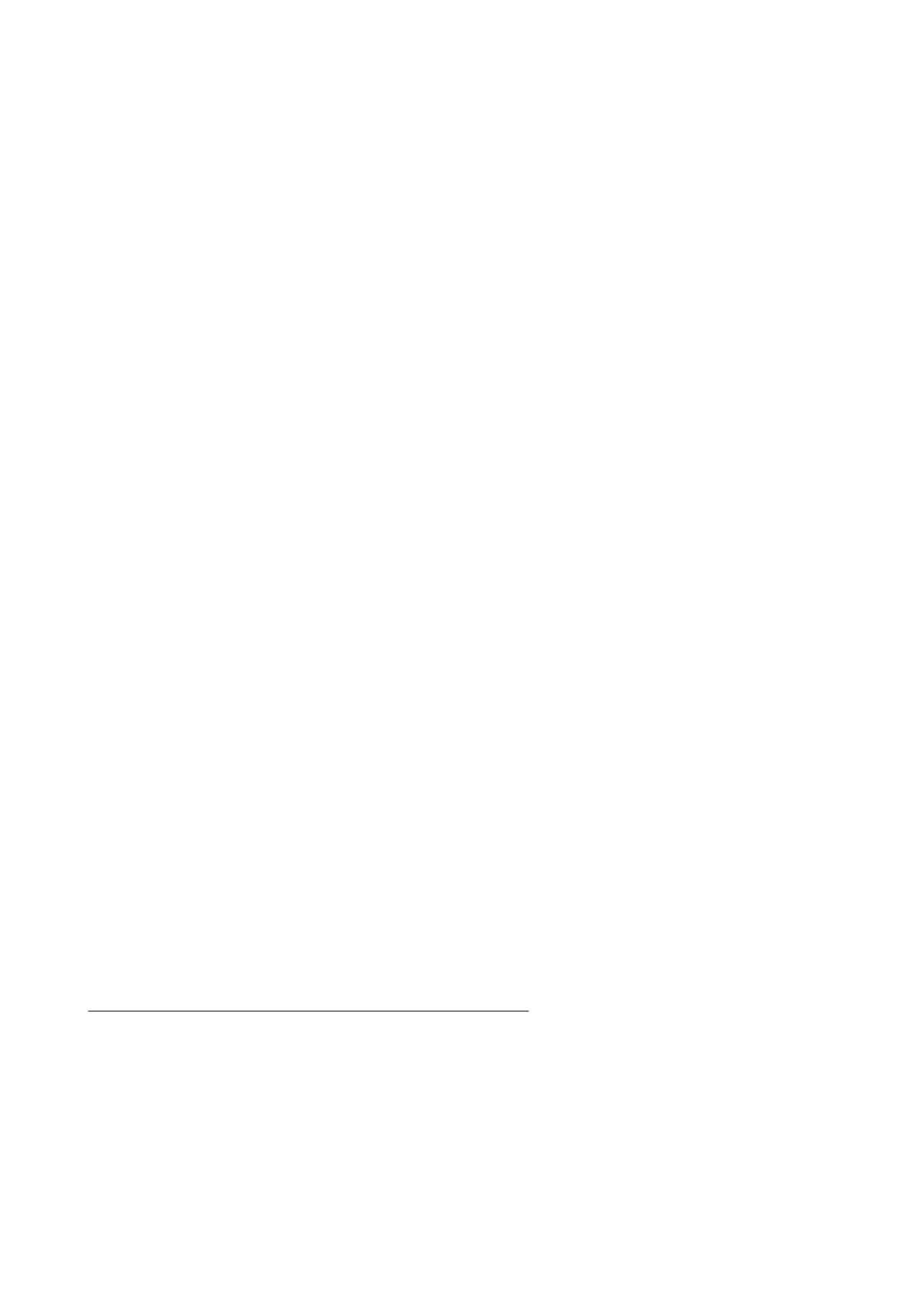
Strutture militari nei borghi e nelle
borgate
Silvia Bertelli
Mentre è ben noto il ruolo giocato dall’industria nella formazione e nel consolidamen-
to di borgate e borghi nelle aree più o meno esterne alla “città barocca”, analoga atten-
zione non è stata finora dedicata ad un altro fenomeno che, nella Torino del XIX secolo,
ha influito – a volte in modo determinante – sulla strutturazione di interi nuovi pezzi di
città: l’uso delle aree e la localizzazione delle proprie strutture, gestiti dall’esercito secon-
do specifiche strategie militari. Alcuni dati conoscitivi su tale fenomeno sono pertanto il
contenuto delle seguenti note.
La vocazione militare di Torino in età moderna è ben nota, sin dai tempi di Emanuele
Filiberto quando, a seguito dello spostamento della capitale del ducato, nel 1564 venne
eretta la cittadella, poi arricchita dal poderoso sistema bastionato, reso inoffensivo in età
napoleonica.
A seguito di quest’operazione di disarmo si riplasma la città ottocentesca, sino alla smi-
litarizzazione della fortezza cinquecentesca (1846) e alla costituzione di una nuova piazza
d’armi
1
. Una prima fase di ridisegno urbano in rapporto alle esigenze militari si ha appunto
in questi anni, con i piani elaborati da Carlo Promis: interprete delle attività progettuali
nell’area dell’ex cittadella, media tra municipalità e Ministero della Guerra, studia la di-
sposizione di una nuova cinta daziaria e di alcuni grandi servizi urbani, come la stazione
ferroviaria di porta Susa. Con il
Piano d’Ingrandimento della Capitale
(1850-1852)
2
e il
Piano di ingrandimento della città di
Torino sopra i terreni gravanti di servitù Militare e cir-
condanti la Cittadella a levante e tramontana
(1852) viene riprogettata concettualmente
la città, mentre la relazione annessa ai piani specifica la strategia militare del collegamento
tra il previsto nuovo nucleo di caserme e i settori più delicati dal punto di vista difensivo.
«Volendosi destinare la Cittadella specialmente a caserme, le communicazioni sue coll’O-
spedale militare divisionale [Santa Croce], colla strada delle Vaude, colla Piazza d’Armi e
colla Città, debbono essere brevi, facili e pronte. Acciò fu provvisto colla Strada di circon-
vallazione che la ricinge parallelamente al proposto ingrandimento [...] e conservando, per
via esteriore, gli accessi a piazza d’Armi dalle Caserme di Porta Susa si ottenne eziandio
che la Strada di circonvallazione per carri e pedoni fasciante l’abitato di Torino, qui non
avesse a cessare; cosicché i voluminosi trasporti potessero in massima parte evitare le vie
1
Le esigenze di urbanizzazione ed espansione della città provocano continui spostamenti delle piazze
d’armi. Prima dell’epoca napoleonica le esercitazioni militari si svolgevano nelle piazze cittadine; con il
Plan
Général d’embellissement pour la ville de Turin
[...] del 1809, si progetta una piazza d’armi vicino alla porta
di Po, un’idea ripresa durante la Restaurazione, ma mai realizzata. Si conferma invece la piazza d’armi di San
Secondo a ovest di porta Nuova (dal 1817, realizzata nel 1822 fra i corsi Matteotti, Ferraris e le vie Volta,
Camerana e Assietta), che verrà riallocata, mantenendo lo stesso nome, più a meridione della cittadella con
il piano Promis, nell’area tra i corsi Matteotti, Re Umberto, Stati Uniti e Vinzaglio, Duca degli Abruzzi, dal
1847. Un ulteriore spostamento avviene infine in borgo Crocetta dal 1872 nell’area fra i corsi Ferraris, Einaudi,
Castelfidardo e Montevecchio. L’individuazione conclusiva dell’area da destinare alle manovre militari prende
infine forma nell’isolato, a ovest della borgata Molinette, definito dai corsi IV Novembre, Ferraris, Montelungo
e Sebastopoli, con la convenzione del 1904.
2
Il piano complessivo ne comprendeva in realtà tre settoriali:
Piano Fuori Porta Nuova
(sud),
Ingrandimento
parziale fuori Porta Susa e sulla regione Valdocco
(ovest) e
Ingrandimento della città nel quartiere Vanchiglia
e sue attinenze
(nord-est). Sul piano cfr. Comoli Mandracci, 1983, pp. 149-190.


















