
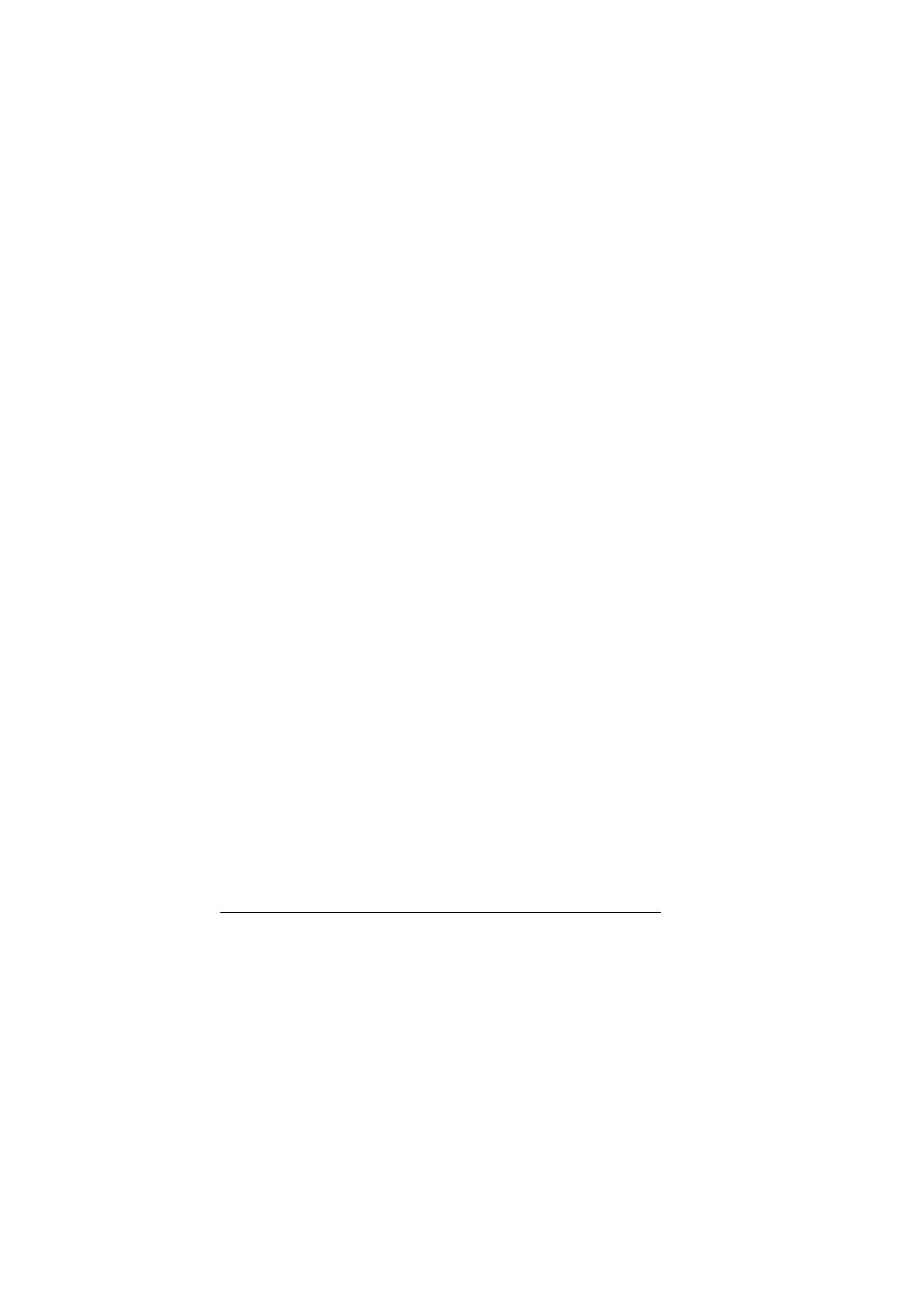
48
collegata all’industria della guerra: l’arsenale militare e la fonderia annessa, le fabbriche
d’armi di Valdocco e borgo Dora. Le manifatture per le armi pesanti e leggere forniscono
all’epoca lavorazioni tra le più elaborate tecnologicamente sul mercato europeo
7
; tanto
che nel 1865 la maggior parte della produzione militare italiana (non solo l’industria del-
le armi, ma anche la produzione di contorno come equipaggiamento, vestiario, razioni
alimentari) è insediata a Torino. Lo sviluppo industriale di metà Ottocento imprime segni
indelebili sul tessuto della città, con opifici e ciminiere che divengono tratti caratteristi-
ci del paesaggio urbano: non solo nelle aree periferiche, ma anche in zone adiacenti al
centro più antico come borgo Dora, uno degli insediamenti produttivi più vitali della città
negli anni trenta-quaranta, dove da secoli dominavano la regia polveriera
8
e il complesso
dei Molassi, i mulini da grano più importanti di Torino. Il
Piano Unico Regolatore e d’Am-
pliamento
del 1908 razionalizza quindi lo sfruttamento dei terreni al di fuori della cinta
daziaria del 1853, organizzando non solo le aree industriali nei borghi operai, ma anche
alcuni immobili dell’esercito. Ad inizio Novecento, inoltre, alcune fabbriche vengono ri-
levate e riutilizzate dall’Amministrazione militare. Il gallettificio militare di via Modena 9
(borgata Aurora) già della Società Anonima Torinese di Panificazione è acquisito nel 1908;
nel sito del lanificio Piacenza (1911-1920) di via Bologna (borgo Regio Parco) si insedia
il magazzino di artiglieria e difesa chimica (MArDiChi); in corso Regina Margherita 16, in
borgo Vanchiglia, l’edificio della Venchi & Unica (1907), circa trenta anni dopo diviene
un opificio militare per la fabbricazione di oggetti in cuoio; l’attuale caserma dell’esercito
Carlo Amione in borgata Campidoglio nasce come trasformazione della ex SCAT (Società
Ceirano Automobili Torino)
9
.
Una seconda fase di fervida attività costruttiva per “Torino militare” è rappresentata
dalla convenzione del 14 aprile 1904 fra il Municipio di Torino (sindaco Frola) e l’Ammini-
strazione della Guerra, rappresentata dalla Direzione Genio Militare di Torino (colonnello
Chiarle). Da anni ormai le caserme appaiono inidonee per il numero, la localizzazione stra-
tegica nel territorio e le normative igieniche; inoltre la costante espansione dell’urbaniz-
zato incrina sempre più la convivenza fra strutture militari e civili.
La convenzione prevede che l’Amministrazione della Guerra accetti «di trasferire il suo
diritto d’uso perpetuo sull’attuale piazza d’Armi della Crocetta in altre due piazze d’Armi
acquistate e sistemate a spese e cura del Municipio di Torino»
10
. Il Comune si assume
l’obbligo, quindi, di costruire a proprie spese e concedere in uso perpetuo (artt. IV-V) una
piazza d’armi (oggi parco Cavalieri di Vittorio Veneto) dell’estensione di circa trenta ettari
compresa tra i viali Stupinigi (corso Unione Sovietica) e Orbassano; inoltre una seconda,
Vanchiglia
, con una superficie di sei ettari nell’attuale parco Crescenzio, due caserme per
la truppa di linea, una per le truppe di cavalleria, un ospedale militare divisionale e infine
alcuni fabbricati di servizio per l’Accademia Militare e la Scuola d’Applicazione di Artiglieria
e Genio, in prossimità della barriera di Francia (fig. 4)
11
. Non vengono prescritte priorità,
come precisa la convenzione:«L’ordine secondo cui saranno intraprese le nuove fabbri-
che come pure le loro particolarità saranno di esclusiva competenza dell’Amministrazione
7
Al competitivo sviluppo tecnologico dell’esercito italiano hanno contribuito personalità di ingegno quali
Giovanni Cavalli, Luigi Federico Menabrea e Giovanni Castellazzi; inoltre Menabrea ha progettato il quartiere
di cavalleria S. Antonio e Castellazzi l’arsenale di borgo Dora e le caserme Cernaia e Podgora.
8
Nell’area poi occupata dall’arsenale, dal 1580 esisteva la polveriera voluta da Emanuele Filiberto, abbando-
nata dopo i danni subiti per lo scoppio dei magazzini delle polveri nel 1852.
9
L’azienda nata nel 1906 in via Madama Cristina, otto anni dopo si era trasferita in corso Francia 142 (angolo
piazza Rivoli); fra il 1921 e il 1939, dall’unione dei vari edifici industriali, la struttura diviene definitivamente un
immobile del Genio Militare.
10
Costruzioni e permuta degli stabili militari - Convenzione
in ASCT,
Deliberazioni e verbali del Consiglio
Comunale
, 15 aprile 1904, p. 387. La convenzione è stabilita il 14 aprile, ma approvata con seduta consiliare il
giorno successivo.
11
Nella carta della
Città di Torino
, in allegato alla delibera del 15 aprile 1904, sono evidenziati, in rosa con le
lettere, gli edifici ceduti
dall’Amministrazione della Guerra al Municipio
, in verde con i numeri romani, i terreni
comunali dati in permuta alla Direzione Genio Militare di Torino. Gli edifici militari in progetto sono disposti sul
perimetro della
nuova Piazza d’Armi a sud
(terreno I): l’
Infermeria Cavalli
(III) collegata all’appezzamento IV in
cui è prevista la caserma di cavalleria Vittorio Dabormida su corso Unione Sovietica, in prosecuzione sul viale
la caserma di fanteria Tommaso Morelli di Popolo (V), un’altra caserma di fanteria (VI), la Montegrappa (prima
Alessandro Lamarmora), in corso IV Novembre sul lato nord della piazza e infine a occidente, sullo stesso cor-
so, l’ospedale militare intitolato ad Alessandro Riberi (VII).


















