
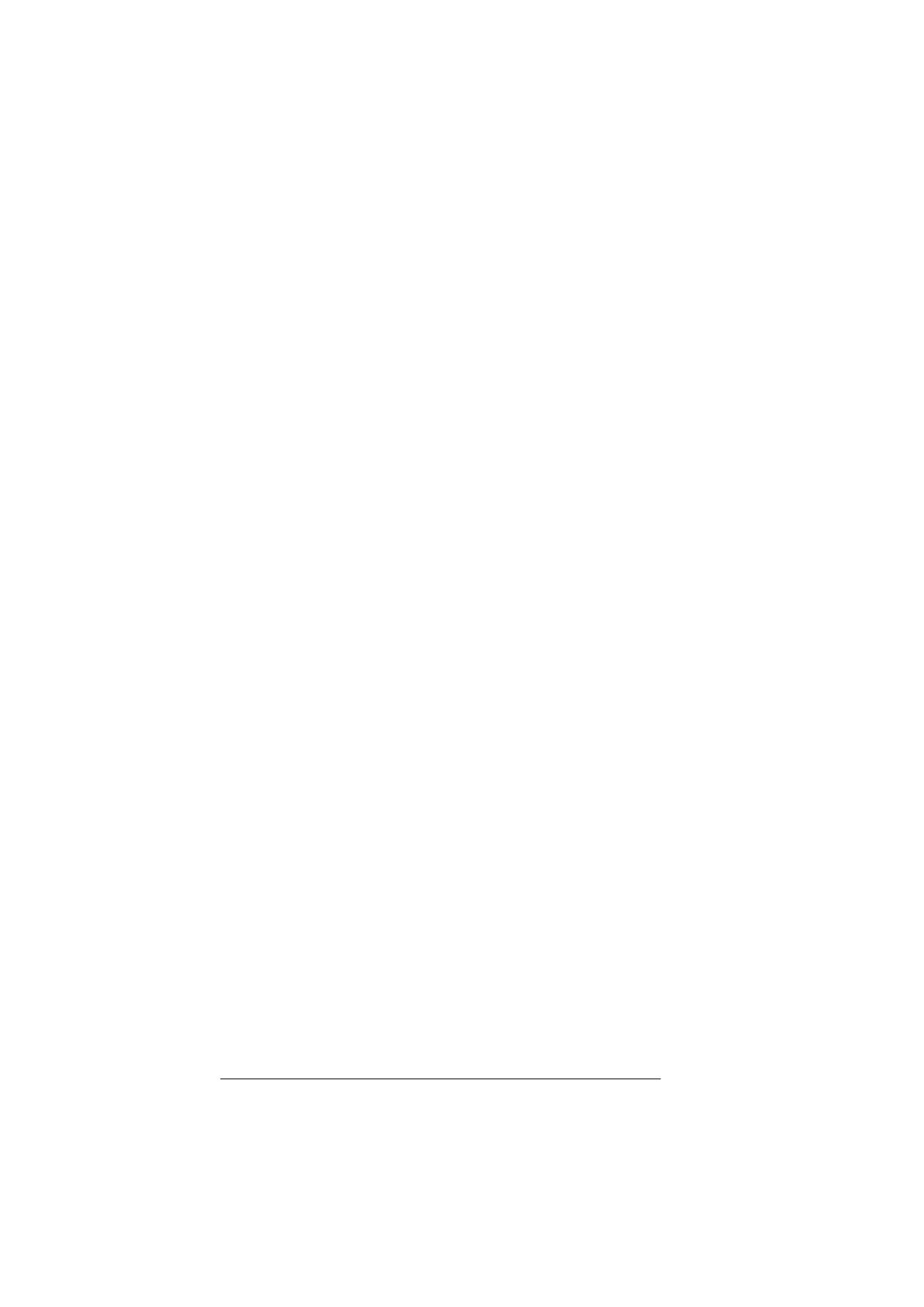
56
diffusi da alcune pubblicazioni
5
. La prima è stata realizzata come catalogo della mostra
organizzata nella primavera del 1984 nella sede centrale dell’Ateneo, fornendo i primi dati
riassuntivi; la seconda è stata pubblicata in due volumi dalla SIAT (Società Ingegneri e
Architetti di Torino) nello stesso anno e contiene dati dettagliati sia sui caratteri generali
del lavoro, sia sull’
individuazione
e
classificazione
dei Beni (mediante relazioni, schede
ed elaborati grafici) nei 23 quartieri in cui era allora suddiviso il territorio comunale, sia
ancora sui riferimenti storici, critici e documentari adottati durante il pluriennale lavoro.
In merito agli esiti della ricerca emergeva quindi un giudizio critico dalle due giornate di
studio del maggio 1985, alle quali partecipavano numerosi esperti italiani e stranieri, giu-
dizio di cui dà conto il volume di atti
Storia e architettura della città
(1986).
Rimando pertanto a queste ormai “vecchie” pubblicazioni per quanto concerne la co-
noscenza dei principi generali, delle motivazioni e delle scelte allora effettuate dal gruppo
di ricerca, mentre ritengo invece indispensabile, a trent’anni di distanza, un ripensamento
critico sulla validità nel tempo dei risultati del lavoro degli anni ottanta.
L’importanza e l’originalità che credo vada tuttora attribuita a quella ricerca sul patri-
monio architettonico ambientale torinese è la sua scala, rivolta all’intero territorio comu-
nale e ai sistemi urbani anziché ai singoli edifici. In quel periodo aveva infatti ancora larga
diffusione il concetto per cui il «bene culturale» era da riferirsi, nel campo dell’edificato, al
«monumento» (chiesa, castello, palazzo...) isolato dal proprio contesto
6
.
Ritornando alla ricerca del 1984, si può constatare che gli studi approfonditi sul sistema
viario (
assi rettori della composizione urbanistica
e
direttrici storiche di sviluppo
), nonché
quelli sulle
aree ambientali fluviali
e sui
complessi ambientali collinari
mantengono tutto-
ra una intrinseca validità, che permette di valutare (in senso per lo più negativo) le trasfor-
mazioni succedutesi nel frattempo
7
.
L’individuazione di sistemi urbani a vasta scala veniva completata con lo studio, per
ciascun quartiere torinese, degli
insediamenti urbani
e dell’edificato (insiemi o singole co-
struzioni) categorie previste in specifico dalla L.R. 56/77
8
.
L’analisi dell’architettura, restituita in singole schede, se valutata attraverso l’odierna
lettura critica
a posteriori
, risulta il settore meno significativo della ricerca (anche se il più
conosciuto) per vari motivi. Anzitutto perché, a differenza degli altri temi – esaminati da
pochi e piccoli gruppi di ricercatori, organizzati con un rigido coordinamento ai vari livelli
9
–, questo studio è stato condotto da singoli esperti, incaricati sulla scorta di pregresse
competenze scientifiche, e risente pertanto di notevoli squilibri nei livelli di informazione
e di approfondimento, e ancor più è carente di tarature sull’intero territorio urbano. In
secondo luogo, mentre si deve riconoscere al lavoro il merito di aver posto all’attenzio-
ne categorie di edifici (come cascine, complessi industriali, quartieri di edilizia popolare)
pressoché ignorati dalla storiografia degli anni ottanta, è altrettanto necessario segnalare
che, anche quantitativamente, l’individuazione di soggetti degni di considerazione risulta
del tutto sperequata nelle varie zone della città.
Di assoluta preminenza rispetto agli altri settori della ricerca, anche per gli effetti reali
che per decenni produrrà sul territorio
10
, risulta invece lo studio su
insediamenti e ambiti
urbani
, ove l’ambito – come allora scrivevo – può definirsi «una porzione di città nella qua-
le sono ancora riconoscibili l’impianto urbanistico ed il tessuto edilizio caratteristici delle
diverse fasi storiche dello specifico processo di costruzione», precisando che ogni ambito,
in ogni zona urbana, costituisce «un “centro storico” di ridotte dimensioni» con caratteri-
stiche specifiche legate alle fasi di formazione e trasformazione e con rapporti identifica-
bili con la complessità dell’organismo urbano, entrambi tuttora riconoscibili. Gli elementi
riconosciuti come strutturanti un ambito, individuati sulla scorta di indagini preliminari
5
Cfr. rispettivamente: Comoli, Viglino, 1984;
Beni culturali ambientali
, 1984; Viglino, 1986.
6
Basti ricordare che l’attuale Soprintendenza ai «Beni architettonici e del paesaggio» aveva la denominazio-
ne di Soprintendenza ai «Monumenti».
7
Cfr., nell’ordine, in
Beni culturali ambientali
, 1984: Comoli, Viglino, pp. 61-130; Re, Sistri, pp. 131-167;
Defabiani, Roggero, Scarzella, Vinardi, pp. 168-199.
8
Cfr. nota 1.
9
Cfr. nota 4.
10
I settori urbani indicati come nuclei di valore storico-ambientale sono stati assunti come degni di tutela
anche dal recente piano regolatore detto «Gregotti-Cagnardi».


















