
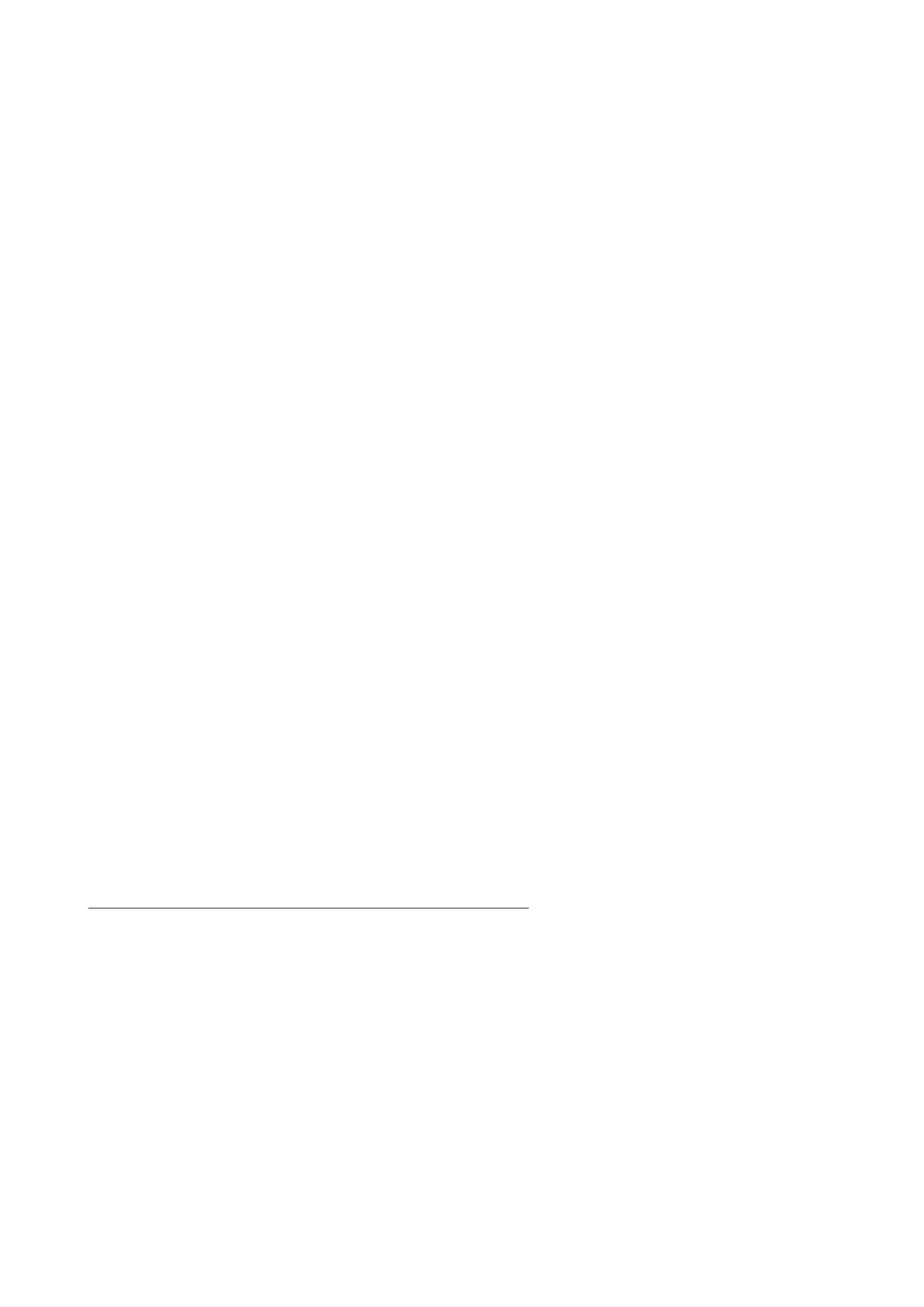
57
fondate su parametri storici e sul rilevamento in sito per verificarne la persistenza, risul-
tano: «i rapporti urbanistici, la dimensione microurbana e la connotazione ambientale»
11
.
Il successivo raffronto tra gli ambiti urbani e la struttura storica della città, studiato da
Vera Comoli e ripreso in seguito dalla sottoscritta
12
, permetteva di identificare in gran par-
te dei borghi e delle borgate oggetto del presente studio i nuclei costituenti. Si ritrovano
ad esempio l’ambito di borgo Po tra i
Primi ampliamenti neoclassici ottocenteschi
, i borghi
San Donato, Dora, Madonna del Pilone tra i
borghi extramuranei
[...]
incorporati nella
pianificazione dell’Ottocento
, e ancora Vanchiglia, Crocetta, Campidoglio, Lucento, Regio
Parco e le borgate operaie tipiche
della fase di industrializzazione della città
come San
Paolo, Aurora, Montebianco e Monterosa, e ancora Bertolla tra le
borgate di originario
impianto rurale
13
.
Si veniva configurando così una organizzazione territoriale che, per la parte piana della
città, individuava – fuori dell’area centrale aulica di Torino – tanti piccoli “centri storici”,
documenti materiali delle varie fasi dell’insediamento urbano, centri che sono tuttora il
cuore dei borghi e delle borgate che qui esaminiamo (fig. 1).
Gli studi sulla struttura storica della città per il PRGC (1990-1992)
Ai progettisti milanesi Vittorio Gregotti e Augusto Cagnardi, incaricati di redigere il
nuovo piano regolatore per il Comune di Torino, con il compito di approfondire la cono-
scenza della struttura insediativa formatasi nel tempo, veniva affiancato come consulente
storico Leonardo Benevolo. Forse influenzato dalla tanto celebrata scacchiera della più
antica “città quadrata”, il celebre studioso, in un primo momento, individuava come set-
tori caratterizzanti il tessuto urbano torinese quelli con lottizzazione a maglia ortogonale,
indipendentemente dalla loro localizzazione e dalle varie specifiche vicende formative e
trasformative. Venuto poi a conoscenza degli studi precedentemente compiuti dai gruppi
del Politecnico, Benevolo stesso rinunciava all’incarico.
Con una scelta molto discutibile dal punto di vista storico, e non solo, il territorio co-
munale veniva disaggregato, separando la «zona centrale di Torino» (ancora la vecchia
concezione del “centro storico”!) di cui verificare le valenze alla scala edilizia, mentre per
le aree rimanenti il patrimonio da individuare in funzione delle esigenze pianificatorie do-
veva riguardare la struttura urbanistica oltre alle costruzioni
14
. Con la stessa logica sparti-
toria, la ricerca veniva affidata a due diversi dipartimenti del Politecnico: quella sulla zona
centrale al DISET
15
ove lavoravano gli allievi di Augusto Cavallari Murat che con lui avevano
partecipato alla ricerca poi illustrata nei celebri volumi
Forma urbana ed architettura nella
Torino barocca
(1968), l’altra ricerca al DICAS che, riguardando tutte le aree in cui sono
localizzati i borghi e le borgate, intendo qui illustrare in modo più puntuale.
La convenzione tra il dipartimento Casa-città e il Comune di Torino (1990-1991) espli-
cita già nel titolo «Ricerca storico-critica sui valori qualitativi dell’edificato e della struttura
urbanistica della città di Torino» i contenuti del lavoro, svolto da un gruppetto di studiosi
16
11
Cfr. Viglino, 1984, pp. 217-223.
12
Comoli, 1984, pp. 224-231; Viglino, 1986, pp. 65-68.
13
Si tenga presente che non vi è sempre corrispondenza tra i termini «borgo» o «borgata» adottati nella
ricerca (1984) e quelli nel presente studio: là si sono usati i termini di uso comune, ora si fa distinzione (come
meglio chiarito negli altri saggi) tra i borghi, nuclei di più antico insediamento, e le borgate, nate nel XIX secolo
in relazione alle porte della prima cinta daziaria del 1853. Un esempio: la borgata San Paolo nell’accezione
comune è citata come «borgo San Paolo».
14
La diversa scala di approfondimento voluta per la zona centrale e per le rimanenti si è riflessa con spere-
quazioni macroscopiche sulla normativa di piano e sui relativi gradi di tutela previsti. Nella prima situazione
l’analisi dettagliata sui singoli organi dell’edificio (androni, scale, caratteri costruttivi particolari...) ne ha per-
messo precise indicazioni anche settoriali per la conservazione, mentre così non è stato per i singoli manufatti
localizzati nelle aree esterne al perimetro delle fortificazioni settecentesche. Viceversa una più attenta norma-
tiva per la salvaguardia è stata dedicata dal PRGC, come vedremo, ai settori urbani caratterizzanti nelle zone
non centrali, valutandone i sistemi viari e di lottizzazione, gli impianti urbanistici ecc., oltre all’edificato, in una
scala sottostimata invece nel cosiddetto centro storico.
15
Al dipartimento
Sistemi edilizi e territoriali
veniva affidata la ricerca, secondo la convenzione con il Comune
(1991), per lo studio della «Caratterizzazione edilizia del tessuto urbano storico nella zona centrale di Torino».
16
Il gruppo di ricerca, con coordinatore scientifico Vera Comoli, e responsabili della ricerca Vera Comoli
e Micaela Viglino, era formato da Andrea Barghini, Vittorio Defabiani, Vilma Fasoli, Giovanni Lupo, Guido


















