
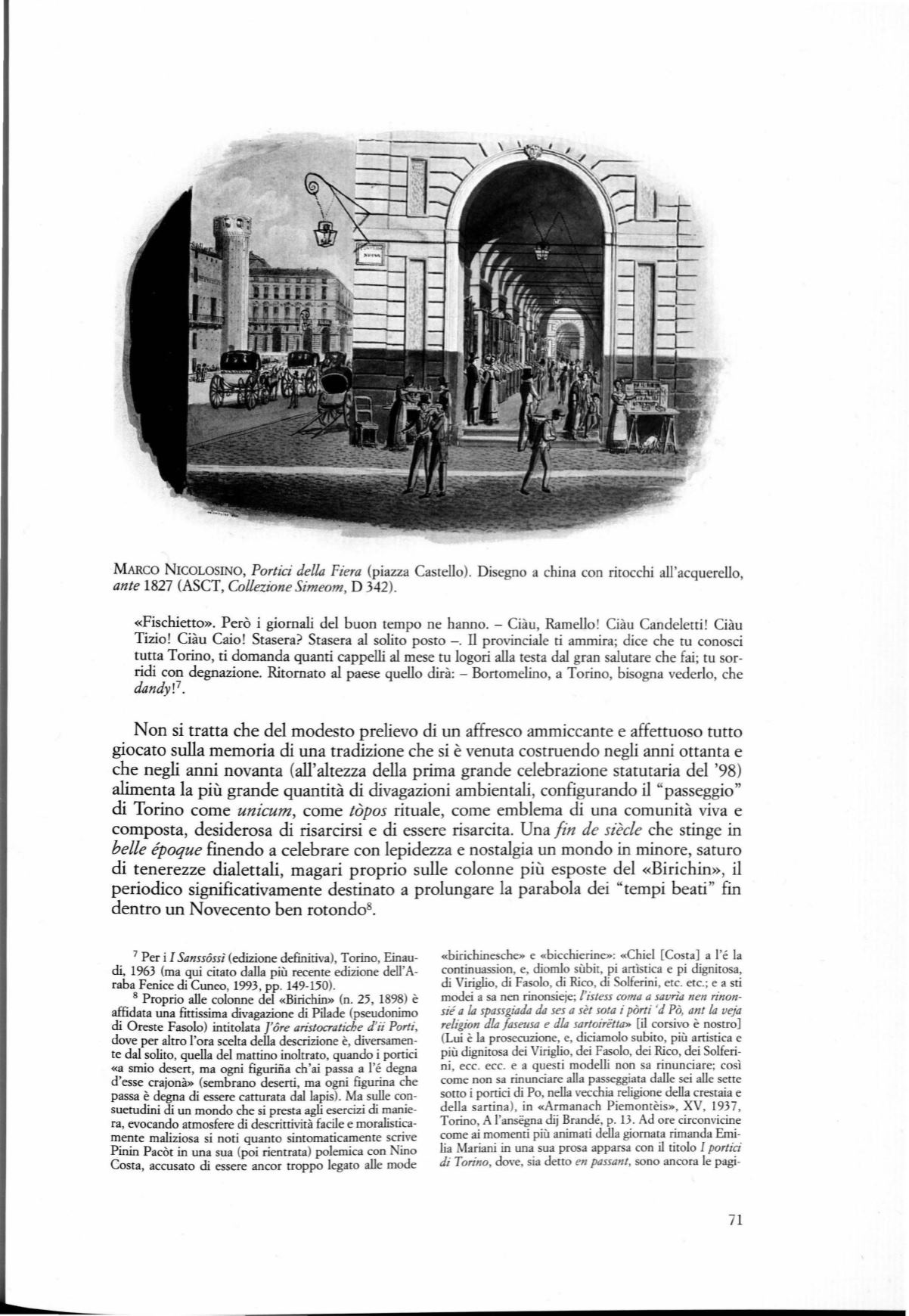
MARCO NICOLOSINO,
Portici della Fiera
(piazza Castello). Disegno a china con ritocchi all'acquerello,
ante
1827 (ASCT,
Collezione Simeom ,
D 342).
«Fischietto». Però i giornali del buon tempo ne hanno. - Ciàu, Ramello! Ciàu Candeletti! Ciàu
Tizio! Ciàu Caio! Stasera? Stasera al solito posto - . TI provinciale ti ammira; dice che tu conosci
tutta Torino, ti domanda quanti cappelli al mese tu logori alla testa dal gran salutare che fai; tu sor–
ridi con degnazione. Ritornato al paese quello dirà: - Bortomelino, a Torino, bisogna vederlo, che
dandy!7.
Non si tratta che del modesto prelievo di un affresco ammiccante e affettuoso tutto
giocato sulla memoria di una tradizione che si è venuta costruendo negli anni ottanta e
che negli anni novanta (all'altezza della prima grande celebrazione statutaria del '98)
alimenta la più grande quantità di divagazioni ambientali, configurando
il
"passeggio"
di Torino come
unicum,
come
fÒpOS
rituale, come emblema di una comunità viva e
composta, desiderosa di risarcirsi e di essere risarcita. Una
/in de siècle
che stinge in
belle époque
finendo a celebrare con lepidezza e nostalgia un mondo in minore, saturo
di tenerezze dialettali, magari proprio sulle colonne più esposte del «Birichin», il
periodico significativamente destinato a prolungare la parabola dei "tempi beati" fin
dentro un Novecento ben rotondo
8 •
7
Per i
I
Sanssossì
(edizione definitiva), Torino, Einau–
di, 1963 (ma qui citato dalla più recente edizione dell'A–
raba Fenice di Cuneo, 1993, pp. 149-150).
8
Proprio alle colonne del «Birichin» (n. 25, 1898) è
affidata una fittissima divagazione di Pilade (pseudonimo
di Oreste Fasolo) intitolata
l'ore aristocratiche d'ii Porti,
dove per altro l'ora scelta della descrizione è, diversamen–
te dal solito, quella del mattino inoltrato, quando i portici
«a smio desert, ma ogni figurma ch'ai passa a l'é degna
d'esse crajonà» (sembrano deserti, ma ogni figurina che
passa è degna di essere catturata dal lapis). Ma sulle con–
suetudini di un mondo che si presta agli esercizi di manie–
ra, evocando atmosfere di descrittività facile e moralistica–
mente maliziosa si noti quanto sintomaticamente scrive
Pinin Pacòt in una sua (poi rientrata) polemica con Nino
Costa, accusato di essere ancor troppo legato alle mode
«birichinesche» e «bicchierine»: «Chiel [Costa] a l'é la
continuassion, e, diomlo sùbit, pi artìstica e pi dignitosa,
di Viriglio, di Fasolo, di Rico, di Solferini, etc. etc.; e asti
modei a sa nen rinonsieje;
l'istess coma a savrzà nen rinon–
sié a la spassgiada da ses a sèt sota i pòrti 'd Pò, ant la veja
religion dIa faseusa e dIa sartoiretta»
[il corsivo è nostro]
(Lui è la prosecuzione, e, diciamolo subito, più artistica e
più dignitosa dei Viriglio, dei Fasolo, dei Rico, dei Solferi–
ni , ecc. ecc. e a questi modelli non sa rinunciare; così
come non sa rinunciare alla passeggiata dalle sei alle sette
sotto i portici di Po, nella vecchia religione della crestaia e
della sartina), in «Armanach Piemontèis», XV, 1937,
Torino, A l'ansegna dij Brandé, p. 13. Ad ore circonvicine
come ai momenti più animati della giornata rimanda Emi–
lia Mariani in una sua prosa apparsa con il titolo
l portici
di Torino,
dove, sia detto
en passant,
sono ancora le pagi-
71


















