
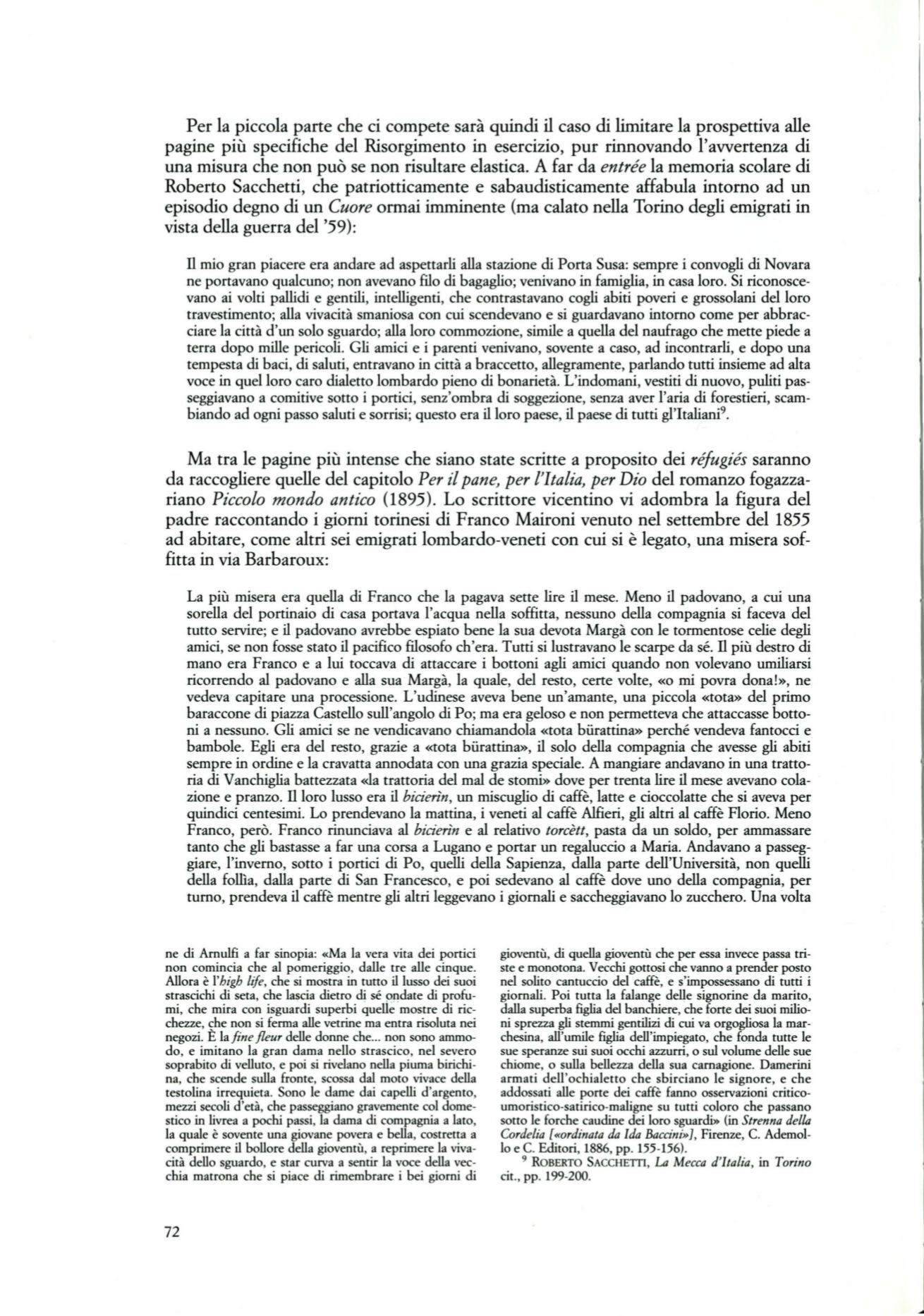
Per la piccola parte che ci compete sarà quindi
il
caso di limitare la prospettiva alle
pagine più specifiche del Risorgimento in esercizio, pur rinnovando l'avvertenza di
una misura che non può se non risultare elastica. A far da
entrée
la memoria scolare di
Roberto Sacchetti, che patriotticamente e sabaudisticamente affabula intorno ad un
episodio degno di un
Cuore
ormai imminente (ma calato nella Torino degli emigrati in
vista della guerra del '59):
TI mio gran piacere era andare ad aspettarli alla stazione di Porta Susa: sempre i convogli di Novara
ne portavano qualcuno; non avevano filo di bagaglio; venivano in famiglia, in casa loro. Si riconosce–
vano ai volti pallidi e gentili, intelligenti, che contrastavano cogli abiti poveri e grossolani del loro
travestimento; alla vivacità smaniosa con cui scendevano e si guardavano intorno come per abbrac–
ciare la città d'un solo sguardo; alla loro commozione, simile a quella del naufrago che mette piede a
terra dopo mille pericoli. Gli amici e i parenti venivano, sovente a caso, ad incontrarli, e dopo una
tempesta di baci, di saluti, entravano in città a braccetto, allegramente, parlando tutti insieme ad alta
voce in quel loro caro dialetto lombardo pieno di bonarietà. L'indomani, vestiti di nuovo, puliti pas–
seggiavano a comitive sotto i portici, senz'ombra di soggezione, senza aver l'aria di forestieri, scam–
biando ad ogni passo saluti e sorrisi; questo era il loro paese, il paese di tutti gl'Italiani
9 .
Ma tra le pagine più intense che siano state scritte a proposito dei
réfugiés
saranno
da raccogliere quelle del capitolo
Per il pane, per !'Italia, per Dio
del romanzo fogazza–
riano
Piccolo mondo antico
(1895) . Lo scrittore vicentino vi adombra la figura del
padre raccontando i giorni torinesi di Franco Maironi venuto nel settembre del 1855
ad abitare, come altri sei emigrati lombardo-veneti con cui si
è
legato, una misera sof–
fitta in via Barbaroux:
La più misera era quella di Franco che la pagava sette lire
il
mese. Meno il padovano, a cui una
sorella del portinaio di casa portava l'acqua nella soffitta, nessuno della compagnia si faceva del
tutto servire; e il padovano avrebbe espiato bene la sua devota Margà con le tormentose celie degli
amici, se non fosse stato il pacifico filosofo ch'era. Tutti si lustravano le scarpe da sé. TI più destro di
mano era Franco e a lui toccava di attaccare i bottoni agli amici quando non volevano umiliarsi
ricorrendo al padovano e alla sua Margà, la quale, del resto, certe volte, «o
mi
povra dona!», ne
vedeva capitare una processione. L'udinese aveva bene un'amante, una piccola «tota» del primo
baraccone di piazza Castello sull'angolo di Po; ma era geloso e non permetteva che attaccasse botto–
ni
a nessuno. Gli amici se ne vendicavano chiamandola «tota biirattina» perché vendeva fantocci e
bambole. Egli era del resto, grazie a «tota biirattina», il solo della compagnia che avesse gli abiti
sempre in ordine e la cravatta annodata con una grazia speciale. A mangiare andavano in una tratto–
ria di Vanchiglia battezzata <<la trattoria del mal de storni» dove per trenta lire il mese avevano cola–
zione e pranzo. TI loro lusso era il
bicierìn,
un miscuglio di caffè, latte e cioccolatte che si aveva per
quindici centesimi. Lo prendevano la mattina, i veneti al caffè Alfieri, gli altri al caffè FIorio. Meno
Franco, però. Franco rinunciava al
bicierìn
e al relativo
torcètt,
pasta da un soldo, per ammassare
tanto che gli bastasse a far una corsa a Lugano e portar un regaluccio a Maria. Andavano a passeg–
giare, l'inverno, sotto i portici di Po, quelli della Sapienza, dalla parte dell'Università, non quelli
della follia , dalla parte di San Francesco, e poi sedevano al caffè dove uno della compagnia, per
turno, prendeva
il
caffè mentre gli altri leggevano i giornali e saccheggiavano lo zucchero. Una volta
ne di Arnulfi a far sinopia: «Ma la vera vita dei portici
non comincia che al pomeriggio, dalle tre alle cinque.
Allora è
l'high life,
che si mostra in tutto
il
lusso dei suoi
strascichi di seta, che lascia dietro di sé fJl1date di profu–
mi, che mira con isguardi superbi quelle mostre di ric–
chezze, che non si fenna alle vetrine ma entra risoluta nei
negozi.
È
la
fine fleur
delle donne che... non sono ammo–
do, e imitano la gran dama nello strascico, nel severo
soprabito di velluto, e poi si rivelano nella piuma birichi–
na' che scende sulla fronte, scossa dal moto vivace della
testolina irrequieta. Sono le dame dai capelli d'argento,
mezzi secoli d'età, che passeggiano gravemente col dome–
stico in livrea a pochi passi, la dama di compagnia a lato,
la quale è sovente una giovane povera e bella, costretta a
comprimere
il
bollore della gioventù, a reprimere la viva–
cità dello sguardo, e star curva a sentir la voce della vec–
chia matrona che si piace di rimembrare i bei giorni di
gioventù, di quella gioventù che per essa invece passa tri–
ste e monotona. Vecchi gottosi che vanno a prender posto
nel solito cantuccio del caffè, e s'impossessano di tutti i
giornali. Poi tutta la falange delle signorine da marito,
dalla superba figlia del banchiere, che forte dei suoi milio–
ni sprezza gli stemmi gentilizi di cui va orgogliosa la mar–
chesina, all'umile figlia dell'impiegato, che fonda tutte le
sue speranze sui suoi occhi azzurri, o sul volume delle sue
chiome, o sulla bellezza della sua carnagione. Damerini
armati dell'ochialetto che sbirciano le signore, e che
addossati alle porte dei caffè fanno osservazioni critico–
umoristico-satirico-maligne su tutti coloro che passano
sotto le forche caudine dei loro sguardi» (in
Strenna della
Cordelia [«ordinata
da
Ida Boccini»],
Firenze,
C.
Ademol–
lo e
C.
Editori, 1886, pp. 155-156).
9 ROBERTO SACCHETTI,
La
Mecca d'Italia,
in
Torino
cit.,
pp. 199-200.
72


















