
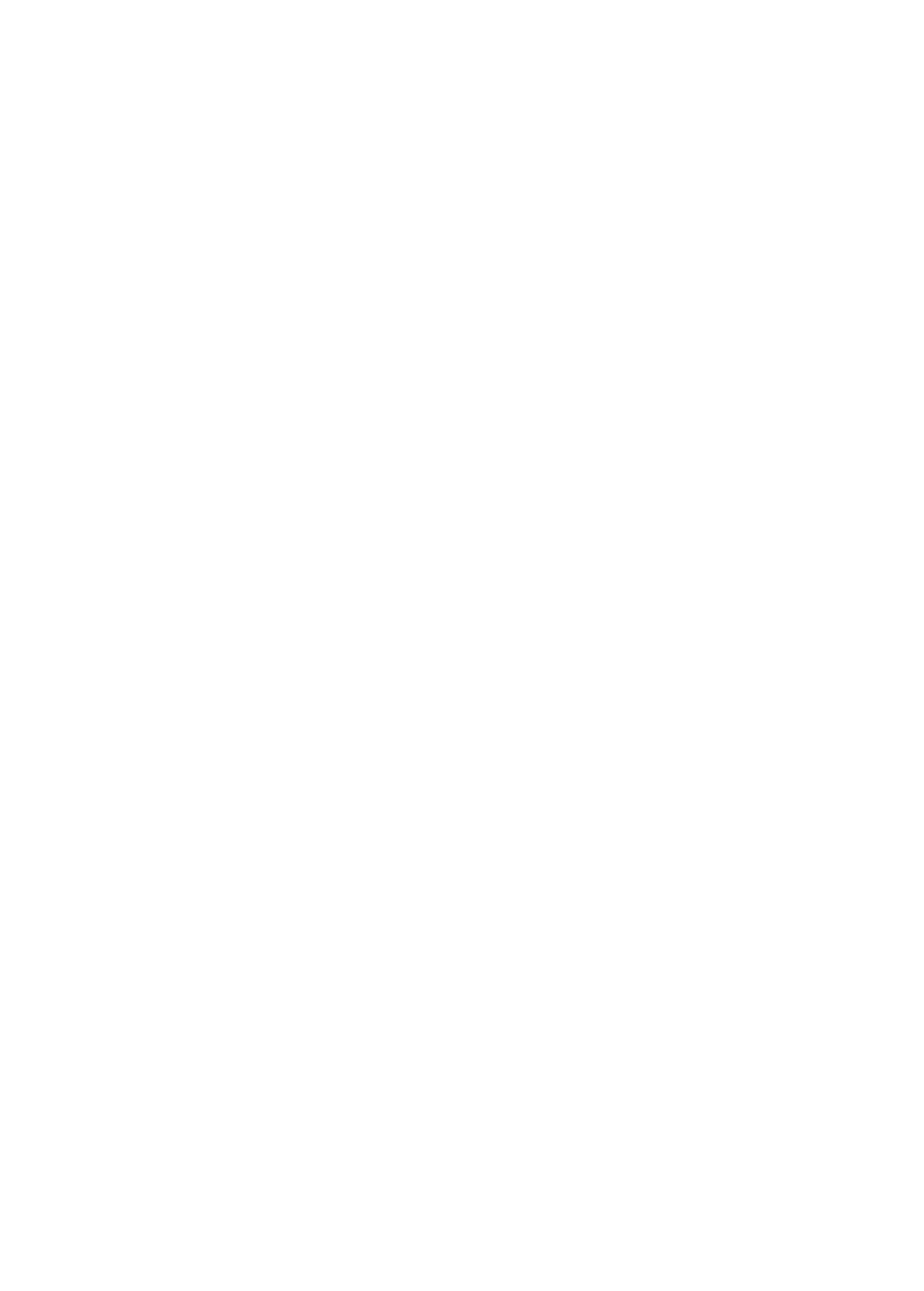
100
Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
caso si specifica che il nuovo abitante non doveva appartenere ad «ali-
qua parte parcium nobilium ipsius civitatis», non doveva cioè schierar-
si con alcuna delle fazioni nobiliari che arroventavano la vita politica
della città
5
.
È notevole, nei documenti raccolti nel
Liber
, la presenza di fi-
deiussori a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dall’
habi-
tator
, specialmente per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili in
Torino, di valore variabile fra le 5 e le 100 lire in moneta di Asti. Evi-
dentemente, con le concessioni di «abitacolo», la città cercava non sol-
tanto di incrementare il numero dei propri abitanti, ma di potenziare
il gettito delle imposte dirette, cosa non facile perché talvolta coloro
che mostravano il desiderio di trasferirvisi non mettevano poi effetti-
vamente in pratica le proprie intenzioni. Lo dimostra il fatto che la ci-
fra realmente spesa nell’acquisto di immobili da parte dei nuovi venu-
ti non sempre corrispondeva a quella prescritta e che il contratto di
compra-vendita talora non era stipulato entro il termine previsto e ta-
lora non era stipulato affatto. Così Martino Goffredo e Michele Lam-
berto di Bardonecchia nel settembre 1293 si erano per esempio obbli-
gati a spendere 10 lire nell’acquisto di immobili, ma si limitarono a com-
prare terreni per 8 lire. Viceversa Ardizzone Gata, che nel marzo 1290
aveva giurato di comprare entro la festa di San Michele un immobile
del valore di 100 soldi in moneta astese, stipulò, soltanto nel novem-
bre 1294, il contratto di acquisto di una casa, per la quale tuttavia ver-
sò una cifra sei volte superiore: 30 lire astigiane. Giovanni Bruno di
Varisella, infine, giurò il 21 giugno la fedeltà ad Amedeo V conte di
Savoia e l’abitacolo di Torino impegnandosi ad acquistare una posses-
sione del valore di 100 soldi di astesi «in Taurino, vel in poderio Tau-
rini, vel in fine Taurini pro predicto habitaculo servando», ma molto
probabilmente non rispettò i patti perché il suo
habitaculum
non fu tra-
scritto nel codice citato. Il comune si premuniva comunque contro
un’eventuale inosservanza dei patti o un allontanamento dei nuovi
ha-
bitatores
facendo loro sottoscrivere una clausola, per la quale, in tal ca-
so, avrebbe potuto sequestrare i beni immobili già acquisiti «pro pre-
dicto habitaculo servando». Infine, come normalmente avveniva in que-
sti casi, le famiglie che mostravano l’intenzione di immigrare erano
incentivate dall’immunità da ogni esazione reale e personale concessa
dal comune per un periodo determinato, variabile da 1 a 25 anni; tale
immunità non si estendeva però al pagamento del
denarius molendini
,
5
bizzarri
,
Studi di storia del diritto italiano
cit., pp. 135 sgg. e p. 142, doc. 5; p. 145, doc. 14;
p. 147, doc. 23; p. 150, doc. 30; p. 151, doc. 31.


















