
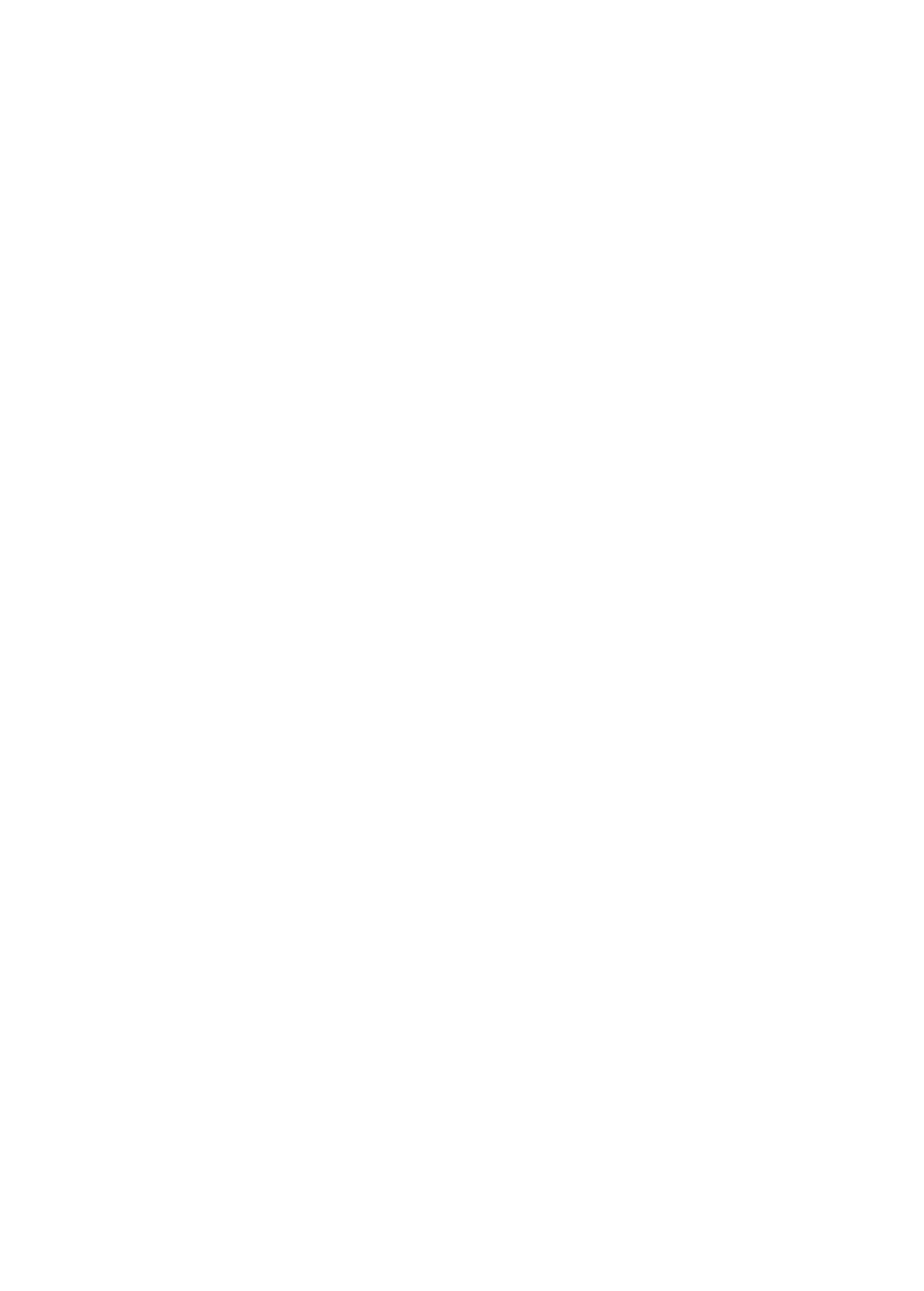
maino Borgesio, e il già menzionato Ribaldino Beccuti, signore di Lu-
cento
62
.
L’aver ritrovato, fra i latifondisti che sfruttavano parte delle proprie
terre «ad masoeriam», proprio quel Ribaldino Beccuti che a Lucento,
in piena crisi bellica e demografica, sperimentò con successo forme di
sfruttamento agricolo che coniugavano l’enfiteusi perpetua con una sor-
ta di modello neocurtense, induce a riflettere ulteriormente non tanto
sulle forme di conduzione della terra che, a larghi tratti, abbiamo ormai
delineato, quanto sul significato dei dati quantitativi desumibili dagli
estimi circa la ripartizione della proprietà fondiaria. Un documento con-
cernente ancora una volta Ribaldino può ben servire a esemplificare la
situazione. Il 28 dicembre 1409, con un lungo atto stipulato nel mona-
stero di San Solutore Maggiore, egli concesse in enfiteusi perpetua 42
giornate di prato irriguo e arativo, suddivise in sei appezzamenti per lo
più situati in località Aviglio, nei pressi di Lucento, e a Santa Maria di
Gorzano, a una dozzina di uomini di Collegno che si impegnarono a ver-
sare nell’agosto di ogni anno a Torino o ad Avigliana 32 staia di fru-
mento, equivalenti a 4 moggia, e a farsi carico di tutti gli oneri reali e
personali gravanti sui terreni concessi. Va da sé che da quel momento
tali beni avrebbero dovuto comparire, come almeno in parte comparve-
ro, nei singoli estimi degli enfiteuti e non del Beccuti, che avrebbe do-
vuto semmai dichiarare, nel proprio consegnamento, il fitto ricevuto.
Così infatti stabilivano gli
Statuta
torinesi del 1360 che, secondo un
orientamento assai diffuso nel mondo tardocomunale, prevedevano che
nessun concessionario potesse perdere i terreni in proprio possesso per
ritardato pagamento del fitto, purché si impegnasse a saldare il debito
l’anno successivo
63
. In altre parole il dominio utile sul fondo, quello del
L’economia
129
62
Contratto di
masoeria
:
panero
,
Viticoltura, patti mezzadrili e colonia parziaria
cit., p. 118 (
pa-
nero
,
Strutture del mondo contadino
cit., p. 124). Frazionamento dei complessi fondiari più estesi
e
masoerii
torinesi:
barbero
,
Un’oligarchia urbana
cit., pp. 119-29 sgg. Attestazioni di
masoerii
nel-
le fonti: ASCT,
Ordinati
, 19, ff. 20
r
, 23
r
, 25
v
; CCT, rot. 55 bis. Proprietari di terre condotte «ad
masoeriam»: Stefano Borgesio (ASCT, Coll. V, n. 1133, iscr. al
liber summarum
, Nuova, per 122
lire di imponibile); Franceschino de Crovesio (ASCT, Pust. 1391, f. 90
r-v
, per 95 giornate di ter-
ra; da confrontare con ASCT, Coll. V, n. 1133, iscr. al
liber summarum
, Pust., per 113 lire di im-
ponibile); Tomaino Borgesio (ASCT, Nuova, per 84 lire di imponibile); Ribaldino Beccuti (ASCT,
Nuova, 524 lire di imponibile). Nel 1415 Ribaldino dichiarò di possedere ben 683 giornate di ter-
reno (ASCT, Nuova 1415, ff. 69 sgg.).
63
AST, Corte, Paesi per A e B, Lucento, mazzo 11, doc. 1 del 28 dicembre 1409. Alcuni de-
gli enfiteuti che sono citati nel documento (come Michele Bozzola, Michele Cane, Giovanni e An-
tonio Messone) ricompaiono, con beni ubicati nella località prediale di Aviglio, nell’elenco dei
fo-
renses
di Collegno che nel 1415 posseggono terreni nel territorio di Torino: ASCT, Forensi 1415
(Coll. V, n. 1045), ff. 3
v
, 5
v
, 6
v
, 13
v
; BSSS, 138/
i
, p. 121, cap. 290, con le interpretazioni di
bar-
bero
,
Un’oligarchia urbana
cit., pp. 117 sgg.


















