
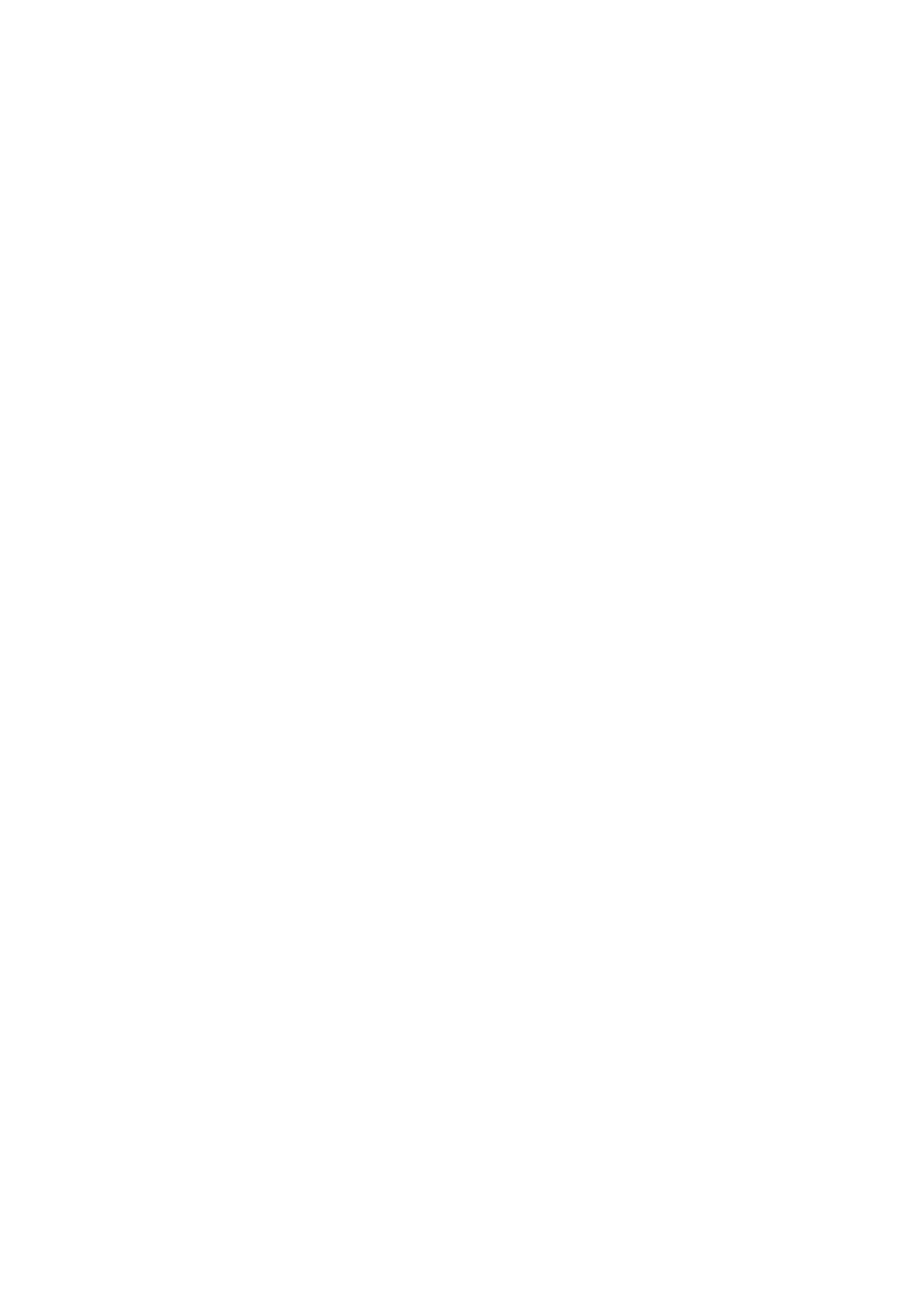
130
Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
concessionario, tendeva a essere assimilato alla piena proprietà, mentre
il canone assumeva l’aspetto di una semplice rendita o di un onere gra-
vante sul fondo stesso; come tale esso era quindi registrato negli estimi
che, invece, includevano fra le proprietà del concessionario l’appezza-
mento su cui tale canone gravava, sia pure annotando che non di piena
proprietà si trattava, ma di un possesso gravato da fitto perpetuo.
Ciò significa – come è stato osservato – che, per quanta terra i gran-
di possessori potessero aver concesso in enfiteusi senza dichiararla
all’estimo, «essi continuavano pur sempre a registrare a proprio carico
decine o centinaia di giornate, e questa terra, qualora manchi un’espli-
cita menzione in proposito, non era certamente data in affitto a lunga
scadenza»
64
: o era gestita in economia ricorrendo magari a manodopera
salariata, oppure era data in gestione indiretta mediante conduzione «ad
masoeriam» o mediante altre forme contrattuali a breve termine. In ul-
tima analisi, frodi fiscali a parte, se gli estimi possono indurre a sotto-
valutare l’estensione effettiva del grande possesso e l’importanza delle
concessioni enfiteutiche, non altrettanto si può dire della piccola pro-
prietà e del piccolo possesso terriero, che invece venivano registrati per
lo più integralmente comprendendovi i numerosi appezzamenti sotto-
posti al pagamento di fitti perpetui o a lunga scadenza. Questi ultimi
erano così numerosi, nei patrimoni minori, coltivati direttamente dai
contadini a cui appartenevano, da essere spesso prevalenti rispetto alle
terre detenute in piena proprietà
65
.
Con t ad i n i d i c i t t à : l e ba s i r u r a l i de l l o s v i l uppo a r t i -
g i ana l e e man i f a t tur i e ro d i Tor i no .
Oltre che per le forme di conduzione, grande e piccola proprietà si
distinguevano per la diversità delle scelte colturali che vi venivano pra-
ticate. L’argomento, già affrontato su base empirica nel lavoro pionie-
ristico di Anna Maria Pascale sull’estimo del 1349-50
66
, è stato ripreso
alcuni anni fa, per il Quattrocento, da Stefano Benedetto, che ha uti-
lizzato il metodo di analisi tipologica di Georges Durand adattato alla
realtà piemontese. Egli ha classificato le proprietà secondo le loro com-
ponenti agrarie fondamentali e secondo le loro dimensioni totali, allo
scopo di comprenderne «le strutture dominanti e le associazioni coltu-
64
Ibid
., p. 118.
65
pascale
,
Fisionomia territoriale
cit., p. 234.
66
Ibid
., pp. 231 sgg.


















