
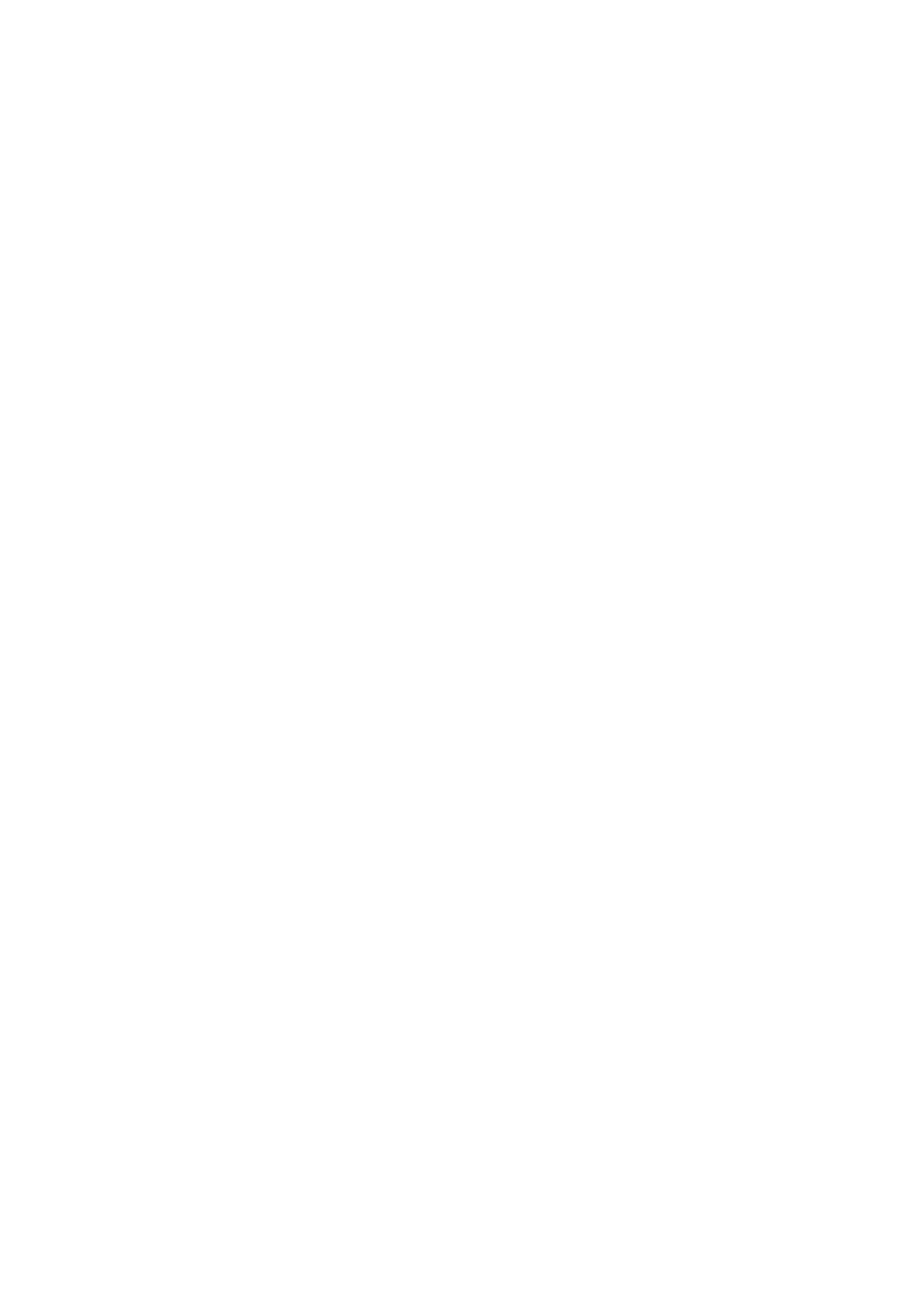
proposito occorre rilevare che, almeno sino agli inizi dell’età moderna,
«le diversità fra medici – fisici e barbieri – chirurghi, e la distinzione
fra medicina e chirurgia, tra terapia interna ed esterna del corpo del ma-
lato, risultano quanto mai nette e marcate […]. Una serie di osserva-
zioni e di indagini, svolte non solo negli stati italiani ma nel complesso
dell’area europea, dimostra che l’origine familiare, la formazione pro-
fessionale, i livelli di retribuzione, la posizione sociale, contribuivano a
tener ben distinti i ruoli di medici e barbieri»
70
.
L’erogazione dei servizi sanitari diventava particolarmente proble-
matica durante le crisi epidemiche, quando la paura del contagio, che
spingeva gran parte della popolazione ad abbandonare i centri urbani
per rifugiarsi in campagna dove l’aria era più salubre e quindi minore il
rischio di infezione, faceva allontanare gli stessi medici. Allora, quando
neppure la promessa al medico convenzionato di un incremento salaria-
le anche cospicuo non valeva a trattenerlo, diventava determinante l’ope-
ra di volontariato, da parte soprattutto di chirurghi e barbieri locali, che
si mettevano al servizio della cittadinanza ricevendo poi dalle pubbliche
autorità un sussidio finanziario oppure sgravi fiscali e/o esenzioni dagli
oneri personali in nome della loro riconosciuta funzione di utilità so-
ciale, rivolta in particolare alla povera gente rimasta in città
71
.
Le fonti torinesi, pur lacunose, sembrano mostrare comunque una
certa stabilità del servizio medico, con un avvicendamento meno rapi-
do del personale sanitario rispetto a località minori; la continuità del-
l’assistenza era di fatto normalmente garantita dalle prestazioni di pro-
fessionisti autoctoni, che – come si è osservato – esercitavano a titolo
libero, conservando perciò una maggiore autonomia nei confronti del
potere pubblico, dal quale peraltro ottenevano una qualche forma di ri-
conoscimento ufficiale mediante i privilegi di natura fiscale.
A partire dall’inizio del Quattrocento, in coincidenza con la fase più
acuta della recessione demografica, sembra avviarsi una certa tendenza
ad agevolare l’immigrazione in Torino e questo fenomeno coinvolse an-
che i professionisti della salute. Nei primi decenni del secolo si trasferi-
rono infatti in città alcuni medici e chirurghi, accettati come
habitato-
La classe dirigente e i problemi di una città in difficoltà
293
70
a. pastore
,
Peste, epidemie e strutture sanitarie
, in
n. tranfaglia
e
m. firpo
(a cura di),
La
Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea
, III.
L’Età Moderna
,
i
.
I quadri gene-
rali
, Torino 1987, p. 66. Per una sintesi delle conoscenze chirurgiche nel medioevo si veda
m. mc-
vaugh
,
Strategie terapeutiche: la chirurgia
, in
m. d. grmek
(a cura di),
Storia del pensiero medico oc-
cidentale
, I.
Antichità e Medioevo
, Roma-Bari 1993, specialmente pp. 377-98.
71
Per alcuni esempi, cfr.
i. naso
,
L’assistenza sanitaria nei comuni pedemontani durante le crisi
epidemiche del
xiv
e del
xv
secolo
, in
a. m. nada patrone
e
i. naso
,
Le epidemie del tardo medioevo
nell’area pedemontana
, Torino 1978, p. 111, nota 127.


















