
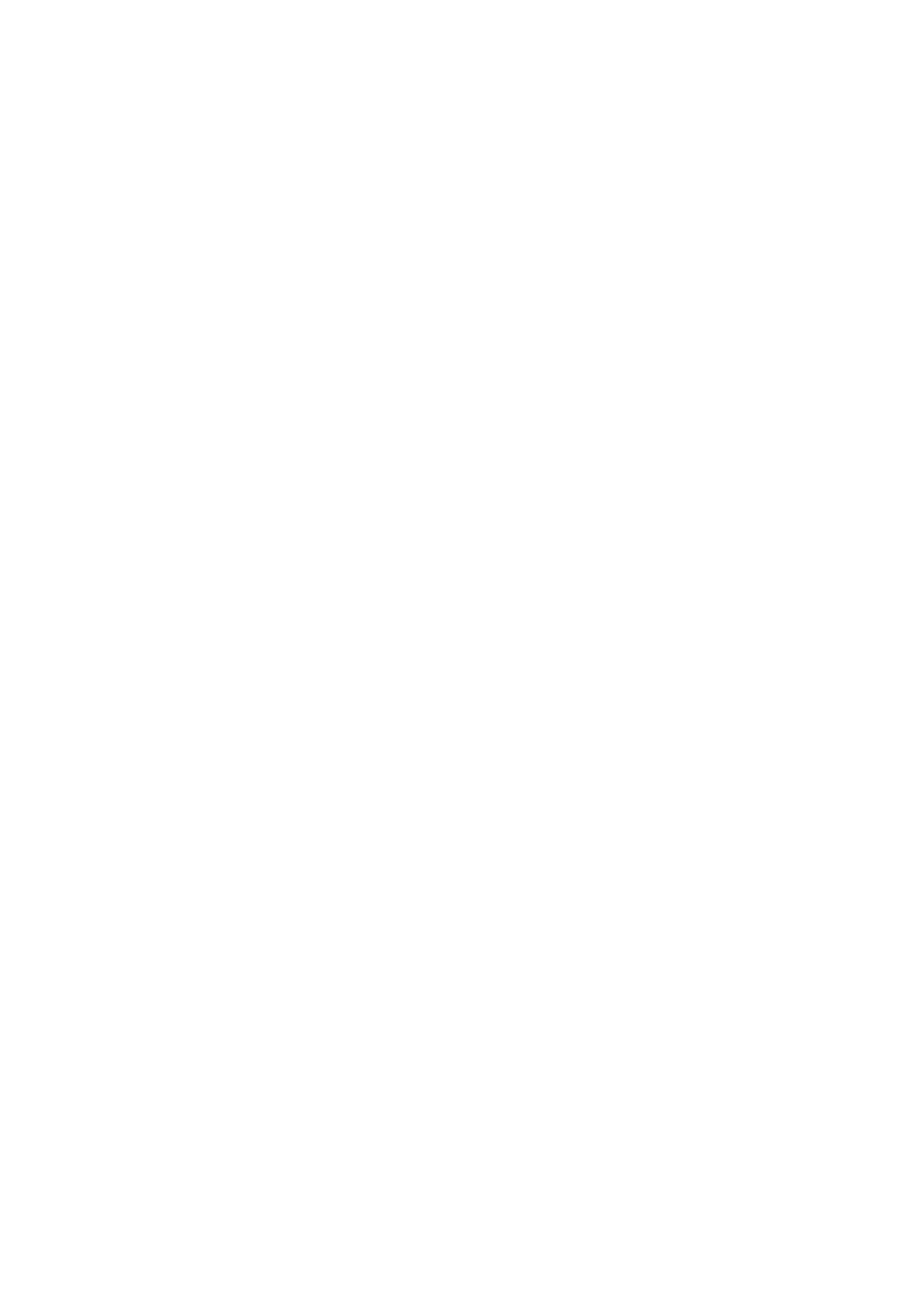
famiglia iscritti a catasto e almeno ventiquattro maschi adulti, ben set-
te dei quali sedevano sui banchi del consiglio.
La rappresentanza nobiliare nel governo del comune era dunque por-
tavoce, per definizione, di interessi oligarchici e il suo peso politico era
inevitabilmente sproporzionato rispetto alla consistenza numerica della
nobiltà cittadina, che ai primi del Quattrocento comprendeva una cin-
quantina di capifamiglia su un totale di oltre seicento. La rappresentanza
popolare avrebbe dovuto, per contro, dar voce agli interessi della mag-
gioranza dei cittadini, tanto più che non esisteva a Torino un popolo in-
teso come forza politica organizzata, distinta dalla collettività nel suo com-
plesso: l’unica organizzazione che in qualche modo si avvicinava a questa
definizione, la Società di San Giovanni Battista, era stata sciolta imme-
diatamente dopo l’annessione della città al ducato. Sennonché il recluta-
mento dei consiglieri popolari dimostra che anch’essi rappresentavano in-
teressi che possiamo ben considerare oligarchici, anche se su una base più
allargata rispetto alla nobiltà. Lo attesta in primo luogo il loro profilo pro-
fessionale: i
populares
che siedono in consiglio sono in gran parte notai, il
gruppo professionale più numeroso e politicamente più influente nella so-
cietà torinese, che fornisce circa metà dei consiglieri e fino a due terzi dei
clavari di popolo. Ai notai si aggiungono i pochi grossi imprenditori e ne-
gozianti del ramo tessile, lanaioli e drappieri, i mercanti di spezie, i gros-
sisti alimentari, i più rispettabili fra gli osti, e più raramente qualche mae-
stro artigiano di solida agiatezza, cuoiaio, carpentiere, barbiere o beccaio.
Calzolai, fabbri, fornai, merciai, sarti restano completamente esclusi dal-
la rappresentanza politica, al pari di quei tessitori e tintori che esercitano
la loro attività all’ombra dei maggiori imprenditori, e naturalmente dei
vignaioli, braccianti e massari residenti in gran numero in città.
Riservato di fatto agli esponenti delle professioni più prestigiose, il
diritto di sedere in consiglio in rappresentanza del popolo tendeva per di
più a trasmettersi ereditariamente all’interno delle stesse trenta o qua-
ranta famiglie, che finirono così per costituire, accanto alla nobiltà, una
vera e propria oligarchia popolare. Quasi tre quarti dei consiglieri in ca-
rica nel 1418 appartenevano a famiglie che erano già rappresentate in
consiglio cinquant’anni prima, e che avrebbero continuato ad esserlo nei
cinquant’anni successivi. Questo consiglio dall’organico quasi sempre in-
completo, che si rinnovava soltanto per cooptazione, e al cui interno il
ricambio procedeva ad un ritmo assai lento, scandito soltanto dai deces-
si dei consiglieri, coinvolgeva nella sua attività, anche tenendo conto di
tutti i possibili legami familiari, forse un decimo dei Torinesi di condi-
zione popolare; tutti gli altri non avevano alcuna partecipazione alla vi-
ta politica cittadina.
La vita e le strutture politiche nel quadro della bipolarità signore-comune
547


















