
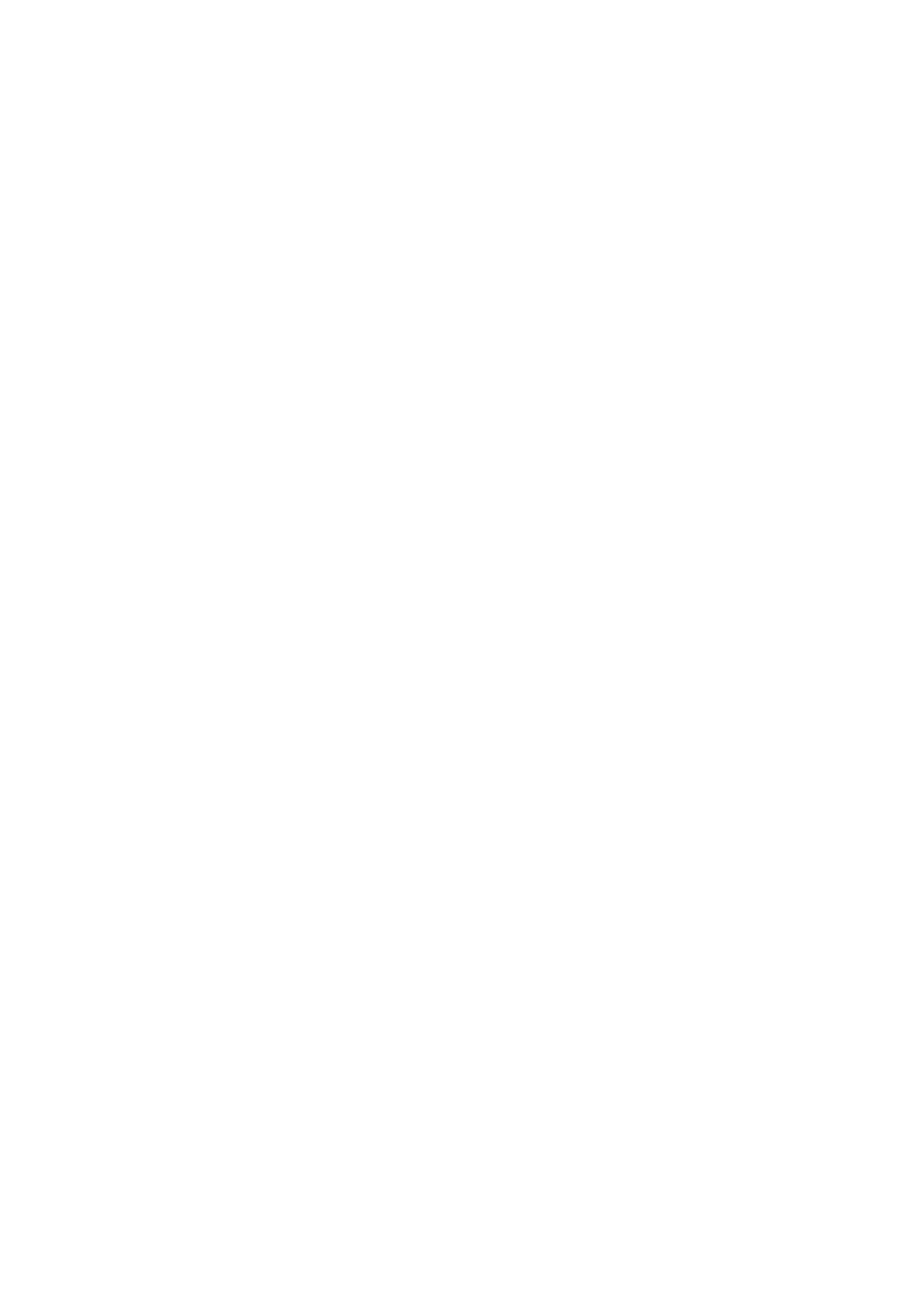
Nel 1317 Filippo d’Acaia esercitava la sua signoria su Torino da ol-
tre vent’anni, perché dunque – è lecito domandarsi – egli pensò proprio
allora al rinnovamento e al potenziamento del castello? Manca ogni pos-
sibilità di rispondere in modo esplicito: si può certo, in generale, rico-
noscere l’utilità di poter disporre, durante i suoi periodi di permanenza
in città, di una residenza più sicura della precedente, benché – come si
è visto – manchi ogni testimonianza di situazioni pericolose cui il prin-
cipe avesse dovuto sottostare.
Non si conoscono neppure pericoli esterni che in quel momento mi-
naccino da vicino la città. Sin dal 1310, dopo la guerra per la successio-
ne di Monferrato, Filippo è in pace con il marchese Teodoro Paleologo,
schierato anzi con lui contro gli Angioini attivi, per ora, solo nell’Asti-
giano e nel Piemonte meridionale, zone sulle quali si concentrano gli
sforzi militari di Filippo d’Acaia
84
. Il perdurante accordo con il marchese
favorisce incidentalmente l’impiego, nella costruzione del nuovo castello,
di maestri e di operai provenienti appunto da Casale e dal Monferrato
85
.
È da escludere inoltre, per la stessa qualità dell’opera intrapresa, che
con essa si intendesse dotare Torino di «un caposaldo difensivo contro
le scorrerie nemiche»
86
che, se per allora, improbabili, erano pur sempre
prevedibili in futuro. L’edificio progettato, per sua struttura e disposi-
zione, non solo appare poco significativo sotto l’aspetto militare ma –
proprio come teorizzerà in seguito l’Alberti – risulta semmai rivolto con-
tro la città piuttosto che costruito in sua difesa.
È quindi ragionevole pensare a una decisione presa non sotto la pres-
sione di necessità contingenti, ma nel quadro di un piano più generale
di miglioramento delle strutture edilizie perseguito dal principe nell’in-
sieme dei suoi domini. Esso comincia con le notevoli spese sostenute nel
1295 e poi nel 1317 per lavori nel castello di Pinerolo, prosegue con la
costruzione della «casa forte» di Torino fra 1317 e 1320, e con la co-
struzione di nuove fortezze a Bricherasio (1324) e a Fossano (1324-27),
alle quali si può aggiungere la
bastita
allestita nel 1325 «in Molari de
Liximonte» sopra Susa; un piano di ampio respiro nel quale rientrano
anche gli interventi del principe sull’assetto del popolamento rurale
87
.
La città e il suo territorio
39
84
Cfr.
f. gabotto
,
Storia del Piemonte nella prima metà del secolo
xiv
(1292-1349)
, Torino
1894, pp. 78-100;
id
.,
Asti e la politica sabauda
cit., pp. 344-74.
85
monetti
e
ressa
,
La costruzione del castello di Torino
cit., pp. 28-29;
settia
,
Un castello a
Torino
cit., pp. 27-30.
86
Come pensano
monetti
e
ressa
,
La costruzione del castello di Torino
cit., p. 9.
87
Rispettivamente:
gabotto
,
Asti e la politica sabauda
cit., pp. 136, 345-46, 426;
g. falco
,
Sulla costruzione del castello di Fossano (1324-1332)
, in
Fonti e studi di storia fossanese
, Torino 1928,
pp. 179-208;
r. comba
,
Il costo della difesa. Investimenti nella costruzione e manutenzione di castelli


















