
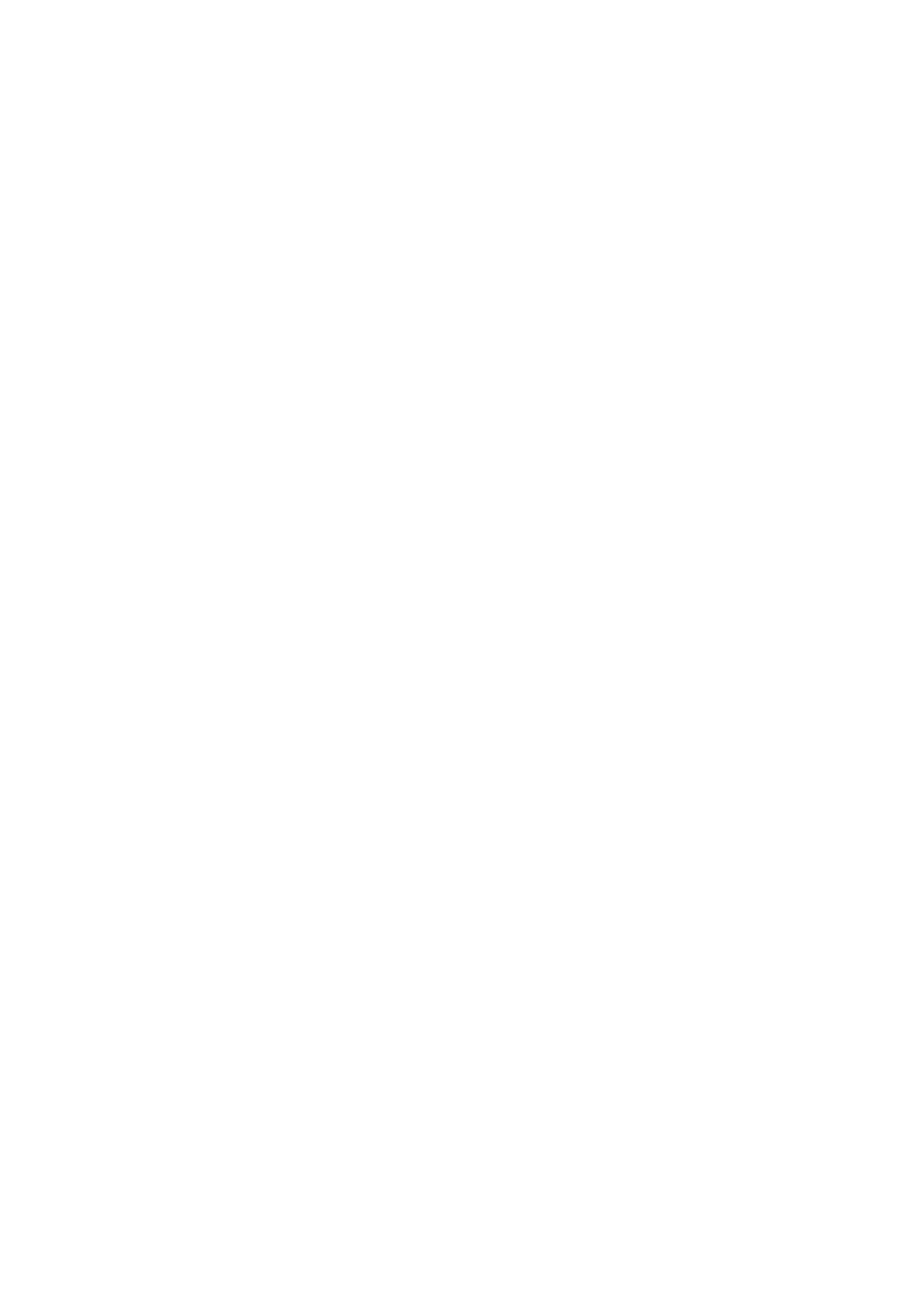
Sulla strada del rimpatrio, nel 1518 o 1519, la città non suscita
nell’uomo maggiore entusiasmo; egli infatti osserva: «Turino, latine
Thaurinum, città archiepiscopalle. He Turino non molto bella città, di
mediocre popullo et di circa a fochi 5000; sua principale chiesia he S. to
Pettro, assay bella, et he tutta in volta di sotto, come l’hospedale di Mi-
lano; muratta». Il rango ecclesiastico, al quale la Chiesa di Torino è sta-
ta recentemente elevata dal pontefice Leone X
14
è elemento degno di
nota; e ancora lo sarà circa trent’anni più tardi, allorché il cardinale por-
toghese Gaspar Barreiros, transitando nel 1546 da Rivoli a Moncalieri
senza passare per Torino, annoterà a proposito della regione subalpina:
«tem esta provincia cinquo cidades principaes: Torim, Vercel, Saluce,
Hyvrea, Osta ou Augusta, todas episcopaes»
15
. Ma agli occhi dell’os-
servatore scarso fascino sembra rivelare il modesto capoluogo piemon-
tese, racchiuso da tempo immemorabile nelle mura, entro le quali una
cosa soltanto colpisce il viaggiatore: l’antica chiesa di San Pietro
Mona-
carum
nel quartiere di Porta Nuova, con il grande chiostro, che rievoca
i cortili porticati dell’Ospedale Maggiore della capitale lombarda
16
.
Se un barlume di contenuto entusiasmo illumina appena le brevi no-
te del viaggiatore milanese, nessun segno di schiarita tempera il verdet-
to severo di un altro visitatore anonimo del primo Cinquecento, di pro-
venienza ignota
17
. «Torino – egli afferma, negando un passato illustre
alla città – non ha in sé alcuna sorta di grandezza e dalle sue ruine si può
congetturare che nemmeno per l’addietro ella sia stata terra di qualche
importanza». Nella memoria di questo personaggio sconosciuto, forse
avvezzo ai
mirabilia
delle grandi capitali europee, non rimane che un
luogo senza storia, trascurato e piatto, dalle strade «sassose e incomo-
de», dai «casamenti» all’apparenza egualmente «poco comodi» e «po-
co onorevoli»: segnali di degrado urbanistico ed edilizio, che trovereb-
bero riscontro a quei tempi in situazioni diffuse di povertà e di disagio
18
.
Immagini della città nelle relazioni dei viaggiatori e dei diplomatici
815
14
f. cognasso
,
Storia di Torino
, Milano 1959, p. 184;
gasca queirazza
,
Notizie di Piemonte
cit., pp. 391-92, nota 8.
15
a. bart rossebastiano
,
Scorci di Piemonte nelle note di viaggio di un portoghese del secolo
xvi
,
in «Studi Piemontesi»,
iii
/1 (1974), pp. 152-74.
16
Sul monastero benedettino di San Pietro
Monacarum
, demolito nella seconda metà del
xvi
secolo per far spazio al mastio della cittadella, si veda
m. t. bonardi
,
Dai catasti al tessuto urbano.
Le chiese urbane
, in
comba
e
roccia
(a cura di),
Torino fra Medioevo e Rinascimento
cit., pp. 129-
130. Il riferimento all’Ospedale milanese è colto da
comba
,
Lo spazio vissuto
cit., p. 39, nota 157.
17
g. arpino
e
r. antonetto
,
Torino altrui
, Torino 1981, p. 9.
18
Nel dicembre 1520 la città promuove un censimento della povertà torinese: «de elligendo
aliquas personas que habeant describere omnes pauperes qui sunt in civitate viventes ellemosinis»:
r. roccia
,
Quartieri e carignoni: le circoscrizioni amministrative urbane
, in
comba
e
roccia
(a cura
di),
Torino fra Medioevo e Rinascimento
cit., p. 54 e nota 90.


















