
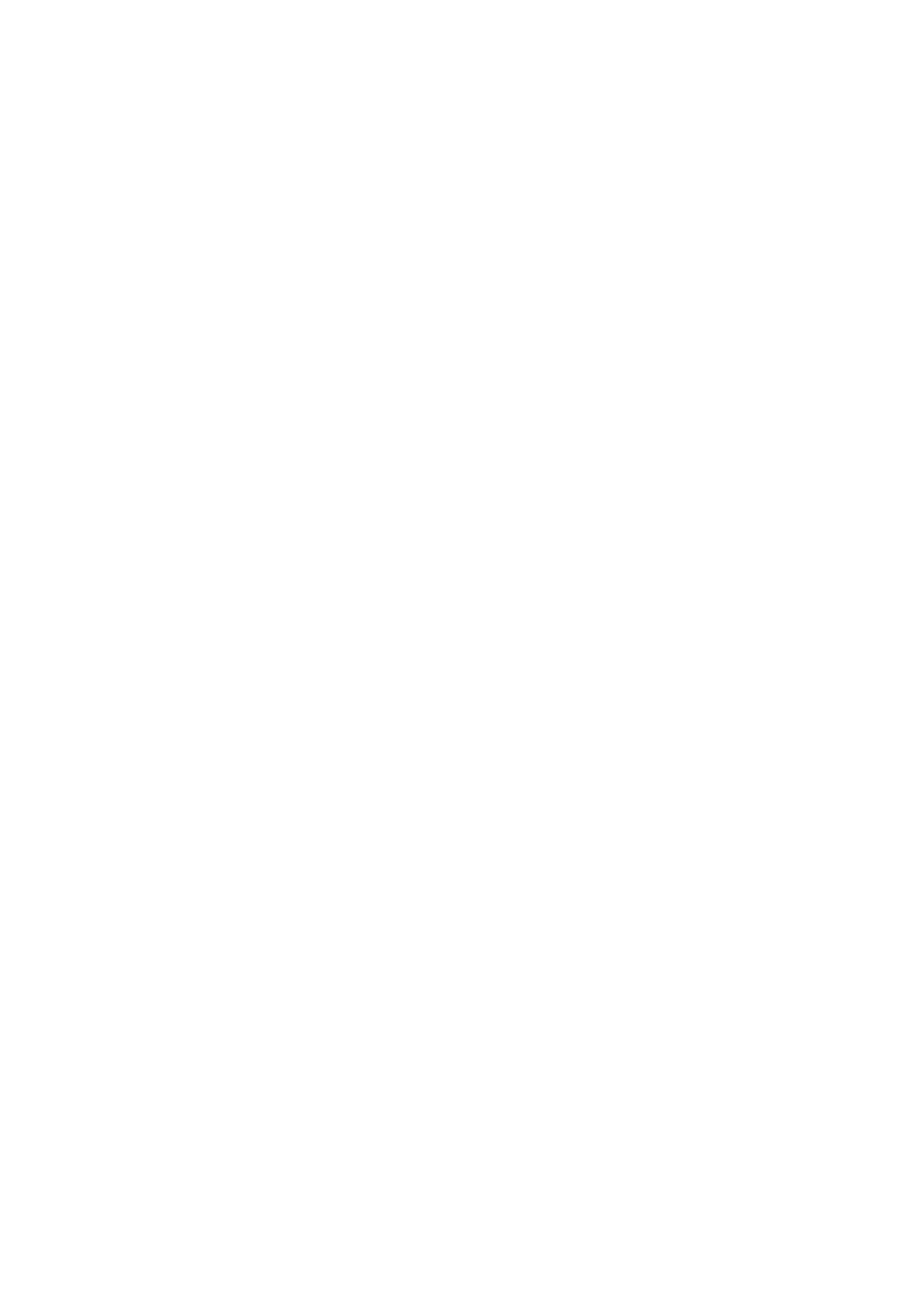
816
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
C’è da chiedersi tuttavia se l’occhio critico dei due osservatori di ini-
zio secolo rifletta, senza deformarla, la realtà o non sia piuttosto velato
dal preconcetto. Un paio di testimonianze coeve contraddicono infatti
apertamente sia il viaggiatore lombardo, sia quell’altro di cui tutto igno-
riamo; l’una appartiene a Sir Richard Torkington, nobile inglese che nel
1517 include Torino tra le tappe del suo
pilgrimage
, riscontrandovi un
fascino che altri hanno ignorato
19
. Il piacere della sosta è riassunto in
una sorta di epigrafe, «bella città e università», ove al giudizio estetico
fa eco il compiacimento. La seconda attestazione è data da Jacques Le
Saige, devoto mercante di seta di Douai, al ritorno da un pellegrinaggio
a Gerusalemme
20
. Il mattino del 22 novembre 1518 egli lascia Chivas-
so, «Quas», e percorre i pochi chilometri che lo separano dal capoluo-
go subalpino osservando che «le païs est assez plain, mais le chemin est
assez penable». La fatica tuttavia è premiata: «la ville de Turin est gran-
de et belle» ai suoi occhi, che in lunghi mesi hanno incontrato luoghi
memorabili; è ben protetta, «se est forte»; è colta, «y a estude», ed è
inoltre «assez sortie de marchandise». Compiaciuto, il pellegrino fran-
cese, più sensibile al richiamo degli affari che alle seduzioni dell’arte,
nota che alle attività commerciali si affiancano servizi efficienti: cosic-
ché, rifocillato dalla buona cucina piemontese e sicuramente ritempra-
to dall’ottimo vino locale
21
, «nous demourasmes la au disner et fusmes
bien servy», riprende di buon grado il cammino.
Quindici anni più tardi spetta alla penna di un poeta mettere in lu-
ce, con generosa adesione, alcuni caratteri inediti di Torino. La suadente
epistola in versi latini, composta il 13 agosto 1533 a Torino da Cl[aude]
Desachius per l’amico lontano, il giurista e umanista francese Jean de
Boyssoné
22
, esordisce con una pennellata efficace, che delinea un cielo
19
r. torkington
,
Pylgrymage
(1517), citato in
battilana
,
Viaggiatori di lingua inglese
cit.,
p. 55.
20
j. le saige
,
Vojage de Douai à Rome, Notre-Dame-de-Lorette, Venise, Jérusalem et autres saints
lieux
, a cura di H. R. Duthilloeul, Douai 1851.
21
r. comba
,
Paesaggi della coltura promiscua: alteni, «gricie» e terre altenate nel Piemonte rina-
scimentale
, in
id
. (a cura di),
Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale
, Cuneo 1991, p. 17, ove è ri-
portato il racconto di «un pasto allietato dal piacere “de bien boire”», che Jacques Le Saige con-
suma nel viaggio di andata all’osteria della Croce Bianca nei dintorni di Rivoli, osservando i vi-
gneti e le terre fertili della campagna alle porte di Torino. Cfr. oltre, nota 31.
22
Il testo integrale del manoscritto, conservato nella Bibliothèque Municipale di Tolosa,
Epi-
stolae Boyssonei
, ms 834, n. 202 (che ho potuto leggere in copia fotostatica grazie alla cortesia di
Jocelyne Deschaux, «Conservateur chargé du fonds patrimonial» presso la stessa Bibliothèque) co-
sì suona: «Hic ubi sum ridet coelum, est gratissimus aër, | Urbs patet insigni non male structa lo-
co. | Undique prata virent, exhalant floribus horti, | Depromit botros vinea laeta suos. | Lympidus
hic amnis placidis dilabitur undis, | Humana per agros rivulus arte fluit. | Adde quod et hic sunt
hic [
sic
] praestanti corpore Nymphae. | Quae Veneres ipsas exuperare queant, | Et quae vel durum
possint mollire Catonem, | Tanta est in facie gratia, forma, lepos. | Cum nihil hic desit, nobis ta-


















