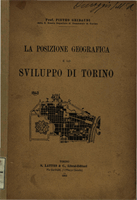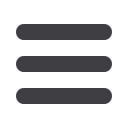
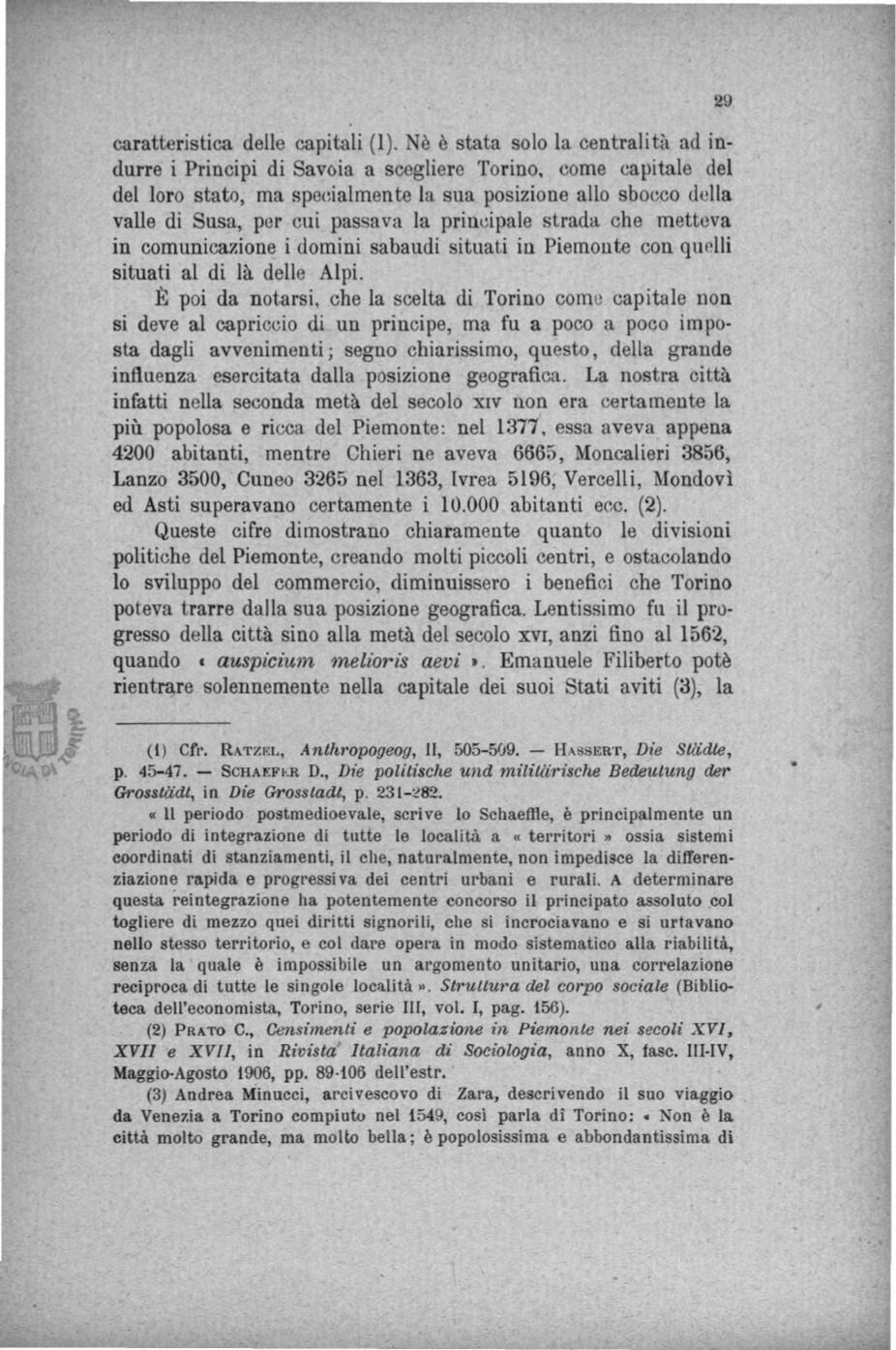
29
caratteristica delle capitali (l ). Nè
è
stata solo
la
centralità
ad in–
durre i Principi di Savoia a scegliere Torino, come ca pitale del
del loro stato, ma specialmente la sua posizion e allo sbocco della
valle di Susa, pCI' cui pas sa va la principal e strada che metteva
in comunicazione i domini sabaudi situati in Piemonte con qu elli
situati al di là delle Alpi.
È
poi da notarsi, che la scelta di Torino come capitale non
si deve al capriccio di un principe, ma fu a poco a poco irnpo–
sta dagli avvenimenti ; segno chiarissimo, qu esto, della grande
influenza esercita ta dalla posizione geografi ca. La nostra città
infatti nella seconda metà del secolo XIV non era cer tamen te la
più popolosa e ricca del Piemonte: nel
1377',
essa aveva appena
4200 abitanti, mentre Chier i ne aveva
6665,
Moncalieri
3856,
Lanzo
3500,
Cuneo
3265"
nel
1363,
Ivrea
5196;
Vercelli, MondOVÌ
ed Asti superavano cer tamen te i
10.000
abitanti ecc. (2).
Queste cifre dimostrano chiaramente quanto le divisioni
politi che del Piemonte, creando molti piccoli centri, e ostacolando
lo sviluppo del commercio, diminuissero i benefici che Torino
poteva t rarre dalla sua posizione geografica. Lenti ssimo fu il pro–
gresso della città sino alla metà del secolo XVI, anzi fino al
1562,
quando
c
auspicium. melioris aeoi
».
Emanuele Filiber to potè
rientrare solennemente nella capitale dei suoi Stati aviti (3), la
(l)
Cf
t'.
RATZ EL,
Anth1'opogeog,
Il, 505-509. -
H ASSERT,
Die Stiidte,
p.
45-47 . -
S CHHFER
D.,
Die politische
und militdrische Bedeuturu) der
Grosstddt;
i
n
Die Grosstadt,
p.
231-~82.
«
Il periodo postmedi oe val e, scrive lo SchaeiIle,
è
princip almen te un
periodo di integrazion e di tutte le locali tà a
«
territori" ossia sis te mi
coordinati di stanzia me nti, il che , natu ralmen te , non impedis ce la differen–
ziazion~
rapida e pr ogressi va dei ce nt r i urbani e rural i.
A
determinare
qu esta r einteg raz ion e ha poten temen te co nco rso
il
princip ato assoluto .col
togliere di mezzo qu ei diri tti signo ri ti, che si in crociavano e si urta vano
nello stesso ter r ito r io, e col da re op era in modo sistematico alla ri a bilità,
senza la qu al e è impossibile un argom ento unitario, un a cor rela zione
reciproca di tutte le si ngo le località
»,
Struttura del
COI'PO
sociale
(Biblio-
teca dell'economista, Torino, ser ie III, vol. I, pa g o 156),
'
. (2)
P RATO
C"
Censim enti e popolazione in Piemo nte nei secoli X VI ,
XVII e XVII,
in
Rivista' It a lia na di
sociotoçia,
a nno X, fase. III-IV,
Maggio-Agosto 1906, pp. 89·106 dell'estro
(3) Andrea Minucci, a rei ves covo di Zara, des crivendo
il
su o vi aggio
da Ven ezi a a Torino compiu to nel
1549,
così parla di Tor ino : • No n è la
città molto grande, ma molto be lla ;
è
pop olosissima e abbonda ntissima di