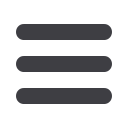
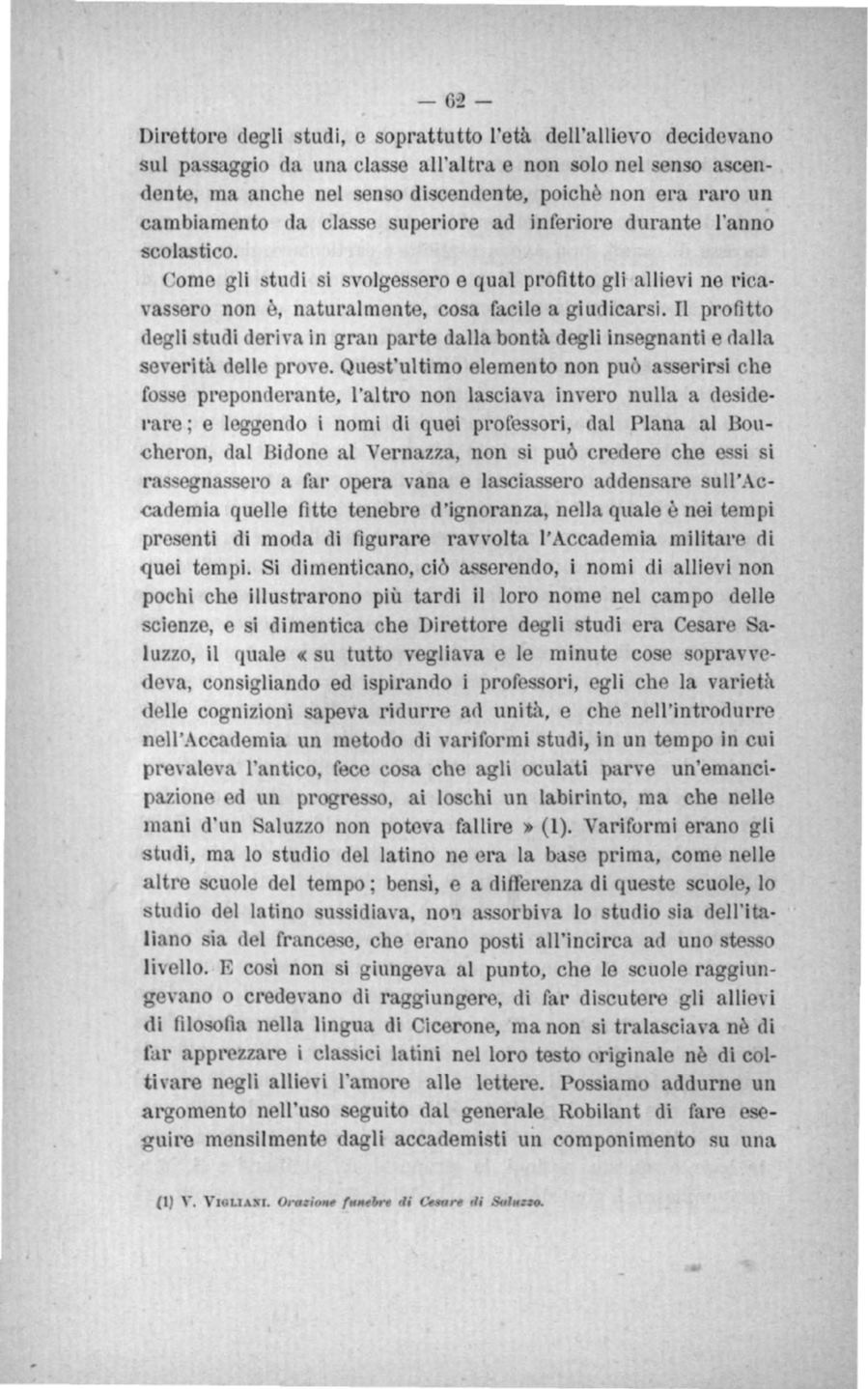
- 02 -
Direttor e degli st udi, e soprat tu tto l'età dell'allievo decidevano
s ul passaggio da una classe a ll'a l tra e non solo nel senso ascen–
den te, ma a nche nel senso disc end ente, poich è non e ra raro un
cambiamento da classe supe r iore ad inferi ore du rante l'anno
sco lastico.
Come gli st ud i si svolgessero e qu al profitto gli alli evi ne r ìca–
vassero non è, natura lmente, cosa facile a giudica rs i. Il pr ofit to
degli studi deriva in gra n par te dall a bontà degli insegn anti e dall a
severità
delle prove. Quest' ult imo elemen to non può a
se i-lrs l
che
fos 'e preponrlerante, l'alt ro non lasciav a invero nulla a deside–
rare ; e leggendo
i
nomi di qu ei pr ofessori, dal Plana al Bou–
cheron, dal Bidone al Vernazza , non si può credere che essi si
rassecnassero a far opera vana e lasciassero adden a re sull'Ac –
cademia quelle fitte te nebre d 'ign oranza, ne lla qu ale
è
nei temp i
prese nti di moda di figurare i-avvolta l'Accad emia mìlltare di
q uei temp i. Si dim enti can o, ciò asserend o, i nomi di alli evi non
pochi che illus trarono più tardi
il
loro nome nel campo delle
scienze, e si diment ica che Dir et tore decli studi era Cesare Sa–
luzzo, il quale
«
su tutto vegli ava e le minu te cose sopravve–
deva, consigliando ed ispirando i pro fessor i, eg li che la variet à
de lle cog nizioni sa peva ridurre ad uni tà, e che nell 'introdurre
nell'Accademia un metodo di
vm-ìforml
stud i, in un te mpo in cui
prevaleva l'antico, fece cosa che agli ocu lati parve un'eman ci–
pazione ed un prog res
so,
a i loschi un labir into, ma che nelle
mani d' un aluzzo non poteva fallire » (1). Variformi erano gli
studi, ma lo st ud io del la tin o ne era la ba-e pr ima, come nelle
altre sc uole del te mpo; bensì, e a differenza di ques te scuole, lo
stud io del latino sus
ìdlava,
non assorb iva lo stud io sia dell 'l ta–
liano sia del francese, che e ra no post i a ll' incirca ad uno stes o
livello. E così non si giungeva al punto, ch e le sc uole raggìun –
gevano o credevano di raggi un gere, di fai' discutere gli alli evi
di fllosofla nella lingua di Cicerone, ma non si tralasc iava n è di
far apprezzare i cla ' ici latini nel loro te to or lgl na le n è di col–
tirare neeli all ievi l'amore alle
lettere,
Poss iamo add urne un
a rgomento nell 'n o seg uito da l generale Robilan t di fare ese–
g uìre me nsilme nt dag li accadem isti un compon ime nto su una.
Cl)
v,
' "'IOLl AX[.
O,.a:;m,t
r"lf t&re
di fÀ-Sart
ti;
Saluzzo.


















