
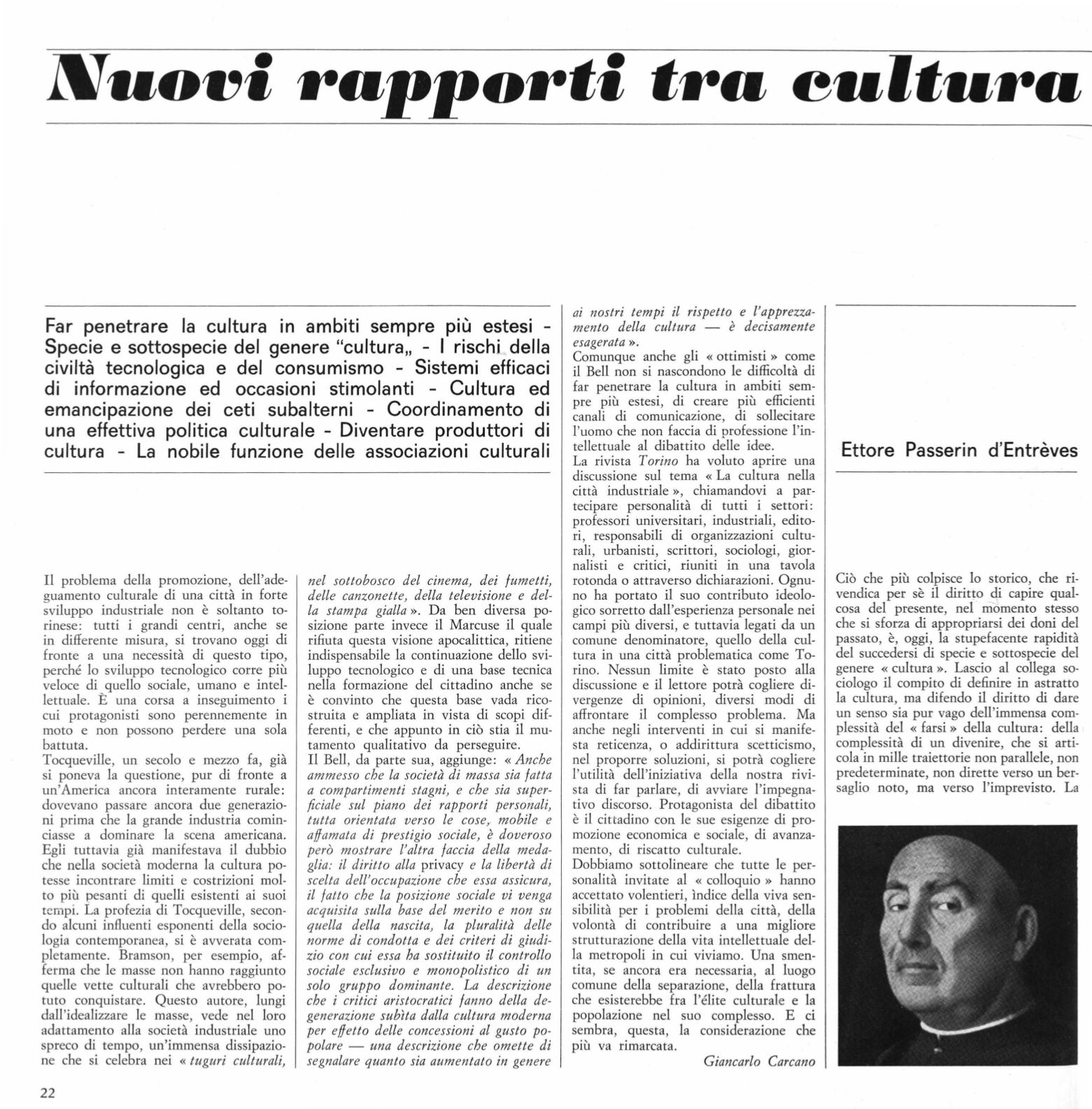
N'uo.,i
rapporti tra
eultura
Far penetrare la cultura in ambiti sempre plU estesi
-
Specie e sottospecie del genere "cultura" - I rischi della
civiltà tecnologica e del consumismo - Sistemi efficaci
di informazione ed occasioni stimolanti - Cultura ed
emancipazione dei ceti subalterni - Coordinamento di
una effettiva politica culturale - Diventare produttori di
cultura - La nobile funzione delle associazioni culturali
Il problema della promozione, dell'ade–
guamento culturale di una città in forte
sviluppo industriale non è soltanto to–
rinese: tutti i grandi centri, anche se
in differente misura, si trovano oggi di
fronte a una necessità di questo tipo,
perché lo sviluppo tecnologico corre più
veloce di quello sociale, umano e intel–
lettuale.
È
una corsa a inseguimento i
cui protagonisti sono perennemente in
moto e non possono perdere una sola
battuta.
Tocqueville, un secolo e mezzo fa, già
si poneva la questione, pur di fronte a
un'America ancora interamente rurale:
dovevano passare ancora due generazio–
ni prima che la grande industria comin–
ciasse a dominare la scena americana.
Egli tuttavia già manifestava il dubbio
che nella società moderna la cultura po–
tesse incontrare limiti e costrizioni mol–
to più pesanti di quelli esistenti ai suoi
tempi. La profezia di Tocqueville, secon–
do alcuni influenti esponenti della socio–
logia contemporanea, si è avverata com–
pletamente. Bramson, per esempio, af–
ferma che le masse non hanno raggiunto
quelle vette culturali che avrebbero po–
tuto conquistare. Questo autore, lungi
dall'idealizzare le masse, vede nel loro
adattamento alla società industriale uno
spreco di tempo, un'immensa dissipazio–
ne che si celebra nei
«tuguri culturali,
22
nel sottobosco del cinema, dei fumetti,
delle canzonette, della televisione e del–
la stampa gialla
». Da ben diversa po–
sizione parte invece il Marcuse il quale
rifiuta questa visione apocalittica, ritiene
indispensabile la continuazione dello svi–
luppo tecnologico e di una base tecnica
nella formazione del cittadino anche se
è convinto che questa base vada rico–
struita e ampliata in vista di scopi dif–
ferenti, e che appunto in ciò stia il mu–
tamento qualitativo da perseguire.
Il Bell, da parte sua, aggiunge:
«Anche
ammesso che la società di massa sia fatta
a compartimenti stagni, e che sia super–
ficiale sul piano dei rapporti personali,
tutta orientata verso le cose,. mobile e
affamata di prestigio sociale,
è
doveroso
però mostrare l'altra faccia della meda–
glia: il diritto alla
privacy
e la libertà di
scelta dell'occupazione che essa assicura,
il fatto che la posizione sociale vi venga
acquisita sulla base del merito e non su
quella della nascita, la pluralità delle
norme di condotta e dei criteri di giudi–
zio con cui essa ha sostituito il controllo
sociale esclusivo e monopolistico di un
solo gruppo dominante. La descrizione
che i critici aristocratici fanno della de–
generazione subìta dalla cultura moderna
per effetto delle concessioni al gusto po–
polare
-
una descrizione che omette di
segnalare quanto sia aumentato in genere
ai nostri tempi il rispetto e l'apprezza–
mento della cultura
-
è
decisamente
esagerata
».
Comunque anche gli «ottimisti» come
il BelI non si nascondono le difficoltà di
far penetrare la cultura in ambiti sem–
pre più estesi, di creare più efficienti
canali di comunicazione, di sollecitare
l'uomo che non faccia di professione l'in–
tellettuale al dibattito
d~l1e
idee.
La rivista
T orino
ha voluto aprire una
discussione sul tema «La cultura nella
città indus triale », chiamandovi a par–
tecipare personalità di tutti i settori:
professori universitari, industriali, edito–
ri, responsabili di organizzazioni cultu–
rali, urbanisti, scrittori, sociologi, gior–
nalisti e critici, riuniti in una tavola
rotonda o attraverso dichiarazioni. Ognu–
no ha portato il suo contributo ideolo–
gico sorretto dall'esperienza personale nei
campi più diversi , e tuttavia legati da un
comune denominatore, quello della cul–
tura in una città problematica come To–
rino. Nessun limite è stato posto alla
discussione e il lettore potrà cogliere di–
vergenze di opinioni, diversi modi di
affrontare il complesso problema. Ma
anche negli interventi in cui si manife–
sta reticenza, o addirittura scetticismo,
nel proporre soluzioni, si potrà cogliere
l'utilità dell'iniziativa della nostra rivi–
sta di far parlare, di avviare l'impegna–
tivo discorso. Protagonista del dibattito
è il cittadino con le sue esigenze di pro–
mozione economica e sociale, di avanza–
mento, di riscatto culturale.
Dobbiamo sottolineare che tutte le per–
sonalità invitate al «colloquio» hanno
accettato volentieri, ìndice della viva sen–
sibilità per i problemi della città, della
volontà di contribuire a una migliore
strutturazione della vita intellettuale del–
la metropoli in cui viviamo. Una smen–
tita, se ancora era necessaria, al luogo
comune della separazione, della frattura
che esisterebbe fra l'élite culturale e la
popolazione nel suo complesso. E ci
sembra, questa, la considerazione che
più va rimarcata.
Giancarlo Carcano
Ettore Passerin d'Entrèves
Ciò che più colpisce lo storico, che ri–
vendica per sè il diritto di capire qual–
cosa del presente, nel momento stesso
che si sforza di appropriarsi dei doni del
passato, è, oggi, la stupefacente rapidità
del succedersi di specie e sottospecie del
genere «cultura ». Lascio al collega so–
ciologo il compito di definire in astratto
la cultura, ma difendo il diritto di dare
un senso sia pur vago dell'immensa com–
plessità del « farsi» della cultura: della
complessità di un divenire, che si arti–
cola in mille traiettorie non parallele, non
predeterminate, non dirette verso un ber–
saglio noto, ma verso l'imprevisto. La


















