
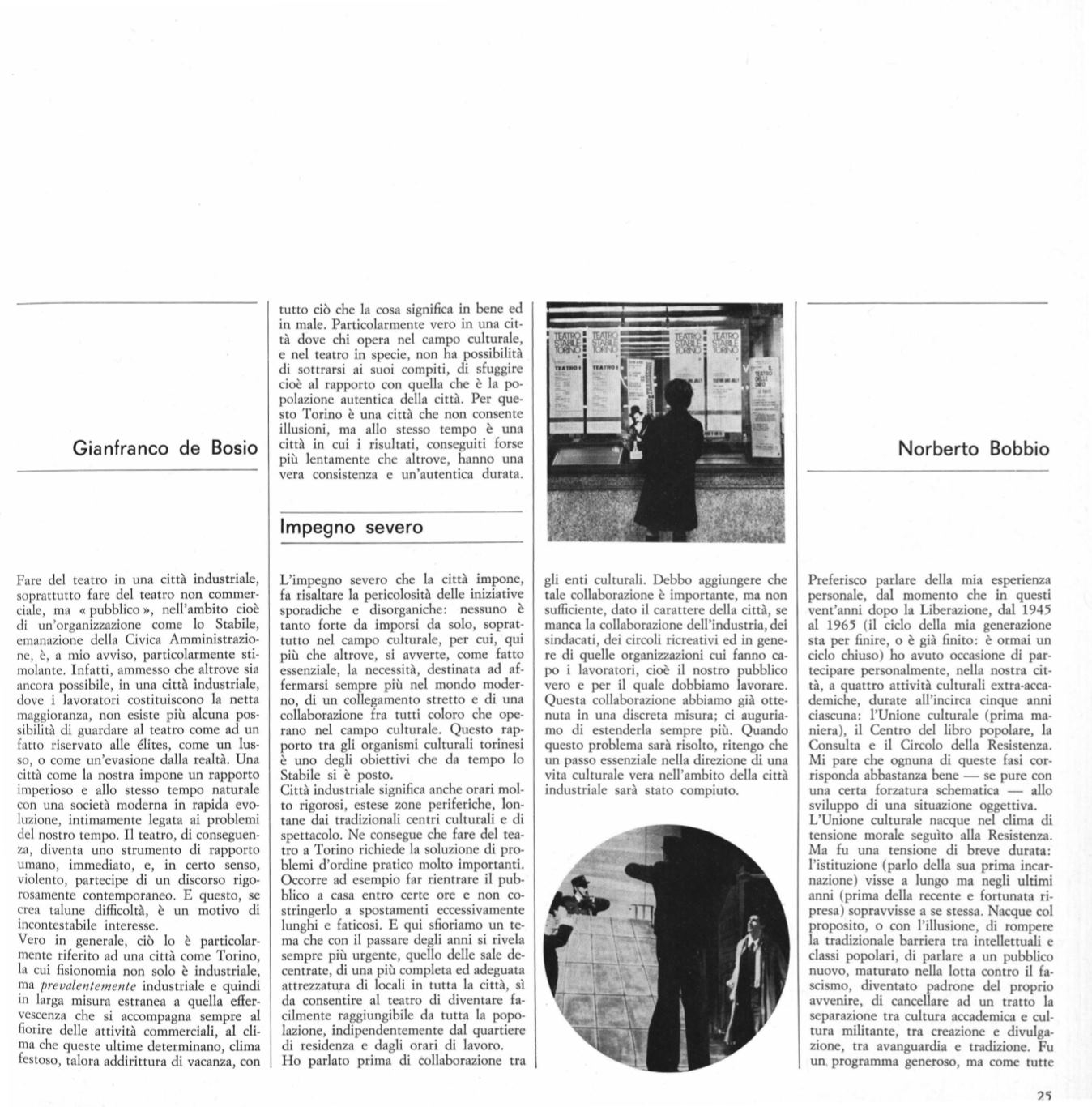
Gianfranco de Bosio
Fare del teatro in una città industriale,
soprattutto fare del teatro non commer–
ciale, ma «pubblico
»,
nell'ambito cioè
di un'organizzazione come lo Stabile,
emanazione della Civica Amministrazio–
ne, è, a mio avviso, particolarmente sti–
molante. Infatti, ammesso che altrove sia
ancora possibile, in una città industriale,
dove i lavoratori costituiscono la netta
maggioranza, non esiste più alcuna pos–
sibilità di guardare al teatro come ad un
fatto riservato alle élites, come un lus–
so, o come un'evasione dalla realtà. Una
città come la nostra impone un rapporto
imperioso e allo stesso tempo naturale
con una società moderna in rapida evo–
luzione, intimamente legata ai problemi
del nostro tempo. Il teatro, di conseguen–
za, diventa uno strumento di rapporto
umano, immediato, e, in certo senso,
violento, partecipe di un discorso rigo–
rosamente contemporaneo. E questo, se
crea talune difficoltà, è un motivo di
incontestabile interesse.
Vero in generale, ciò lo è particolar–
mente riferito ad una città come Torino,
la cui fisionomia non solo è industriale,
ma
prevalentemente
industriale e quindi
in larga misura estranea a quella effer–
vescenza che si accompagna sempre al
fiorire delle attività commerciali, al cli–
ma che queste ultime determinano, clima
festoso, talora addirittura di vacanza, con
tutto ciò che la cosa significa in bene ed
in male. Particolarmente vero in una cit–
tà dove chi opera nel campo culturale,
e nel teatro in specie, non ha possibilità
di sottrarsi ai suoi compiti, di sfuggire
cioè al rapporto con quella che è la po–
polazione autentica della città. Per que–
sto Torino è una città che non consente
illusioni, ma allo stesso tempo è una
città in cui i risultati, conseguiti forse
più lentamente che altrove, hanno una
vera consistenza e un'autentica durata.
Impegno severo
L'impegno severo che la città impone,
fa risaltare la pericolosità delle iniziative
sporadiche e disorganiche: nessuno è
tanto forte da imporsi da solo, soprat–
tutto nel campo culturale, per cui, qui
più che altrove, si avverte, come fatto
essenziale, la necessità, destinata ad af–
fermarsi sempre più nel mondo moder–
no, di un collegamento stretto e di una
collaborazione fra tutti coloro che ope–
rano nel campo culturale. Questo rap–
porto tra gli organismi culturali torinesi
è uno degli obiettivi che da tempo lo
Stabile si è posto.
Città industriale significa anche orari mol–
to rigorosi, estese zone periferiche, lon–
tane dai tradizionali centri culturali e di
spettacolo. Ne consegue che fare del tea–
tro a Torino richiede la soluzione di pro–
blemi d'ordine pratico molto importanti.
Occorre ad esempio far rientrare
il
pub–
blico a casa entro certe ore e non co–
stringerlo a spostamenti eccessivamente
lunghi e faticosi. E qui sfioriamo un te–
ma che con
il
passare degli anni si rivela
sempre più urgente, quello delle sale de–
centrate, di una più completa ed adeguata
attrezzatu,ra di locali in tutta la città, si
da consentire al teatro di diventare fa–
cilmente raggiungibile da tutta la popo–
lazione, indipendentemente dal quartiere
di residenza e dagli orari di lavoro.
Ho parlato prima di collaborazione tra
gli enti culturali. Debbo aggiungere che
tale collaborazione è importante, ma non
sufficiente, dato il carattere della città, se
manca la collaborazione dell'industria, dei
sindacati, dei circoli ricreativi ed in gene–
re di quelle organizzazioni cui fanno ca–
po i lavoratori, cioè il nostro pubblico
vero e per il quale dobbiamo lavorare.
Questa collaborazione abbiamo già otte–
nuta in una discreta misura; ci auguria–
mo di estenderla sempre più. Quando
questo problema sarà risolto, ritengo che
un passo essenziale nella direzione di una
vita culturale vera nell'ambito della città
industriale sarà stato compiuto.
Norberto Bobbio
Preferisco parlare della mia esperienza
personale, dal momento che in questi
vent'anni dopo la Liberazione, dal 1945
al 1965 (il ciclo della mia generazione
sta per finire, o è già finito: è ormai un
ciclo chiuso) ho avuto occasione di par–
tecipare personalmente, nella nostra cit–
tà, a quattro attività culturali extra-acca–
demiche, durate all'incirca cinque anni
ciascuna: l'Unione culturale (prima ma–
niera), il Centro del libro popolare, la
Consulta e il Circolo della Resistenza.
Mi pare che ognuna di queste fasi cor–
risponda abbastanza bene - se pure con
una certa forzatura schematica - allo
sviluppo di una situazione oggettiva.
L'Unione culturale nacque nel clima di
tensione morale seguìto alla Resistenza.
Ma fu una tensione di breve durata :
l'istituzione (parlo della sua prima incar–
nazione) visse a lungo ma negli ultimi
anni (prima della recente e fortunata ri–
presa) sopravvisse a se stessa. Nacque col
proposito, o con l'illusione, di rompere
la tradizionale barriera tra intellettuali e
classi popolari, di parlare a un pubblico
nuovo, maturato nella lotta contro il fa–
scismo, diventato padrone del proprio
avvenire, di cancellare ad un tratto la
separazione tra cultura accademica e cul–
tura militante, tra creazione e divulga–
zione, tra avanguardia e tradizione. Fu
un. programma gene.roso, ma come tutte


















