
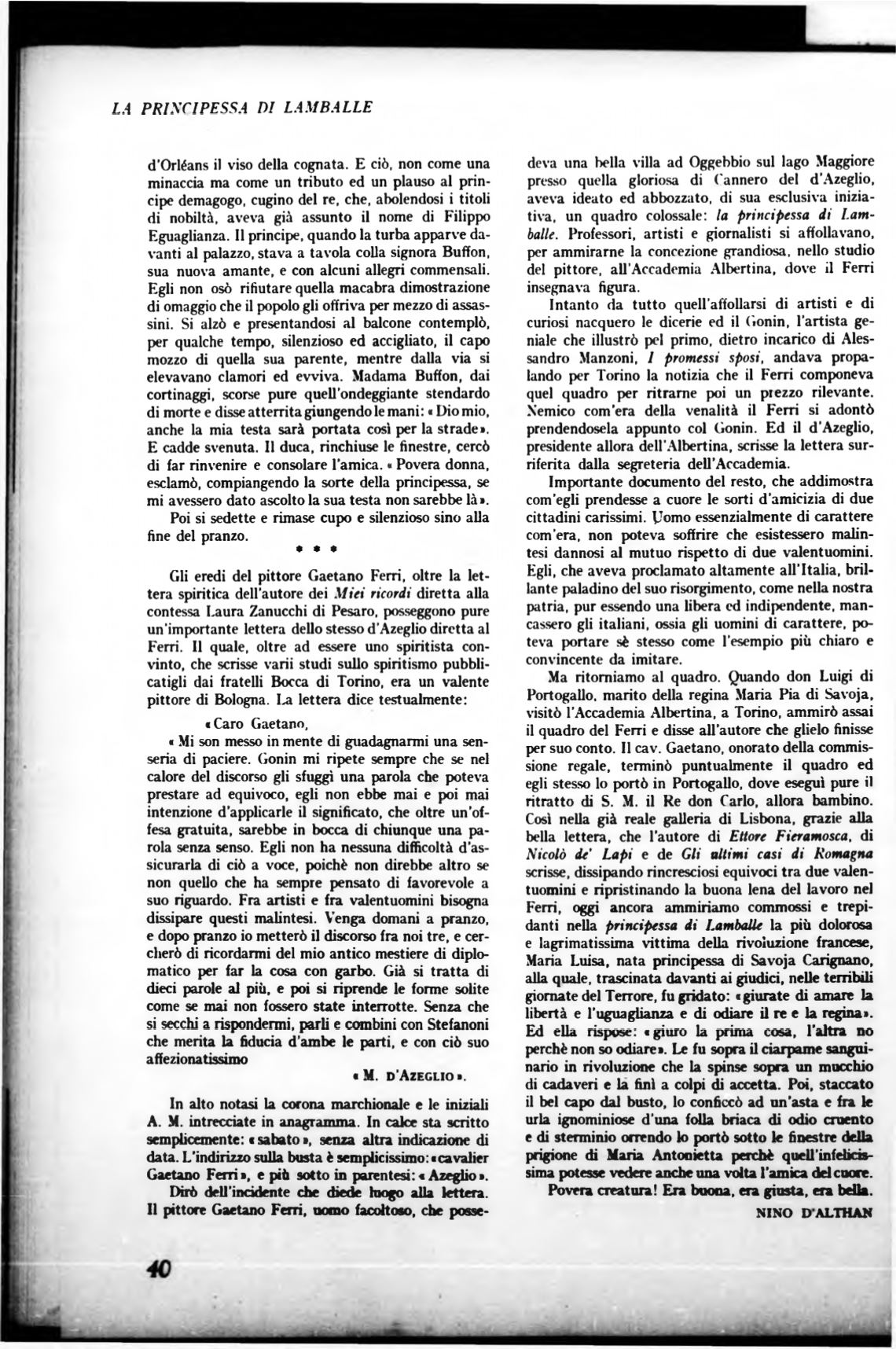
L A P R IN C I P E S S A D I L A M B A L L E
d ’Orléans il viso della cognata. E ciò, non come una
minaccia ma come un tributo ed un plauso al prin
cipe demagogo, cugino del re, che, abolendosi i titoli
di nobiltà, aveva già assunto il nome di Filippo
Eguaglianza. Il principe, quando la turba apparve da
vanti al palazzo, stava a tavola colla signora Buffon,
sua nuova amante, e con alcuni allegri commensali.
Egli non osò rifiutare quella macabra dimostrazione
di omaggio che il popolo gli offriva per mezzo di assas
sini. Si alzò e presentandosi al balcone contemplò,
per qualche tempo, silenzioso ed accigliato, il capo
mozzo di quella sua parente, mentre dalla via si
elevavano clamori ed evviva. Madama Buffon, dai
cortinaggi, scorse pure quell'ondeggiante stendardo
di morte e disse atterrita giungendo le mani: «Dio mio,
anche la mia testa sarà portata così per la strade».
E cadde svenuta.
11
duca, rinchiuse le finestre, cercò
di far rinvenire e consolare l’amica. «Povera donna,
esclamò, compiangendo la sorte della principessa, se
mi avessero dato ascolto la sua testa non sarebbe là».
Poi si sedette e rimase cupo e silenzioso sino alla
fine del pranzo.
* * *
Gli eredi del pittore Gaetano Ferri, oltre la let
tera spiritica dell’autore dei
Miei ricordi
diretta alla
contessa Laura Zanucchi di Pesaro, posseggono pure
un'importante lettera dello stesso d’Azeglio diretta al
Ferri. Il quale, oltre ad essere uno spiritista con
vinto, che scrisse varii studi sullo spiritismo pubbli
catigli dai fratelli Bocca di Torino, era un valente
pittore di Bologna. I.a lettera dice testualmente:
«Caro Gaetano,
«Mi son messo in mente di guadagnarmi una sen
seria di paciere. Gonin mi ripete sempre che se nel
calore del discorso gli sfuggì una parola che poteva
prestare ad equivoco, egli non ebbe mai e poi mai
intenzione d’applicarle il significato, che oltre un’of
fesa gratuita, sarebbe in bocca di chiunque una pa
rola senza senso. Egli non ha nessuna difficoltà d’as-
sicurarla di ciò a voce, poiché non direbbe altro se
non quello che ha sempre pensato di favorevole a
suo riguardo. Fra artisti e fra valentuomini bisogna
dissipare questi malintesi. Venga domani a pranzo,
e dopo pranzo io metterò il discorso fra noi tre, e cer
cherò di ricordarmi del mio antico mestiere di diplo
matico per far la cosa con garbo. Già si tratta di
dieci parole al più, e poi si riprende le forme solite
come se mai non fossero state interrotte. Senza che
si secchi a rispondermi, parli e combini con Stefanoni
che merita la fiducia d’ambe le parti, e con ciò suo
affezionatissimo
«M.
d
'A
zeg l io
».
In alto notasi la corona marchionale e le iniziali
A. M. intrecciate in anagramma. In calce sta scritto
semplicemente: «sabato», senza altra indicazione di
data. L ’indirizzo sulla busta è semplicissimo: «cavalier
Gaetano Ferri », e più sotto in parentesi: «Azeglio ».
Dirò dell’incidente che diede luogo alla lettera.
Il pittore Gaetano Ferri, uomo facoltoso, che posse
deva una bella villa ad Oggebbio sul lago Maggiore
presso quella gloriosa di ('annero del d ’Azeglio,
aveva ideato ed abbozzato, di sua esclusiva inizia
tiva, un quadro colossale:
la principessa di Lam-
balle.
Professori, artisti e giornalisti si affollavano,
per ammirarne la concezione grandiosa, nello studio
del pittore, aU’Accademia Albertina, dove il Ferri
insegnava figura.
Intanto da tutto quell'affollarsi di artisti e di
curiosi nacquero le dicerie ed il Gonin, l’artista ge
niale che illustrò pel primo, dietro incarico di Ales
sandro Manzoni,
1
promessi sposi,
andava propa
lando per Torino la notizia che il Ferri componeva
quel quadro per ritrame poi un piezzo rilevante.
Nemico com’era della venalità il Ferri si adontò
prendendosela appunto col Gonin. Ed il d ’Azeglio,
presidente allora dell'Albertina, scrisse la lettera sur
riferita dalla segreteria deU’Accademia.
Importante documento del resto, che addimostra
com’egli prendesse a cuore le sorti d ’amicizia di due
cittadini carissimi. Uomo essenzialmente di carattere
com’era, non poteva soffrire che esistessero malin
tesi dannosi al mutuo rispetto di due valentuomini.
Egli, che aveva proclamato altamente all'Italia, bril
lante paladino del suo risorgimento, come nella nostra
patria, pur essendo una libera ed indipendente, man
cassero gli italiani, ossia gli uomini di carattere, po
teva portare sè stesso come l’esempio più chiaro e
convincente da imitare.
Ma ritorniamo al quadro. Quando don Luigi di
Portogallo, marito della regina Maria Pia di Savoja,
visitò l’Accademia Albertina, a Torino, ammirò assai
il quadro del Ferri e disse all'autore che glielo finisse
per suo conto. Il cav. Gaetano, onorato della commis
sione regale, terminò puntualmente il quadro ed
egli stesso lo portò in Portogallo, dove eseguì pure il
ritratto di S. M. il Re don Carlo, allora bambino.
Così nella già reale galleria di Lisbona, grazie alla
bella lettera, che l’autore di
Ettore Fieramosca,
di
Nicolò de’ Lupi
e de
Gli ultimi casi di Romagna
scrisse, dissipando rincrescasi equivoci tra due valen
tuomini e ripristinando la buona lena del lavoro nel
Ferri, oggi ancora ammiriamo commossi e trepi
danti nella
principessa di Lamballe
la più dolorosa
e lagrimatissima vittima della rivoluzione francese,
Maria Luisa, nata principessa di Savoja Carignano,
alla quale, trascinata davanti ai giudici, nelle terribili
giornate del Terrore, fu gridato: «giurate di amare la
libertà e l’uguaglianza e di odiare il re e la regina».
Ed ella rispose: «giuro la prima cosa, l ’altra no
perchè non so odiare». Le fu sopra il ciarpame sangui
nario in rivoluzione che la spinse sopra un mucchio
di cadaveri e la finì a colpi di accetta. Poi, staccato
il bel capo dal busto, lo conficcò ad un’asta e fra le
urla ignominiose d ’una folla briaca di odio cruento
e di sterminio orrendo lo portò sotto le finestre della
prigione di Maria Antonietta perchè quell’infelicis-
sima potesse vedere anche una volta l ’amica del cuore.
Povera creatura! Era buona, era giusta, era bella.
NINO
DALTHAN


















