
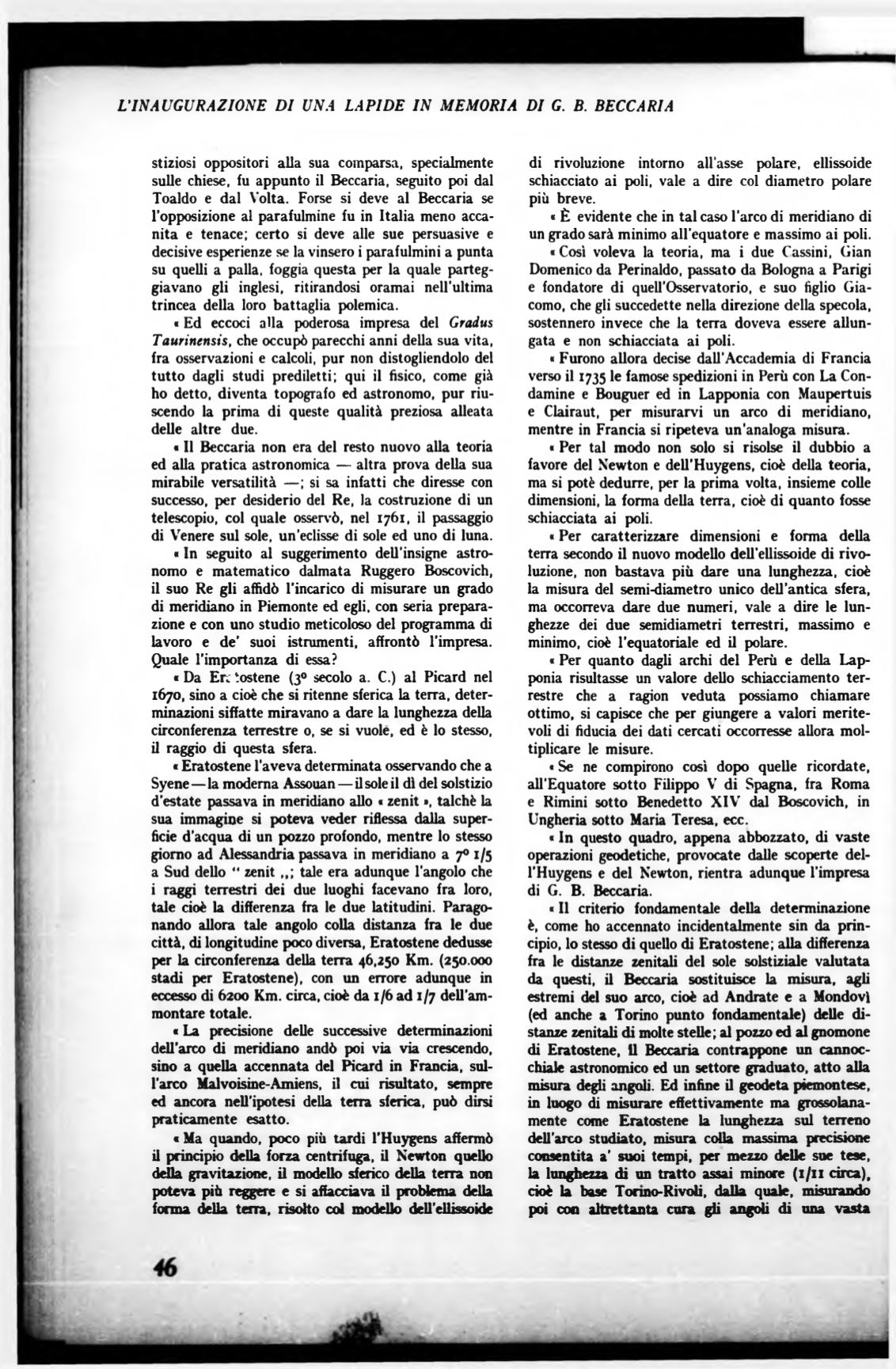
L 'I N A U G U R A Z I O N E D I U N A L A P I D E I N M E M O R I A D I G. B . B E C C A R I A
stiziosi oppositori alla sua comparsa, specialmente
sulle chiese, fu appunto il Beccaria, seguito poi dal
Toaldo e dal Volta. Forse si deve al Beccaria se
l’opposizione al parafulmine fu in Italia meno acca
nita e tenace; certo si deve alle sue persuasive e
decisive esperienze se la vinsero i parafulmini a punta
su quelli a palla, foggia questa per la quale parteg
giavano gli inglesi, ritirandosi oramai nell’ultima
trincea della loro battaglia polemica.
«Ed eccoci alla poderosa impresa del
Gradus
Taurinensis,
che occupò parecchi anni della sua vita,
fra osservazioni e calcoli, pur non distogliendolo del
tutto dagli studi prediletti; qui il fisico, come già
ho detto, diventa topografo ed astronomo, pur riu
scendo la prima di queste qualità preziosa alleata
delle altre due.
« Il Beccaria non era del resto nuovo alla teoria
ed alla pratica astronomica — altra prova della sua
mirabile versatilità — ; si sa infatti che diresse con
successo, per desiderio del Re, la costruzione di un
telescopio, col quale osservò, nel 1761, il passaggio
di Venere sul sole, un’eclisse di sole ed uno di luna.
«In seguito al suggerimento dell’insigne astro
nomo e matematico dalmata Ruggero Boscovich,
il suo Re gli affidò l ’incarico di misurare un grado
di meridiano in Piemonte ed egli, con seria prepara
zione e con uno studio meticoloso del programma di
lavoro e de’ suoi istrumenti, affrontò l’impresa.
Quale l’importanza di essa?
«Da Ere tostene (30 secolo a. C.) al Picard nel
1670, sino a cioè che si ritenne sferica la terra, deter
minazioni siffatte miravano a dare la lunghezza della
circonferenza terrestre 0, se si vuole, ed è lo stesso,
il raggio di questa sfera.
«Eratostene l’aveva determinata osservando che a
Syene— la moderna Assouan— il sole il dì del solstizio
d’estate passava in meridiano allo «zenit », talché la
sua immagine si poteva veder riflessa dalla super
ficie d’acqua di un pozzo profondo, mentre lo stesso
giorno ad Alessandria passava in meridiano a 7*1/5
a Sud dello “ zenit ,,; tale era adunque l’angolo che
i raggi terrestri dei due luoghi facevano fra loro,
tale cioè la differenza fra le due latitudini. Parago
nando allora tale angolo colla distanza fra le due
città, di longitudine poco diversa, Eratostene dedusse
per la circonferenza della terra 46,250 Km. (250.000
stadi per Eratostene), con un errore adunque in
eccesso di 6200 Km. circa, cioè da 1/6 ad 1/7 dell’am
montare totale.
«La precisione delle successive determinazioni
dell’arco di meridiano andò poi via via crescendo,
sino a quella accennata del Picard in Francia, sul
l’arco Malvoisine-Amiens, il cui risultato, sempre
ed ancora nell’ipotesi della terra sferica, può dirsi
praticamente esatto.
«Ma quando, poco più tardi l’Huygens affermò
il principio della forza centrifuga, il Newton quello
della gravitazione, il modello sferico della terra non
poteva più reggere e si affacciava il problema della
forma della terra, risolto col modello dell’ellissoide
di rivoluzione intorno all’asse polare, ellissoide
schiacciato ai poli, vale a dire col diametro polare
più breve.
«È evidente che in tal caso l ’arco di meridiano di
un grado sarà minimo all’equatore e massimo ai poli.
«Così voleva la teoria, ma i due Cassini, Gian
Domenico da Perinaldo, passato da Bologna a Parigi
e fondatore di quell’Osservatorio, e suo figlio Gia
como, che gli succedette nella direzione della specola,
sostennero invece che la terra doveva essere allun
gata e non schiacciata ai poli.
«Furono allora decise dall’Accademia di Francia
verso il 1735 le famose spedizioni in Perù con La Con
damine e Bouguer ed in Lapponia con Maupertuis
e Clairaut, per misurarvi un arco di meridiano,
mentre in Francia si ripeteva un’analoga misura.
«Per tal modo non solo si risolse il dubbio a
favore del Newton e dell’Huygens, cioè della teoria,
ma si potè dedurre, per la prima volta, insieme colle
dimensioni, la forma della terra, cioè di quanto fosse
schiacciata ai poli.
«Per caratterizzare dimensioni e forma della
terra secondo il nuovo modello dell'ellissoide di rivo
luzione, non bastava più dare una lunghezza, cioè
la misura del semi-diametro unico dell’antica sfera,
ma occorreva dare due numeri, vale a dire le lun
ghezze dei due semidiametri terrestri, massimo e
minimo, cioè l ’equatoriale ed il polare.
«Per quanto dagli archi del Perù e della Lap
ponia risultasse un valore dello schiacciamento ter
restre che a ragion veduta possiamo chiamare
ottimo, si capisce che per giungere a valori merite
voli di fiducia dei dati cercati occorresse allora mol
tiplicare le misure.
«Se ne compirono così dopo quelle ricordate,
all’Equatore sotto Filippo V di Spagna, fra Roma
e Rimini sotto Benedetto XIV dal Boscovich, in
Ungheria sotto Maria Teresa, ecc.
«In questo quadro, appena abbozzato, di vaste
operazioni geodetiche, provocate dalle scoperte del-
l’Huygens e del Newton, rientra adunque l’impresa
di G. B. Beccaria.
«Il criterio fondamentale della determinazione
è, come ho accennato incidentalmente sin da prin
cipio, lo stesso di quello di Eratostene; alla differenza
fra le distanze zenitali del sole solstiziale valutata
da questi, il Beccaria sostituisce la misura, agli
estremi del suo arco, cioè ad Andrate e a Mondovì
(ed anche a Torino punto fondamentale) delle di
stanze zenitali di molte stelle; al pozzo ed al gnomone
di Eratostene, il Beccaria contrappone un cannoc
chiale astronomico ed un settore graduato, atto alla
misura degli angoli. Ed infine il geodeta piemontese,
in luogo di misurare effettivamente ma grossolana
mente come Eratostene la lunghezza sul terreno
dell’arco studiato, misura colla massima precisione
consentita a’ suoi tempi, per mezzo delle sue tese,
la lunghezza di un tratto assai minore (1/11 circa),
cioè la base Tonno-Rivoli, dalla quale, misurando
poi con altrettanta cura gli angoli di una vasta


















