
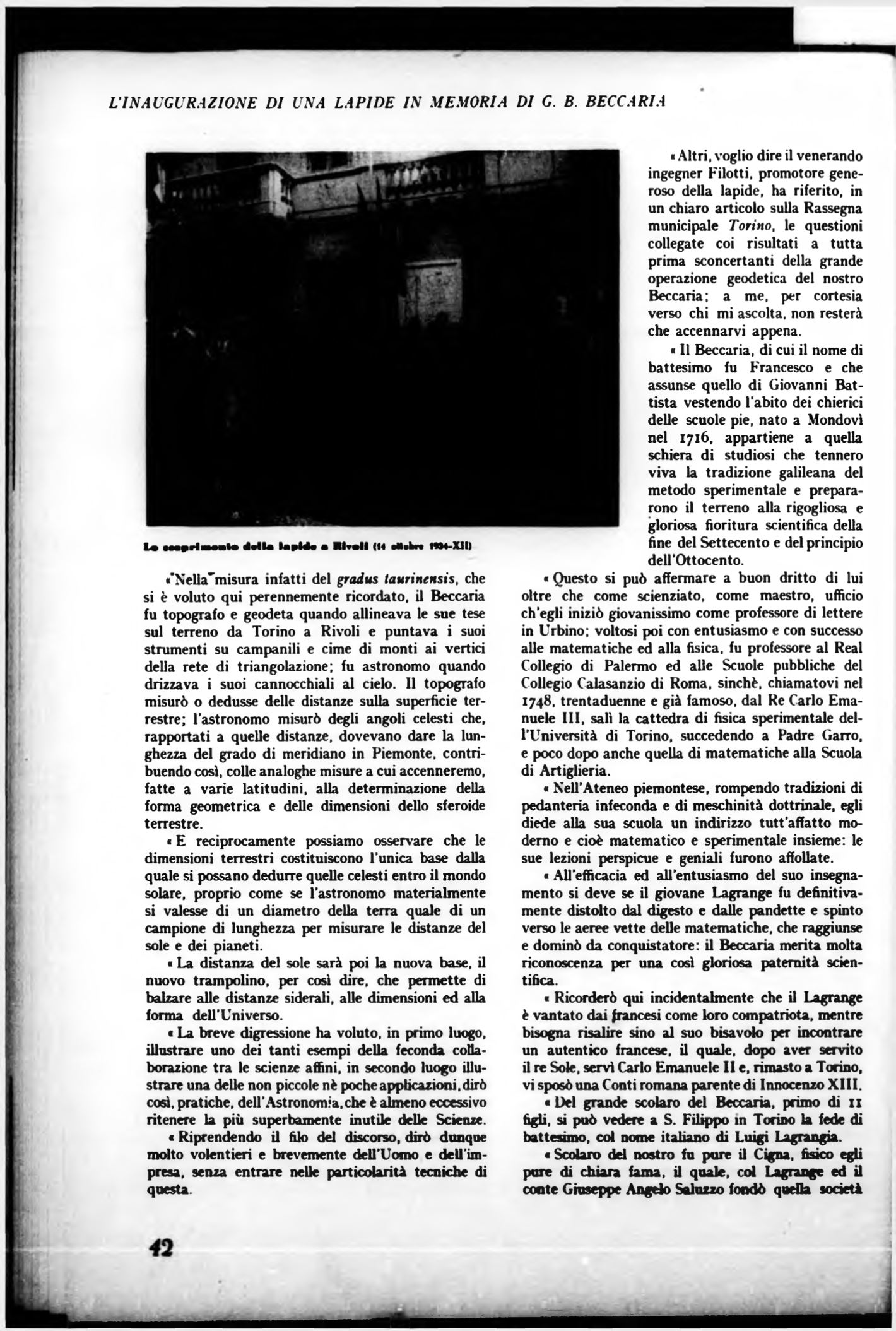
L 'I N A U G U R A Z I O N E D I U N A L A P I D E I N M E M O R I A D I G. B . B E C C A R I A
L a i w p r i — t o d a lla la p id a a V iv a li (14 oMoh t 1194-X II)
«’NeUa"'misura infatti del
gradus taurinensis,
che
si è voluto qui perennemente ricordato, il Beccaria
fu topografo e geodeta quando allineava le sue tese
sul terreno da Torino a Rivoli e puntava i suoi
strumenti su campanili e cime di monti ai vertici
della rete di triangolazione; fu astronomo quando
drizzava i suoi cannocchiali al cielo. Il topografo
misurò o dedusse delle distanze sulla superficie ter
restre; l ’astronomo misurò degli angoli celesti che,
rapportati a quelle distanze, dovevano dare la lun
ghezza del grado di meridiano in Piemonte, contri
buendo così, colle analoghe misure a cui accenneremo,
fatte a varie latitudini, alla determinazione della
forma geometrica e delle dimensioni dello sferoide
terrestre.
«E reciprocamente possiamo osservare che le
dimensioni terrestri costituiscono l ’unica base dalla
quale si possano dedurre quelle celesti entro il mondo
solare, proprio come se l'astronomo materialmente
si valesse di un diametro della terra quale di un
campione di lunghezza per misurare le distanze del
sole e dei pianeti.
«La distanza del sole sarà poi la nuova base, il
nuovo trampolino, per così dire, che permette di
balzare alle distanze siderali, alle dimensioni ed alla
forma delTUniverso.
«La breve digressione ha voluto, in primo luogo,
illustrare uno dei tanti esempi della feconda colla
borazione tra le scienze affini, in secondo luogo illu
strare una delle non piccole nè poche applicazioni, dirò
così, pratiche, dell’Astronomia,che è almeno eccessivo
ritenere la più superbamente inutile delle Scienze.
«Riprendendo il filo del discorso, dirò dunque
molto volentieri e brevemente dell’Uomo e dell’im
presa, senza entrare nelle particolarità tecniche di
questa.
«Altri, voglio dire il venerando
ingegner Filotti, promotore gene
roso della lapide, ha riferito, in
un chiaro articolo sulla Rassegna
municipale
Torino,
le questioni
collegate coi risultati a tutta
prima sconcertanti della grande
operazione geodetica del nostro
Beccaria; a me, per cortesia
verso chi mi ascolta, non resterà
che accennarvi appena.
«Il Beccaria, di cui il nome di
battesimo fu Francesco e che
assunse quello di Giovanni Bat
tista vestendo l ’abito dei chierici
delle scuole pie, nato a Mondovì
nel 1716, appartiene a quella
schiera di studiosi che tennero
viva la tradizione galileana del
metodo sperimentale e prepara
rono il terreno alla rigogliosa e
gloriosa fioritura scientifica della
fine del Settecento e del principio
dell’Ottocento.
«Questo si può affermare a buon dritto di lui
oltre che come scienziato, come maestro, ufficio
ch’egli iniziò giovanissimo come professore di lettere
in Urbino; voltosi poi con entusiasmo e con successo
alle matematiche ed alla fisica, fu professore al Reai
Collegio di Palermo ed alle Scuole pubbliche del
Collegio Calasanzio di Roma, sinché, chiamatovi nel
1748, trentaduenne e già famoso, dal Re Carlo Ema
nuele HI, salì la cattedra di fìsica sperimentale del-
l’Università di Torino, succedendo a Padre Garro,
e poco dopo anche quella di matematiche alla Scuola
di Artiglieria.
«Nell’Ateneo piemontese, rompendo tradizioni di
pedanteria infeconda e di meschinità dottrinale, egli
diede alla sua scuola un indirizzo tutt’affatto mo
derno e cioè matematico e sperimentale insieme: le
sue lezioni perspicue e geniali furono affollate.
•
All’efficacia ed all’entusiasmo del suo insegna
mento si deve se il giovane Lagrange fu definitiva
mente distolto dal digesto e dalle pandette e spinto
verso le aeree vette delle matematiche, che raggiunse
e dominò da conquistatore: il Beccaria merita molta
riconoscenza per una così gloriosa paternità scien
tifica.
«Ricorderò qui incidentalmente che il Lagrange
è vantato dai francesi come loro compatriota, mentre
bisogna risalire sino al suo bisavolo per incontrare
un autentico francese, il quale, dopo aver servito
il re Sole, servì Carlo Emanuele II e, rimasto a Torino,
vi sposò una Conti romana parente di Innocenzo XIII.
«Del grande scolaro del Beccaria, primo di n
figli, si può vedere a S. Filippo in Torino la fede di
battesimo, col nome italiano di Luigi Lagrangia.
«Scolaro del nostro fu pure il Cigna, fisico egli
pure di chiara fama, il quale, col Lagrange ed il
conte Giuseppe Angelo Saluzzo fondò quella società


















